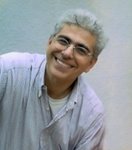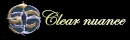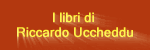giovedì 22 settembre 2011
Le mie fallite storie d’amore con le bibliotecarie
Alt! Voglio rassicurare mia moglie: da quando ci siamo conosciuti non ho mai avuto storie d’amore con le bibliotecarie (né con altre donne appartenenti a qualsivoglia tipologia lavorativa).
Bene, chi mi segua attraverso questo blog o attraverso i miei libri avrò almeno intuito che mi piace leggere. Sì, posso immaginare la vostra meraviglia!
Ma a proposito del mio amore per la lettura vorrei raccontarvi un aneddoto.
Di solito si chiede alle persone famose di raccontare un aneddoto; io non sono una persona famosa né ho mai conosciuto persone di quel genere, ma ve ne racconto uno lo stesso.
Be’, una volta ho parlato col romanziere Massimo Carlotto e di recente (ad un convegno su Gramsci) con Giulio Angioni, mio vecchio prof di antropologia culturale ed anch’egli romanziere; di lui vi consiglio… caldamente Le fiamme di Toledo, Sellerio, Palermo, 2007.
Non posso però dire di d’aver conosciuto quegli scrittori.
Bene, una volta in una biblioteca dell’hinterland cagliaritano in cui presentai uno dei miei libri, dissi ad una bibliotecaria: “A me piace scrivere ma anche leggere.”
La bibliowoman scoppiò a ridere! Strano, in effetti la gente rideva più che altro quando (al liceo) venivo interrogato in fisica ed in matematica.
Ora che vi sarete asciugati le lacrime per l’involontaria battuta che scatenò l’ilarità delle bibliofemme, andiamo avanti.
Un alcolizzato frequenta le bettole ed i bar, un atleta le palestre, un killer le armerie. Uno che ama i libri frequenta le librerie e le biblioteche. Ma questo lo sapete; del resto, lo so perfino io!
Bene, non so perché ma di rado io e le bibliofrauen andiamo d’accordo. Ho analizzato il problema a fondo, ma invano.
Che io compili male le richieste o le schede per il prestito? Mah, qualche volta sarò anche impreciso: ma questo non giustifica certi atteggiamenti gelidi, quasi sprezzanti.
Del resto, in queste cose raramente sono impreciso.
Una cosa che potrebbe però giustificare l’atteggiamento di qualche bibliomujer è questa: bazzico molte biblioteche, perciò chissà, forse a volte mi confondo circa alcune modalità di prestito e di restituzione. E' una possibilità, no?
Quando poi si compila appunto quella richiesta bisogna indicare esattamente la collocazione ed anche il numero di inventario, oltre a nome dell’A., titolo dell’opera, anno e luogo di pubblicazione ecc. e soprattutto ecc.
Ieri presso la Biblioteca Centro documentazione e studi sulle donne di Cagliari ho preso, della scrittrice austriaca (poi trasferitasi nell’ex-Germania Est) Maxie Wander Una vita preziosa, che in quella biblio ha come collocazione 836.914 wan e come n° di inv. 1672.
Oltre alle Fiamme di Angioni vi consiglio anche questo gran libro della Wander, che è una straordinaria raccolta di lettere e riflessioni sul tema soprattutto della malattia e della sua morte imminente, oltre che sull’amore, sull’arte, sulla giustizia.. eppure in tutto questo Maxie non assume mai un tono da prima della classe, né tragico o lamentoso.
In quella biblioteca non ho subito nessun atteggiamento glaciale; sì, quando ho iniziato a sfogliare una rivista di storia medievale, la bibliomulier ha detto con un tono da capufficio stile Gianni Agus: “Dopo lo rimetta a posto, eh?!”, al che io sono stato (temo) un po’ fracchiesco. Ma in effetti, aveva ragione lei.
Poi, una volta ritirato il libro della cara Maxie, la Lady of the books mi ha stupito con una grande finezza… mi ha augurato: “Buona lettura!” Non si trattava di parole di circostanza e le ho gradite moltissimo; perché un libro, regalato o prestato è un dono, è qualcosa che sia chi lo presta che chi lo legge spera possa essere gustato e condiviso. Come diceva Stendhal (e Nietzsche era d’accordo) “l’arte è una promessa di felicità.”
Quando tantissimi anni fa ero ko perché non trovavo del materiale per la mia tesi di laurea, una bibliozena della biblio di Sestu mi tolse parecchie castagne dal fuoco.
La professionalità di una bibliogirl del Centro di studi americani di Roma si rivelò più che fondamentale per la bibliografia della tesi in questione.
A Cagliari, una bibliomuchaca molto gentile della biblio universitaria mi è preziosissima per il reperimento di riviste e periodici rari.
Sempre in Casteddu (Cagliari) una Madame des livres della biblio provinciale si fece in 4 per trovarmi un articolo in cui si esaminava l’interesse che ebbe per Salgari Antonio Gramsci; il tutto con grande affabilità.
Una bibliofimmina della biblio regionale, oberata di lavoro ed assediata dai richiedenti mi ha detto dove trovare le opere di Aristotele: si trovavano all’ultimo piano di uno scaffale molto alto e mi ha pregato di prenderle da me, ma non ha assolutamente voluto che le portassi la scala.
Insomma, se ripenso a quelle che ho scherzosamente chiamato fallite storie d’amore, devo riconoscere che gli antichi equivoci contano quanto uno zero sfondato.
Senza le bibliofilles la vita in biblioteca sarebbe muy triste, perciò w le bibliotecarie. E non scherzo!
giovedì 8 settembre 2011
Sulle montagne del Perù
Era una sera di marzo, Pablo Sanchez ed i suoi compagni Incas marciavano ormai da settimane. Nell’inerpicarsi su per le montagne l’aria si faceva sempre più rarefatta, ma la vegetazione rimaneva lussureggiante. Come aveva detto una volta il suo maestro, fray Bartolomè de Las Casas, le terre del Nuovo mondo erano “il Paradiso o poco meno.”
“Un Paradiso”, aveva commentato in lingua quechua un Inca, “che voi spagnoli state trasformando in un Inferno.”
Era vero: un’infinità di indios furono (e lo erano ancora!) sottomessi, derubati e sottoposti a violenze sessuali, fisiche e psicologiche d’ogni tipo, quindi sterminati in massa… i loro villaggi rasi al suolo o dati alle fiamme, i pochi superstiti ridotti in schiavitù e come diceva fray Bartolomè nella sua Breve storia della distruzione delle Indie, i loro bimbi venivano dati in pasto ai cani: ancora vivi o dopo esser stati fatti a pezzi dalle lame spagnole.
Avendo finalmente gli indios messicani impugnato le armi, el fray ben definì la loro reazione “santa”; infatti, la Chiesa non sosteneva la legittimità della guerra di difesa? E quella non era una guerra ma peggio, l’immotivato sterminio di un popolo.
Lui, Pablo, già capitano di fanteria e prossimo alla vita religiosa, era tornato in Spagna e col suo maestro aveva seguito le dispute filosofico-teologiche in cui magister Bartolomè aveva difeso i diritti degli indios, affermato la loro appartenenza al genere umano e per il Sangue del Cristo, la redenzione anche di quelle miti genti.
Pablo ricordava che furibondo aveva così argomentato col fray: “Ma come, come sottrarre a quelle ottime e sventurate persone terre e beni che appartengono loro da sempre? Con quale mai motivazione giuridica? Lo stesso atto del Requerimiento, che vien letto loro nella nostra lingua (che essi non conoscono affatto) impone di cedere qualsiasi cosa noi desideriamo, pena il massacro!”
“Infatti”, rispondeva Las Casas, “qui il diritto è il grande assente.”
“Va bene, ma chi può credere che gli indios non siano umani? Essi costruiscono abitazioni, strade, templi, parlano una lingua, creano dell’arte, si associano in famiglie, stringono amicizia, vivono in Stati, tengono assemblee, lavorano i campi, vari materiali ecc. Insomma, qualsiasi filosofo dai tempi almeno di Aristotele (se non da quelli di Socrate e di Platone) direbbe che ciò conferisce loro le caratteristiche di animal rationale, socialis et politicus!”
“Ma qui non c’entrano neanche la filosofia o la teologia. Certo, Dio ha creato il mondo e tutte le genti che lo abitano e ha creato anche i popoli delle Indie, che sono anch’essi umani. E poiché dal Cristo sono stati redenti tutti gli uomini ed anche gli indios sono uomini, allora sono stati redenti anche loro. Ma di fronte alla prospettiva dell’oro e del poter schiavizzare ogni uomo ed ogni donna, pochissimi vogliono onorare le ragioni di diritto, filosofia e teologia.”
“Allora”, concluse Pablo, “bisogna fare come Cortès e Pizarro: impugnare la croce al rovescio, a mo’ di spada… ma contro loro ed i loro amici.”
El fray sospirò e forse quel sospiro equivalse ad una benedizione.
“Pablo”, che cosa pensi?”, disse il capo Inca. Lui glielo disse e l’altro: “Las Casas è un nostro grande, grande fratello.”
“Già. E se non l’avessi mai incontrato, forse avrei partecipato anch’io a quei massacri.”
“No, un cuore generoso come il tuo si sarebbe rifiutato anche se certo, ci sono uomini che sono per noi come dei padri e le cui parole ci germogliano dentro dando frutti meravigliosi… rendendoci delle persone migliori.”
“Questo è verissimo, capo.”
“Ora ascoltami: stamattina ho avuto una visione, ho visto tanta gente. Parlava lingue forse non ancora nate, comunque subivano violenze ed inganni d’ogni tipo, a volte i loro oppressori non usavano le armi ma i testi sacri, i codici delle leggi, i versi dei grandi poeti e le sentenze dei filosofi più profondi, ricorrevano ai labirinti dei numeri e del calcolo. Ho visto i nostri fratelli del Messico che combattevano contro Cortès e quelli di un paese chiamato Frankenhausen… esiste un paese che si chiama così?”
“Sì, si trova in Germania, nel Vecchio mondo”, disse Pablo. “Là anni fa i contadini combatterono contro i nobili, ma furono sconfitti.”
“Ho capito. Ma ho visto anche i loro nipoti e gente dai vestiti e dai capelli strani, viaggiavano su carri di ferro con ruote di gomma. Ho visto i figli dei figli dei loro nipoti e dei nostri, anch’essi in lotta contro altri spagnoli… che forse si chiameranno diversamente. Vinceranno prima gli uni poi gli altri e così via daccapo, sarà duro distinguere tra le vittorie di chi considera l’altro uomo un cabròn, un caprone o un cane oppure uno schiavo e quelle di chi lo considera un fratello. Capisci ancora la mia lingua o passo al castigliano?”
“Continua pure col quechua. Ma alla fine chi vincerà?”
“Chissà. Comunque, tra qualche anno chi potrà sapere se tutti noi siamo mai esistiti? Ma finchè un uomo vorrà trattare il suo simile come un verme, bisognerà impedirglielo perché chi si comporta così è fatto non ad immagine di Dio ma del Diavolo… come dice anche el fray.”
Pochi minuti dopo un tiro incrociato di frecce, sassi e pallottole falciò una trentina di conquistadores.
Il tempo di raccogliere le armi dei loro nemici e Pablo e gli Incas si rimisero subito in marcia.
lunedì 15 agosto 2011
Per i bloggers e le bloggers che lasciano
A volte mi capita (penso che non capiti solo a me) di vedere che compagne/i di web decidano di chiudere il blog.
Al massimo lo lasciano in rete ma non ci scrivono più… allora le loro sono come delle bottiglie di parole che vagano nel mare dello spazio, del tempo e delle idee in cui alcuni di noi continuano ad aggirarsi con la tastiera.
E’ una decisione che rispetto, come in generale cerco di rispettare tutte quelle civili.
Eppure sapete, mi dispiace sempre, soprattutto quando si parla di persone con le quali scorgevo una certa affinità e simpatia sul piano umano.
Talvolta ho scritto ad alcune/i di loro chiedendo (spero senza risultare fastidioso o invadente) di continuare, se potevano, a scrivere. A volte mi è stato risposto, altre no. Pienamente legittimo: forse quell’affinità non era così… affine o più semplicemente, chi ha deciso di ritirarsi preferiva dare davvero un taglio netto.
Tutto questo mi porta ad interrogarmi sui motivi che possono condurre una persona a voler evitare uno scambio come quello bloggistico, senza (repetita iuvant) però per questo pretendere di sindacare scelte altrui.
Bene, il motivo più grave può essere dato dalla salute, propria o di chi vive con noi.
Un altro può essere il tempo, di cui non si può disporre come si vorrebbe quando ci si trovi sotto la pressione del lavoro, dei doveri legati alla famiglia, da passioni diverse da quelle della scrittura sul web ecc.
Del resto, chi ha problemi di salute può averne anche di tempo, poiché deve utilizzare quello che ha per curare sé o per occuparsi di amici o parenti che appunto, non stanno bene.
Talvolta c’è chi scrive su fb e così dà l’addio al blog; o lavora a libri, articoli di giornale, riviste e così via.
Altro motivo può esser dato dalla pura e semplice noia o dalla mancanza di voglia; ogni tanto nella vita è bello cambiare ed in questo non c’è niente di male.
Perciò, ripeto: abbandonare il blog è una decisione, una scelta senz’altro legittima.
L’unica cosa che mi sentirei ma sommessamente di dire è che spiace vedere che chi non scrive più sul suo blog, spesso tronchi la comunicazione anche con persone con le quali non c’è mai stata neanche una lite.
Ma forse, se qualcuno si è allontanato in modo così drastico, qualcosa devo pur aver fatto… benché involontariamente.
Comunque spero sempre che chi ha lasciato torni, perché le cose che scriveva mi hanno fatto sorridere, riflettere ed in alcuni casi hanno anche ispirato quelle 4 scemenze che scrivo.
Quanto a me, temo proprio che continuerò ad infliggervi le scemenze di cui sopra perché io scrivo sempre, anche quando non pubblico e spesso anche quando dormo.
Scusate, mi pare che in cucina sia entrato qualcuno… ah, ma è I.I., il mio Interlocutore Immaginario! “Come stai I.I., tutto bene?”
“Sì. Senti, ma ‘sto post deve durare ancora molto? Guarda che se continui così poi ti metti a parlare di te e vai fuori tema.”
“E perché mai? Ho anch’io un blog quindi è giusto che parli anche di me.”
“Sarà… ma che bisogno c’era di dire che scrivi in cucina?”
“Questo l’hai appena detto tu.”
“Sì, ma io sono te. Insomma, noi siamo la stessa persona, possibile che non lo capisca? Come ha detto uno dei tuoi personaggi, per essere una persona intelligente sei molto stupido.”
“Non mi sono mai definito intelligente.”
“Va bene, lasciamo perdere. Senti, per ferragosto vai fuori?”
“Di testa?”
“Fa un po’ meno lo spiritoso e riservami un posto in auto ed a tavola, perché io a ferragosto me la spasso alla grande.”
“Allora rimani a casa: non ho nessuna intenzione di fare una figuraccia.”
“Va bene, va bene, scherzavo… Ma posso darti un suggerimento? Il prossimo post, scrivilo sul cardinal Danielou. E’ solo un suggerimento, beninteso.”
“Danielou era una persona straordinaria ma non accetto suggerimenti da te, anche se sei me. Però l’idea è buona. Ed ora saluta tutti.”
“Bene. Signore e signori, io e Riccardo vi salutiamo ed auguriamo un ottimo ferragosto, all’insegna dell’amore, dell’amicizia, del fantasmagorico rock-blues, del buon vino, degli stupendi malloreddus (gnocchetti sardi), del sole, del mare, dei laghi, delle montagne o eventualmente, all’insegna dei ruscelli. Cogliamo inoltre l’occasione per invitare i/le bloggers che avessero intenzione di ritornare sui loro passi, a farlo. Stateci bene o possibilmente, meglio. Ciao!”
(“Sono stato bravo, Riccardo?”)
(”Sì, I.I., bravissimo.”)
(“Non è che sono sembrato retorico, oppure troppo rigido, noiosamente filosofico o magari lunghetto?”)
(”No, stai tranquillo, hai fatto un grande discorso. Adesso però vai a metterti il costume.”).
martedì 2 agosto 2011
Le nuvole sopra Bologna
I binari corrono e scorrono,
si allungano sulle colline
si arrampicano sulle montagne…
una volta, ricordo… e ricordare è importante!,
si usava uno strano termine
(o che strano sembra ai giovani):
strada ferrata.
Gli alberi guardano i treni,
voi non ci crederete
(ma i miei nipotini ci credevano)
eppure quando un treno corre bene e sorride sincero,
gli alberi corrono con loro…
ma in amicizia.
Orribile esser stato assassinato,
anche se ero già così vecchio!
Prendere il treno e correre con lui, brava gente,
è come suonare il blues:
ma un blues allegro!
Quando prendevo il treno sentivo Langhston Hughes,
Langhston che cantava del Freedom train…
il treno della libertà
che è reale solo se possono salirci tutti.
Altrimenti, aggiungevo ed aggiungo io,
è solo una presa in giro!
Vedevo Langhston
che faceva correre la sua penna
come io facevo correre le mie dita
sulla chitarra o sulla pelle della mia donna,
sentivo Jimi che cantava The wind cries, Mary
e davvero quel vento urla e piange
come il vento che fischia e la bufera che urla,
oggi come allora.
Non meritavo quella fine, non a 19 anni…
In realtà, non la meritava nessuno.
Una notte intera di nave e poi tante ore di treno,
da Cagliari a Civitavecchia ed infine a Bologna…
triplice o quadruplice provinciale
come diceva l’Antonio dei Quaderni,
io diretto non a Torino ma a Bologna
e non valevo neanche un millesimo di quell’uomo
ma fui stroncato anch’io dalla violenza fascista.
Non troverò più i miei secchielli o la mia palla.
A volte… a volte mi sembra…
sì, mi sembra di vederli ancora andare via,
rubati da un’onda burlona e ladra…
ma l’onda peggiore fu quella piena di fuoco,
quella mattina del 2 agosto.
In certe giornate
le nuvole sopra Bologna
non fanno vedere il sole:
neanche quando in cielo non esiste una nuvola.
In certe giornate
le nuvole sopra Bologna
non promettono grandine, fulmini né pioggia…
in certe giornate quelle nuvole
che “in realtà” non esistono
e che nessun meteorologo saprebbe spiegare,
ebbene, in quelle giornate
si tratta dei pensieri e delle anime dei morti
e dei vivi
che continuano a chiedere una giustizia
che raggiunga anche
chi mandò gli assassini.
giovedì 21 luglio 2011
La “Lauda" di Francesco di Angelo Branduardi
Quanto alle musiche, questo spettacolo si base su quelle dell’album L’infinitamente piccolo in cui Branduardi si è accostato con grande finezza alla figura di S. Francesco.
Ma questa Lauda non è un musical, benché gli elementi diremmo strutturali siano simili: musica, delle parti recitate, scene di danza ecc.
Ma nego l’appartenenza di questo spettacolo al mondo del musical non per attaccare quella forma artistica (che anzi apprezzo1) bensì per almeno cercare d’evidenziare come Branduardi si sia collegato proprio alla Lauda medievale… quella composizione poetica e musicale che se non erro, si sviluppò tra il XIII ed il XIV secolo; composizione di carattere e d’argomento religioso e che in Francesco toccò vette di particolare, notevole dolcezza ed ebbe un certo valore letterario.
E’ peraltro nota l’importanza che le composizioni di Francesco ebbe per lo sviluppo della futura lingua italiana; inoltre, io penso che lo stesso pensiero del Nostro meriterebbe un’analisi filosofica: questo anche volendo estendere il discorso oltre la dimensione religiosa del Poverello.
Ma torniamo allo spettacolo.
Le musiche sono di Branduardi, i testi di Luisa Zappa Branduardi, la regia è stata curata da Oreste Campagna, la coreografia da Alberta Palmisano, la scenografia da Paola Benvenuto. Francesco è stato interpretato da Alberto Salvi; Bernardo da Quintavalle, il primo seguace, è stato interpretato da Walter Tiraboschi, Chiara da Maria Tirelli.
La Lauda ha come voce narrante quella di Branduardi che compare nelle vesti di un trovatore; essi erano così chiamati “perché trovavano rime, accompagnandole col liuto.”2
Egli segue le vicende di Francesco fino al momento della morte, che chiamò sora nostra cioè nostra sorella. Nota bene: la Lauda inizia con un lungo estratto dall’XI canto del Paradiso di Dante… i versi 43-117, quelli in cui Dante celebra Francesco e che Branduardi ha musicato.
Forse quello è il “pezzo” musicalmente meno trascinante ma: 1) è già un’impresa musicare Dante; 2) comunque il tono scelto dal menestrello si imprime nella memoria: insomma, il brano rimane in testa.
Inoltre, durante tutta la Lauda Branduardi non fa di certo il mattatore, lascia anzi parecchio spazio agli attori ed al balletto. Di lui ci si accorge solo per le parti che si è ritagliato come musicista e come voce narrante.
Poi, quando attacca col suo violino le prime note di ogni pezzo, c’è da esaltarsi! A me, almeno, è successo. Inoltre egli, messo in un’occasione l’archetto da parte, ha suonato il violino con le dita e sembrava che da esso ricavasse degli arpeggi, come se avesse una piccola chitarra. Altro strumento da lui utilizzato, appunto una chitarra dalla forma inusitata: probabile antenata della chitarra moderna.
Molto sobria la recitazione dei protagonisti. Il Francesco interpretato da Salvi è gioioso senza essere troppo estatico e talvolta tormentato da un profondo sentimento di inadeguatezza e di impotenza a cambiare in profondità e permanentemente il cuore degli uomini. Ma anche in questo Salvi mantiene una certa misura.
Benché la spiritualità del Bernardo di Tiraboschi si basi spesso su alcuni (anche forti) sbalzi d’umore, perciò non paia sempre fondata sulla solida roccia che è invece tipica della fede di Francesco o di Chiara, è comunque la figura più simpatica.
Quel Bernardo è probabilmente necessario all’interno dell’universo francescano, che forse è più complesso di quanto non sembri: un universo quindi fatto di serenità ma anche di forti dubbi e di repentine esaltazioni.
Forse la figura di S. Chiara rimane un po’ troppo sullo sfondo ma del resto, lei avrebbe meritato una Lauda a parte. Tuttavia la Chiara della Tirelli risulta molto forte ed anche entusiasta, ma senza mai risultare esaltata.
Il brano che per intensità espressiva mi ha colpito di più è Il lupo di Gubbio.
Applicherei a quel lupo il discorso impostato da Eco nel Nome della rosa quando Guglielmo da Baskerville afferma che Francesco era sconfortato dalla durezza di cuore degli uomini; perciò non avrebbe predicato realmente agli uccelli3: quella sarebbe stata un’allegoria, figura retorica la cui importanza “per l’arte e la letteratura medievale” è stata ben colta da Auerbach.4
Analogamente, forse dovremmo intendere il lupo come un “malvivente” o come un “signorotto feroce, di quelli che frustavano a sangue i servi, strappavano gli occhi ai prigionieri, aizzavano i mastini contro i visitatori importuni, e legavano i nemici per i piedi alla coda di un cavallo in corsa.”5
Ma niente di quanto ho scritto può rendere la metà della bellezza dell’opera branduardiana, perché l’armonia tra l’essenzialità della scenografia (davvero… francescana), la fantasia ed il ritmo di musica e danza, la sobrietà comunque coinvolgente della recitazione ed il sapiente gioco di luci è davvero qualcosa di incantevole…
Note
1) Apprezzo infatti parecchio Jesus Christ superstar che però appartiene ad un universo di spazio, di tempo, di musica (rock-soul!) e di valori moderno. Gli stessi dubbi espressi dal Cristo di J.C. superstar, soprattutto quando dice a Dio nel Getsemani: “Va bene, uccidimi!”, sarebbero stati impensabili nell’ambito dell’ortodossia medievale.
2) Maria Sticco, San Francesco d’Assisi, O.R., Milano, 1994, p.24.
3) Umberto Eco, Il nome della rosa (1980), Bompiani “I Grandi Tascabili”, Milano, 1986, p.205.
4) Erich Auerbach, Studi su Dante, Feltrinelli, Milano, 1990, p.229.
5) M. Sticco, San Francesco d’Assisi, op. cit., p.169.
martedì 21 giugno 2011
La rivista “Coloris de limbas”
E’ uscito da poco il 1° numero della rivista semestrale di letteratura, arti visive, società ed attualità Coloris de Limbas, titolo che può essere tradotto con “Colori di (o delle) lingue"; infatti essa contiene contributi in italiano, sardo, castigliano, inglese e portoghese.
I testi non in lingua italiana sono comunque tradotti appunto nella lingua di Dante e trovo questo approccio multilinguistico davvero interessante: esso permette l’incontro tra uomini e donne che appartengono a culture tra loro anche molto diverse.
Del resto, tale approccio si collega alla storia di una città, Cagliari, che si è sempre trovata “tra” varie civiltà: fenicia, cartaginese, romana, araba, spagnola, pisana, genovese ecc. E considero lingue, sistemi di valori etici, sociali e così via dei ponti tra gli esseri umani.
Entrando nel… vivo della rivista, devo dire che ho trovato davvero valido pressoché ogni “pezzo” (articolo, racconto, poesia o disegno) da me finora visto.
Vari Autori o Autrici hanno toccato temi o atmosfere a me molto vicini: per es. la tragedia dei desaparecidos1 o quella dei migranti e dei minatori di Marcinelle, in Belgio2, laddove in un incidente morirono 262 minatori di varie nazionalità (ma la maggior parte italiani).
Trovo a me molto vicino anche l’articolo, dall’impostazione storico-saggistica di Nicoletta Lampis sul cimitero monumentale di Bonaria, a Cagliari3. Vicino perché anche su di me un luogo come quello ha sempre esercitato un certo fascino e perché visitare un cimitero (benché certo non costituisca un divertimento) non mi turba. Tra quei vialetti penso più del solito ai miei amici ed ai parenti scomparsi e mi sento in pace se non con me stesso, almeno con loro.
E quel che più conta, l’articolo di Nicoletta è animato da un tono di dolente pietas per le sfortunate donne che morirono giovani e nello stesso tempo, è sostenuto da una documentazione seria, rigorosa.
In Coloris troviamo poi un racconto di Alessandro Serra4 che si svolge proprio nel mio vecchio liceo… e prendete alla lettera il riferimento alla vecchiaia: quando il sottoscritto frequentava il liceo, aveva come compagno di banco il celebre Noè.
Ma tornando seri, c’è qualcosa di molto inquietante nella storia della passione frustrata della bidella per il professore di storia dell’arte che somigliava a Mastroianni; è una storia che potrebbe succedere e forse succede e comunque, quanti amori sono destinati a rimanere nel limbo della solitudine o sprofondano nell’inferno della follia?
Bene, il trait d’union della rivista, ciò che accomuna i vari “pezzi” consiste in una certa capacità visiva che ricorda quel che diceva Socrate, per il quale “un poeta, per essere veramente tale, deve scrivere per immagini e non per deduzioni logiche.”5
Dirò di più: il poeta non può far altro che uscire fuori di sé; in una sua canzone Van Morrison esorta così il poeta inglese del ‘600 John Donne: “Rave on, John Donne” cioè delira, vaneggia, John Donne.
Del resto uno ben poco incline ai vaneggiamenti come Kant disse: “Nessun Omero o Wieland potrebbe mostrare come si siano prodotte e combinate nella sua testa le sue idee, ricche di fantasia e dense di pensiero, perché non lo sa egli stesso, e non può quindi insegnarlo agli altri.”6
Comunque non è detto che la visività, che può anche essere intesa come visionarietà sia poi lontana dalla realtà: per es. nel pezzo di Annalisa Puddu7 assistiamo all’assopirsi (o alla morte?) del vecchio minatore che descrive i suoi “polmoni” come se fossero “di gesso” o di “carbone”: un riferimento forse questo alle malattie dei minatori o anche al trasformarsi il minatore nell’ambiente in cui ha lavorato e penato per tanto tempo.
Questi versi di Annalisa mi ricordano, ma con una forte dose di amarezza in più un canto indiano in cui un artigiano che sta costruendo un’ascia dice: “Io sono l’ascia,/ io sto fabbricando me stesso./ Noi due siamo una cosa.”8
Tuttavia quel pellerossa esprime gioia per la creazione del suo utensile fino ad identificarsi con esso; il minatore sardo (forse il padre di Annalisa?) manifesta un doloroso stupore nel vedersi diventare i materiali contro i quali ha combattuto per tutta la vita.
Eppure qualcosa consola quest’uomo quando dice: “Reclino la testa, è la mia prima volta. Il viaggio comincia, e sono farfalla.”9 Il riposo del minatore diventa leggero come non è mai stato e ricorda quanto disse nel VI sec. il cinese Lao Tzu sul vecchio che sognava d’essere diventato una farfalla.10
N.b: la rivista intende l’arte oltre che come creazione di opere appunto artistiche, anche come “liberazione dal disagio esistenziale”11 ed in effetti anche da quello sociale. Del resto, il bluesman John Lee Hooker è stato chiamato the healer, il guaritore: a testimonianza di come la musica possa guarire (secondo convinzioni mi(s)tiche e poetiche nel senso più alto del termine) dal dolore.
E già l’Aristotele della Poetica parlava della tragedia e della musica come catarsi, purificazione o cura dalle emozioni spiacevoli.
Nel film di Norman Jewison Hurricane sul pugile Rubin “Hurricane” Carter, ingiustamente condannato per omicidio, Rubin riesce a controllare la sua ira e la sua frustrazione attraverso la lettura e la scrittura; tutto ciò indica a Carter un senso ed una strada ben diversi da quelli che poteva trovare sul ring.12
Bene, mi sono dilungato parecchio ma se leggerete Coloris vedrete che lo meritava!
Note
1) Simonetta Murtas, Nunca màs. Le atrocità della dittatura argentina nelle parole di una giovane sarda, pp.30-32; Gianni Mascia, Plazas de Mayo, pp.33-34, testi di G. Mascia illustrazioni di Ferdinando Sanna, trad. dall’italiano al sardo di Gian Gavino Irde.
2) Eliano Cau, Animas affartadas, pp.55-56. La traduzione proposta dalla rivista rende “Animas affartadas” con “anime tristi.”
3) N. Lampis, Quel primissimo fior della vita. Suggestioni leopardiane nel Cimitero monumentale di Bonaria, pp.47-54.
4) A. Serra, L’amore e l’odio, pp.69-72.
5) Platone, Fedone, Garzanti, Milano, 1980, IV, p.77.
6) I. Kant, Critica del giudizio, Laterza, Roma-Bari, 1982, p.168. Ma Socrate anticipò forse Kant dicendo che “i poeti componevano le loro opere non facendo uso del loro cervello ma per una certa disposizione naturale, per una sorta di ispirazione, come gli indovini e i profeti.” Platone, Apologia di Socrate, Garzanti, Milano, 1980, VII, pp.11-12.
7) A. Puddu, La miniera, pp.57-59.
8) 49 Canti degli indiani d’America, Mondatori, Milano, 1997, p.25.
9) A. Puddu, op. cit., p.59.
10) Purtroppo, non avendo sottomano il testo di Lao Tzu cito a memoria. Ma la canzone di Branduardi Il vecchio e la farfalla, contenuta ne Alla fiera dell’Est mi sembra abbastanza vicina allo spirito del Cinese; cfr. A. Branduardi, Canzoni, a c. di Giampiero Comolli, Latoside editori, Roma, 1979, pp.106-107.
11) Gianni Mascia e Coloris de Limbas, Editoriale, p.1.
12) Su Carter Bob Dylan scrisse la famosa Hurricane, contenuta nel lp del 1975 Desire.
giovedì 12 maggio 2011
Su “Summer of ‘69” (e non solo) di Bryan Adams
Ci sono delle canzoni magari non tanto complesse ma di forte impatto. Se parliamo di rock, a me piace sentire una bella chitarra ritmica, una voce ruvida, un basso ed una batteria essenziali, un sax potente. Non sto dicendo che quello sia o debba essere il rock; sto dicendo che è soprattutto quello il rock che piace a me.
Fine della parentesi (di solito, dopo la decimillesima smetto).
Uno dei brani che per me dovrebbe essere insegnato in un’ipotetica università del rock ‘n roll è Summer of ’69 di Bryan Adams; in quella facoltà io farei al massimo le pulizie, ma pazienza.
L’estate del 1969 inizia con un duro riff di chitarra e racconta la tipica, forse l’eterna storia (sia pure senza troppo estro narrativo) del rock. I got my first real six-string/ bought it at the five-and-dime/1, canta il buon Bryan: avevo la mia prima vera chitarra/ comprata al five-and dime.
Il ragazzo di Summer dice: la suonavo till my fingers bleed, finchè le mie dita sanguinavano. Quando è molto giovane, per l’appassionato di rock quello è una questione di vita o di morte.
Ma: “Jimmy quit and Jody got married”; è anche il momento in cui qualcuno lascia il gruppo, qualcun altro si sposa ecc. Si cresce, come si dice; o si cambia.
Con la fine dell’estate che seemed to last forever, sembrava che dovesse durare per sempre, si vede come niente possa durare per sempre. Comunque, il protagonista afferma: “Those were the best days of my life”, quelli erano i migliori giorni della mia vita.
Del resto: “Standin’ on your mama porch/ you told me you’d wait forever/ oh and when you held my hand/ I knew it was now or never/, seduti sotto il portico di tua madre/ dicevi che mi avresti aspettato per sempre/ e quando stringevi la mia mano/ sapevo che sarebbe stato ora o mai.
Ma ripetiamo: niente dura per sempre, né una rock-band né l’amore, se Adams canta: “And now the times are changin’/ look at everything that’s come and gone/ sometimes when I play that old six-string/ I think about you wonder what went wrong, ora i tempi sono cambiati/ guardo a tutto quel che è venuto ed andato/ a volte quando suono quella vecchia chitarra/ penso a te e mi chiedo che cosa andò storto.
Già, perché all’inizio del brano il protagonista dice che avrebbe dovuto sapere che non sarebbero mai andati far, lontano; comunque che cosa puoi fare quando sei young and restless, giovane ed inquieto?
Stando alla storia raccontata dagli ottimi Jagger e Richards in Street fighting man: “But what can a poor boy do/ except to sing in a rock ‘n roll band/ ‘cause in the sleepy London town/ there’s just no place for street fighting man, ma che cosa può fare un povero ragazzo/ tranne cantare in un gruppo rock/ perché nella sonnolenta Londra/ non c’è proprio posto per un combattente di strada.2
E la città del protagonista di Summer non è Londra, probabilmente è solo una piccola città di provincia; Adams sviluppa il tema nel singolo Rebel, contenuto in Into the fire.
Del resto, come canta zio Bruce in Rosalita: “Now I know your mama, she don’t like me ‘cause I play in a rock/ and roll band”, so che non piaccio a tua madre perché suono in un gruppo rock.3
Comunque, in fondo che cosa cercava il protagonista di Summer? Un po’ di divertimento, l’amore, seguire strade creative e forse, diverse… magari con una chitarra in mano. Forse questo era troppo, o troppo poco… chissà.
In Summer Adams canta: “And if I had a choice/ Ya- I’d always wanna be there, se potessi scegliere/ vorrei essere sempre lì; ancora ”nell’estate” del 1969, insomma.
Il che ci porta a chiederci: ma il rock non sarà un sogno d’eterna giovinezza, qualcosa quindi di impossibile e forse anche di poco sperabile?
L’idea o l’ipotesi è tutt’altro che peregrina, ma io penso che valga solo per chi decida di fermarsi lì; non vale per chi decida d’andare avanti e d’utilizzare il rock come una grande fonte d’energia e d’ispirazione per la propria vita… perfino quando non faccia più attivamente del rock.
Infatti, come scrive Dave Marsh nel suo 2° libro su Springsteen (Glory days) col tempo sembra che quei pochi accordi diventino + importanti di quando avevamo 17-19 anni, benché (questo lo dico io, per quel poco che vale il mio pensiero) ad un livello più complesso e problematico.
Di certo, come ho detto in altri post rifacendomi ancora a Marsh, nella stessa Born to run di Bruce ed in quelle auto lanciate in corsa possiamo trovare del fatalismo, una sorta di condanna a correre… come in una versione moderna del mito di Prometeo… con tanti Prometei, ognuno incatenato in eterno a quelle 4 ruote.
Ma (ecco la complessità tematica di una musica tecnicamente poco raffinata come quella che piace a me) già nel successivo Darkness on the edge of town Bruciuzzo iniziò a parlare anche d’altro.
Alla fine, condivido il parere del grande Dylan quando in Forever young canta: “May you have a strong foundation when the/ winds of changes shift”, possa tu avere una base solida quando soffiano i venti del cambiamento.4
Tornando ad Adams: quella base strong, forte, solida ti permette di fare la tua scelta anche con la giusta dose di dubbio, che però non impedisce appunto la scelta.
Infatti in Rebel Adams conclude: “For a moment he stands undecided/ looking back on the days of his youth/ as two worlds collide in a moment of truth/, per 1 istante rimane indeciso/ guardando indietro ai giorni della sua giovinezza/ come 2 mondi che si scontrano nel momento della verità.
Per un istante, ma poi capiamo che il protagonista di Rebel lascerà la città benché pensi a suo padre ed al padre di suo padre “prima di lui” ed a come lui sia o sia stato “il primo ad andarsene.”
Insomma: un po’ di rimpianto, che è anche un legame col passato rimarrà, perché noi siamo anche il nostro passato… ma non si vivrà in un’eterna estate o in una continua giovinezza.
Del resto, come canta Adams in Summer “non c’è alcun vantaggio nel lamentarsi” “when you got a job to do”, quando hai un lavoro da fare.
Note
1) Non so tradurre l’espressione “five-and-dime”, che comunque dovrebbe corrispondere a qualcosa come un negozio di articoli venduti a basso prezzo.
Comunque, per i testi di Adams cioè Summer of ’69 e Rebel il colpevole delle traduzioni sono solo io.
2) Per la traduzione dei versi di Street fighting man dei Rolling Stones mi sono avvalso del lavoro compiuto da Pani Galeazzi in “Rolling Stones. Volume primo, Arcana editrice, Milano, 1983, pp. 186-187.
3) Dei versi di Rosalita ho proposto la versione che troviamo in Bruce Springsteen, Arcana editrice, a c. di Guido Harari, Milano, 1981, pp.80-81.
4) Per la traduzione dei versi di Forever young cfr. Bob Dylan. Tutte le canzoni (1973-1980), Lato side 41, Milano, 1980, pp. 56-57.
D’eventuali errori, forzature ecc. sono… fucilabile solo io.
sabato 23 aprile 2011
“Nanneddu meu”, di Peppino Mereu
Nella poesia Nanneddu meu Mereu si rivolge al suo grande amico, il dott. Nanni Sulis (Nanneddu significa Giannino, Giovannino ecc.); essa consta di 33 strofe, ognuna composta di 4 versi.
Di Nanneddu esistono varie versioni musicali: una è quella che fu eseguita a suo tempo dai Tazenda del grande e purtroppo scomparso Andrea Parodi; ne esistono comunque molte altre: molto bella anche quella del Coro Su Nugoresu (il nuorese) e quella del Coro di Neoneli, col quale ha collaborato anche Elio delle storie tese.
La 1/a strofa inizia coi versi che concludono il brano: “Nanneddu meu,/ su mundu est gai,/ a sicut erat/ non torrat mai”, Giovannino mio, così va il mondo, com’era un tempo non torna più1.
A quale tempo allude Mereu? Ad uno forse felice o che almeno, fu migliore dell’attuale; un tempo mitico? Chissà.
Intanto, possiamo notare l’ironia del latino sicut erat che a sua volta potrebbe rimandare al “latino da chiesa” di cui parlava Rimbaud nella Stagione all’inferno2.
Non sappiamo se Mereu, che era un autodidatta abbia mai letto Rimbaud e quali siano state, in generale, le sue letture; tuttavia gli si ascrive una “conoscenza del latino e della mitologia classica.”3
Il sicut di Peppinu ricorda il sicut in caelo et in terra (Matteo, 6,10), come in cielo così in terra che segue il fiat voluntas tua del Padre nostro. Ma se in quella preghiera si chiede che sia fatta la volontà del Padre, come vedremo Mereu dice come quella volontà (non certo per colpa del Padre) non si compia.
Quel sicut chiede infatti che ci sia dato il “pane quotidiano” (Mt., 6,11). Ma qual era la situazione che sperimentavano sia Mereu che tanti suoi contemporanei?
“Como sos popolos/ cascant che cane,/ gridende forte:/ Cherimus pane, ora i popoli sbadigliano come cani affamati, gridando a gran voce: vogliamo pane. Ma noi: “Affamati, mangiamo pane di castagne, terra con ghiande.”4
Si verifica così un’evidente ed inquietante regressione sul piano morale ed umano se Mereu aggiunge: “Siamo assetati, alle fontane, lottando per l’acqua, sembriamo rane”5 ed ancora: “Avvocatucci, laureati, a tasche vuote e spiantati nelle campagne mangiano more, come capre magre lungo le siepi.”6
Ripeto: la regressione investe qui la stessa sfera umana e morale, si fa vera e propria involuzione; la fame conduce a negare in sé stessi l’umanità. Del resto, a proposito del pane Gramsci studiava con doloroso stupore l’atteggiamento dei suoi compagni di detenzione ed anche in lui si trova un’analisi del Pater noster e del pane quotidiano.7
La fame, il non potersi procurare il necessario per vivere neanche dopo lunghi e faticosi anni di studio8, la miseria che da fatto economico conduce ad una dimensione animalesca, non-umana, in Mereu sembra evocare un’autentica danse macabre. Una danza macabra ed insieme, folle.
Ma qui, a differenza dei celebri dipinti (tra gli altri) di Bosch, gli invitati al ballo non sono scheletri né figure comunque stregonesche bensì povera gente che cerca solo di sbarcare il lunario. E certo, questa condizione ricorda parecchio quella “generale tensione degli spiriti vitali” di cui parlava Gramsci nella lettera citata.9
Ed il ditirambo di Mereu colpisce con tutta la violenza che è concessa a chi con la sua arte si fa voce di chi, storicamente, non ne ha mai avuto.
Del resto egli: “Figlio di medico proprietario, si ribellò alla famiglia ed alla sua condizione piccolo-borghese” e dopo aver attraversato una profonda crisi esistenziale, diventò “su cantadore malaittu”, che “ripudiato dai ricchi parenti borghesi, viene assunto dalla comunità popolare tonarese a coscienza critica dell’ingiustizia sociale e dell’egoismo di classe.”10
Ancora, in Nanneddu si parla della filossera (Mereu morì nel 1901) e di impostas, tasse che nos distruint/ campos e binzas, ci distruggono i campi e le vigne.
Addirittura: “Terra c’a fangu/ torrat su poveru, la terra trasforma il povero in fango.11 Quella stessa terra che dovrebbe sostenere l’uomo diventa la sua maledizione; anzi, se prima alcuni regredivano allo stadio animale, ora eccoli perdere perfino la dimensione senziente, eccoli inghiottiti dalla materia inanimata.
Il furore del Nostro non risparmia neanche la Chiesa perché: “S’intulzu apostolu/ de su Segnore/ si finghet santu,/ ite impostore!”, l’avvoltoio del Signore si mostra santo, che impostore!12 E mentre Mereu attacca gli sgherri dell’avvoltoio, afferma con amarezza che tutti noi ci combattiamo l’un l’altro “Pro pagas dies/ de vida in terra, per pochi giorni di vita.13
Così non ci uniamo per cambiare alla radice questa situazione e coltiviamo solo la discordia, se non la classica guerra tra poveri,… sì che alla miseria si aggiunge la lacerazione del tessuto umano e sociale.
Tutto ciò perché “Semus in tempus/ de tirannias/ infamidades/ e carestias, viviamo in tempi di tirannia, soprusi e carestia: Mereu aveva infatti una chiara visione dei problemi storico-sociali della Sardegna e forse, non solo di quella.14
Certo, sia in Nanneddu che in altre poesie Mereu ha spesso un tono violento, in apparenza volgare, plebeo. Ma qui bisogna distinguere: il Gramsci del periodo “torinese” opererà appunto una fondamentale distinzione tra essere volgari e plebei.
Per Gramsci è volgare l’esibizione di un buon cuore che non si possiede, il che conduce spesso ad elargire doni tanto sfavillanti quanto inutili, espressione quindi un “filantropismo spagnolesco che irrita, non benefica.”15
E’ plebeo invece chi polemizza anche aspramente ma con finalità etico-sociali e mai per porsi in luce con alcuno, né per “una bassa ragione di risentimento personale.”16 Mereu è plebeo in questo senso: lo stesso che rivendicava per sé Gramsci.
Inoltre Peppino esclama: ”Scellerati, affamati, ladri, creiamo disordine e non si opponga nessuno.”17
Io penso che questo sia solo uno scherzo amaro, fatto per aggiungere nuovi “attori” a quella danza macabra che era iniziata con esseri umani che sbadigliano come cani affamati, mangiano terra con ghiande, uomini mutati in fango, altri assimilabili a capre o a rane e che si aggirano per la campagna… braccati da corvi ed avvoltoi “umani.”
Peraltro, le relazioni parlamentari del tempo, evidentemente non tenute alla presentazione di immagini di una poesia diciamo visionaria, non sono lontanissime dai versi di Mereu.
Risulta infatti da un’inchiesta condotta dal deputato Pais Serra su incarico di Crispi (con decreto ministeriale del 12 dic. 1894) che in vaste aeree della Sardegna si era ormai creato un intreccio davvero perverso comprendente criminalità comune, corruzione ed intrighi spesso orditi da funzionari ed amministratori pubblici, nascita illecita di grandi patrimoni ecc.18
E già tra il 1880 e l’82 l’avv. Salaris parla di chi “ è costretto a vagare di campo in campo in traccia di cardi selvatici, o di altre erbe per sfamare la sua famiglia”19; il viaggiatore francese Gaston Vuillier vede dei contadini che si sfamano con un “pane di ghiande, d’orzo e d’argilla.”20
Così, la ribellione cui Mereu pare inviti i sardi del suo tempo non parrebbe troppo irrazionale. Inoltre, la Sardegna fu spesso terreno di scontro armato tra dominatori prima spagnoli e poi sabaudi da una parte e popolo e nobiltà sarda dall’altra; il che abbracciò (benché con qualche stasi) il periodo compreso tra l’inizio del ‘600 e buona parte dell’’800. 21
Si può così parlare di “autentici corpi di guerriglieri che battono la montagna dopo aver rotto tutti i legami con la società civile.”22
Lo stesso Garibaldi denunciò come già dopo il 1860 un sistema economico-sociale iniquo avesse prodotto “nella parte meridionale della penisola, l’anarchia, il brigantaggio e la miseria”23.
La tesi di Garibaldi sarà riproposta ed ampliata, certo con maggior rigore argomentativo dal Gramsci che nella Questione meridionale parlerà (ma senza assolvere le locali camarille) de: “La borghesia settentrionale” che “ha soggiogato l’Italia meridionale e le isole e le ha ridotte a colonie di sfruttamento.”24
Naturalmente, come diceva Socrate “un poeta, per essere veramente tale, deve scrivere per immagini e non per deduzioni logiche”25; così, Mereu non era tenuto alla formulazione d’analisi di tipo storico, economico-sociale ecc. Eppure dal suo cuore di poeta e di uomo geniale, tormentato e generoso fuoriusciva comunque tutto lo sdegno per uno stato di cose ormai insostenibile… ed egli sapeva individuare e centrare i bersagli giusti.
Quando poi dice a Nanni: “Adiosu, Nanni/ tenedi contu,/ faghe su surdu,/ ettad’a tontu, arrivederci, Nanni, rifletti su questo, fai il sordo e fingi di non capire26, è come se lo invitasse ad indossare una maschera di bonomia. E’ come se dicesse: noi non la beviamo, conosciamo i rapporti di forza, sappiamo chi e dove siano i nemici ma per ora, fingiamo d’essere stupidi.
Questo è un atteggiamento che spesso gruppi e classi subalterne hanno dovuto assumere quando si trovavano nell’impossibilità di cambiare le cose: anche a costo di confermare nei loro dominatori l’idea di un’inferiorità sul piano morale, intellettuale ecc.27
Ma benché Mereu auspichi un radicale cambiamento28, egli non appoggiò mai il banditismo o fenomeni simili. Io penso che non avrebbe considerato, alla Satta, i banditi “belli, feroci e prodi”29 ma anzi, avrebbe condiviso il tagliente giudizio di Dessì.
In ogni caso, per Mereu lo scopo ed il senso dell’esistenza umana consiste nel superamento di tutte quelle ingiustizie e sofferenze che ci opprimono; per lui bisogna essere liberos, rispettados e uguales.30
Ed in questo spirito faccio a tutti voi i miei migliori auguri di buona Pasqua e di buona festa della Liberazione!
Note
1) Peppinu Mereu, Poesias, a c. del collettivo di ricerca « Peppinu Mereu », Sassari, 1978, pp.88 e 93.
2) Arthur Rimbaud, Una stagione all’inferno, Ten, Roma, 1995, p.57.
3) Nota biografica a c. del collettivo di ricerca “P. Mereu”, in P. Mereu, op. cit., p.16; egli inoltre, lesse i libri della “biblioteca paterna”; ibid. Il padre di Mereu era un medico.
4) P. Mereu, op. cit., pp. 88 e 93.
5) Ibid., p.94.
6) Ibid., p.94.
7) A. Gramsci, Lettere dal carcere, a c. di R. Uccheddu, D. Z. Editore, Cagliari, 2008, p.52.
8) Riferimento all’avvocazia, la classe degli avvocati; cfr. P. Mereu, op. cit., p.91.
9) A. Gramsci, op. cit., p. 51.
10) F. Masala, Un poeta, a Tonara, in P. Mereu, op. cit., pp. 10, 13. Senza nulla togliere ai maudits francesi, Masala traduce “cantadore malaittu” con “poeta maledetto.”
11) Ibid., pp. 88, 93.
12) Ibid., pp. 92, 94.
13) Ibid., pp. 92, 94.
14) Cfr. A Genesio Lamberti, in Ibid., p. 69 sgg.
15) A. Gramsci, Sotto la Mole (1916-1920), Einaudi, Torino, 1960, p.20.
16) A. Gramsci, op. cit., pp.38-39.
17) P. Mereu, op. cit., p. 95.
18) Manlio Brigaglia, Storia e miti del banditismo sardo, La biblioteca della Nuova Sardegna, Sassari, 2009, pp. 86-90.
19) M. Brigaglia, op. cit., p. 83. I corsivi sono miei.
20) Ibid., p. 84.
21) Ibid., pp. 47-60.
22) Ibid., p. 49.
23) G. Garibaldi, Clelia: il governo dei preti, a c. di R. Uccheddu, D. Z. Editore, Cagliari, 2008, p. 136.
24) A. Gramsci, La questione meridionale, Editori Riuniti, Roma, 1969, p. 132.
25) Platone, Fedone, Garzanti, Milano, 1980, IV, p. 77.
26) P. Mereu, op. cit., pp. 93, 95.
27) Nel caso dei Neri d’America abbiamo la deliberata autocaricatura che si trovava in spettacoli comico-musicali come la negro-minstrely, vicina nello spirito all’umorismo yiddish, quello ebraico-orientale; su questo cfr. F. Valentini, Sulle strade del blues, Gammalibri, Milano, 1984, pp. 81-85. Vi è poi un legame tra il parlare con “infinite sottigliezze”: F. Valentini, op. cit., p. 103 e le parole del siciliano principe di Salina sullo “spaccare i capelli in quattro”; cfr. Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo, Feltrinelli, Milano, 158/a ed., p.161.
28) Mereu “manifesta idee che si ispirano al nascente movimento socialista”; cfr. Nota biografica, cit., pp. 17-18.
29) G. Dessì, Un pezzo di luna, Edizioni della torre, Cagliari, 1987, p. 86. Per Dessì i banditi “di oggi” sono “volgari ladri di strada, bastardi criminali”; G. Dessì, op. cit., p. 87. Ma con quel “di oggi”, in fondo neanche Dessì sembra del tutto immune dal fascino (?) degli antichi banditi.
30) Nota biografica, cit., p. 18.
sabato 12 febbraio 2011
Per il 2011… per “tutti”, anche per i prossimi!
Sia pure fuori tempo massimo, auguri di felice anno nuovo a tutti quelli che (l’anno scorso) hanno fatto o (questo) faranno qualcosa per chi soffriva o soffre gravi malattie o disoccupazione, amore deluso o tradito, falsi amici e per la perdita di persone care.
Auguri chi è stato o sarà voce di chi non può far arrivare la sua a chi sta molto, anzi troppo in alto…
Auguri a tutti i lavoratori che difendono il loro posto ed i loro diritti, perché senza diritti il lavoro è schiavismo.
Auguri a chi pensa che la pace non possa esistere senza la giustizia, perché come diceva S. Agostino nella Città di Dio, gli Stati senza giustizia sono solo magna latrocinia, grandi associazioni di delinquenti.
Auguri a chi con una penna o una chitarra, una cinepresa, uno scalpello, con le mani, un pennello o la voce ha creato Bellezza senza aprire prima il portafogli.
Auguri a chi pensa che la vita e la libertà non possano esistere senza un pensiero che scavi sempre: infatti, come diceva Socrate a chi aveva già deciso di condannarlo a morte (Platone, Apologia di Socrate): “Una vita senza ricerca non è degna d’esser vissuta.”
Auguri a chi crede che l’allegria ed il gioco siano cose troppo serie e belle per abbassarle a volgari schiamazzi.
Auguri a chi non si prende troppo sul serio ma non per questo fa carta straccia delle sue convinzioni.
Auguri anche a chi non ha mai condiviso questi pensieri ma inizierà a coltivarli.
Ed ora, se permettete, vorrei fare gli auguri anche a me stesso. Lo so, di solito non si fa… ma vi chiedo d’aver pazienza.
Chi segue questo blog sa che talvolta discuto con I.I., il mio interlocutore immaginario; allora pensate che stia parlando con lui e non badatemi…
Quindi… auguri anche a me stesso soprattutto ora che sto imparando ad accettarmi (non a piacermi, sia chiaro!).
Infatti Marco Aurelio avrà anche avuto ragione di dire: “E’ difficile per un uomo sopportare sé stesso”… ma io dico che chi non lo fa, chi non riesce a sopportarsi, poi vive un Infernuccio niente male.
Perciò auguri anche a te, Riccardo!
Grazie!
Chiudo il post dicendo: auguri di vero cuore a tutte, a tutti; non potremo esser sempre bersagliati dalla grandine; parola di scrittore ed armonicista idrofobo.
State bene, stiamo bene… per quanto possibile, ma senza esitazioni.
Al prossimo post... speriamo non a Pasqua!
venerdì 24 dicembre 2010
mercoledì 15 dicembre 2010
Una vigilia di Natale
Anche quella sera Enrico rincasò alle 17: sapeva che entro pochi minuti si sarebbero scatenate le bande.
La strada sotto casa era piena di erbacce, vecchie carcasse d’auto e di animali, ma anni prima lui aveva adocchiato una villetta abbandonata; per lui, equivaleva ad un castello. Ed aveva sempre il caro serramanico.
Il coltello dormiva nella tasca del giubbotto, da cui egli lo svegliò poco prima d’aprire la porta. Enrico, pila in una mano e serramanico nell’altra ispezionò scrupolosamente ogni stanza; non c’era nessuno, come sempre... ma non si poteva mai dire.
3 anni prima c’era stata una donna; già, che fine aveva fatto? Temendo che qualcuno potesse averla rapita aveva battuto quasi tutta la città; era arrivato fino ai quartieri nord ma poi era tornato indietro: senza un’arma da fuoco si sarebbe solo fatto ammazzare. L’amore non valeva la pena.
Aveva sistemato la caldaia e quello andava bene: non potevi andare in giro a cercare lavoro con la schiena ed i polmoni congelati .
In tutto il mondo, in pochi anni la temperatura si era abbassata d’almeno 15 gradi. Per fortuna le zone radioattive erano state quasi tutte bonificate, o come si diceva; naturalmente, il rischio c’era ancora.
Stappò una bottiglia di vino e mentre beveva gli tornò in mente Marta; cercò di controllare una struggente, lancinante nostalgia: che alla fine l’amore valesse la pena?
Pensò: “Mi sembra d’essere un animale.”
Sapeva che in un certo senso era vero: asserragliato in quella vecchia casa, ospite di un mondo che per puro caso non si era disintegrato, lui, isolato, senza amici, senza amore, con poco lavoro, amareggiato e stanco, si sentiva come un vecchio predatore… con in giro tanti rivali più giovani e feroci di lui o forse, solo più pazzi.
Alzatosi in piedi, Enrico chiuse e riaprì il serramanico molte volte mentre al contempo eseguiva vari salti e giravolte. Si sentiva calmo e carico né provava paure di sorta; aveva già bevuto molto ma non era per niente sbronzo.
Sedette con la schiena contro la parete e disse a voce alta: “Sentite, voi che avete abitato questa casa prima di me… non sto qui per mancarvi di rispetto. Non voglio profanare i vostri ricordi. Sento la vostra felicità e davvero, in me non c’è invidia o cattiveria... sono contento che siate stati più felici di quanto ora non sia io.”
Naturalmente non poteva rispondergli nessuno: non dall’altro mondo… ma a lui questo bastò, gli sembrò un’assoluzione.
Finì quel che restava del vino e pensò che un giorno sarebbe stato bello vivere alla luce del sole, tra gente serena e che ti trattava con cordialità e simpatia… non come un animale tra altri animali, ognuno pronto a fare a pezzi l’altro.
Mentre continuava ad aprire e chiudere ritmicamente il serramanico pensò che non sapeva quando avrebbe visto quella luce, ma che per il momento quel pensiero gli aveva fatto bene. Era già qualcosa, in un manicomio di mondo come quello... anno Domini 2189.
domenica 14 novembre 2010
Dizionario gastronomico ragionato
Anch’io, come tutti, mangio; l’uomo è quello che mangia, come si suol dire? Mah, non saprei (anche suole a parte).
Comunque quando faccio la spesa mi colpisce il nome di certi alimenti, molti dei quali sembrano inventati. Exempla (esempi):
Bavette. Tipo di pasta egizia. Particolarmente gradita dal faraone Tutankamon, che infatti la custodiva gelosamente nella sua barba.
Brigantone. Il “Brigantone” è un formaggio. Sotto la consueta e doverosa stratificazione di cellophane, trovate una policroma etichetta che rappresenta un terribile criminale che avvolto in un cappottaccio tarmato, vi fissa da sotto 2 metri di barbaccia.
Gli occhi si vedono appena, forse perché temono di farsi raschiare o asportare dalla rovosa barba.
Il brigante che lega il suo destino criminoso a quello dell’omonimo formaggio è fucil-munito e dalle sue tasche fanno simpatico capolino 3 o 4 coltellacci, probabilmente atti allo scuoiamento dei mammuth.
Spostiamoci ora nel creativo mondo dei bar; a chi non piace un buon caffè? Parliamo quindi del
Caffè corretto. E’ stata ormai scartata l’ipotesi che si tratti di una bevanda molto amata dai professori di grammatica e di dizione.
L’ipotesi in questione sopravvive solo in angusti (e dall’aria viziata) ambienti di coltivatori di ciclamini del Quebec.
In ogni caso, stando al recente testo alchimistico Veneficum caffeum, prima di bere un caffè corretto sarebbe opportuno inzuppare all’interno della tazzina una lucertola in preda a (moderato) delirium tremens e possibilmente, daltonica.
Trancio del porto. La storia di questa pizza, clandestinamente venduta nelle più rinomate bettole di tutte le città di mare, è davvero sofferta.
Originariamente il Trancio fu ritirato dalla circolazione per una questione di diritti d’autore: il suo nome fu considerato dai figli di Marlon Brando un evidente plagio del famoso film Waterfront, in italiano Fronte del porto.
Pagata una penale d’alcuni milioni di euro, il Trancio tornò sotto i tavoli di tutti i più pittoreschi postacci da qui a Vladivostock.
Purtroppo, esso fu poi chiamato Trancione del porto e questa nuova denominazione fu considerata potenzialmente oscena, anzi corrutrice dei costumi dei giovani.
Esso fu riabilitato solo quando si chiamò Pizza Van Gogh e benché sia ormai questa la denominazione ufficiale (accettata anche dall’associazione medica rionale) nel cuore di molti rimane Il trancio o Il trancione.
Ingredienti: farina, mozzarella di bisonte, salsa, aglio, cipolla, capperi, salsiccia sarda o dell’Aspromonte, aringa fritta, pepe, salvia, tabasco, speck, code d’anguilla farcite di peperoncino messicano e grasso di motore.
Tuttavia, non ogni pizzaiolo mette l’aglio.
Vialone nano. Pare che il Vialone sia un tipo di riso, anche se non si sa quale; qualcuno pensa che sia collegato alla toponomastica tedesca.
Effettivamente, a Berlino si trova il Der gross Zweg Allee… appunto il Vialone nano, quel viale molto largo ma cortissimo che collega Berlino a Koenisberg, la città che diede i natali al grande filosofo Immanuel Kant.
Ma certi germanisti sostengono che Der gross Zweg Allee significhi "il viale del grande nano"o del "nanone"; infatti tra il 1770 ed il 1799 alla corte di vari re di Prussia servì un uomo molto basso, di cui si ignora però l'identità.
Però l’ipotesi del riso (in sé non risibile) è stata comunque rivalutata da alcuni storici, anche grazie al ritrovamento, a Postdam, di una statua che riproduce Kant che (travestito da cinese) coltiva appunto del riso.
Be’, per ora chiudo qui e così; a presto e speriamo che non passi 1 altro mese!
sabato 2 ottobre 2010
Woland, il simpatico Diavolo di Bulgakov (parte 2/a)
Insomma, Il maestro e Margherita è un romanzo incredibilmente complesso, fantasioso eppure unitario.
Ad esso penso che si possa senz’altro applicare la definizione del Bachtin di “satira menippea.”1
Credo che il romanzo bulgakoviano possa essere considerato (almeno in parte) anche come un “poema eroicomico in prosa”: definizione, questa, che perlopiù si riserva a certo romanzo inglese del ‘700 e che ha come suoi antesignani soprattutto Henry Fielding e Lawrence Sterne.2
Probabilmente, tra “satira menippea” e “poema eroicomico” ecc. esiste un’affinità sul piano strutturale: nel senso che l’una e l’altro risultano composti di più elementi, spesso eterogenei, quindi davvero di varia e talvolta opposta natura.
Ma credo che esista anche una diversità sul piano emozionale poiché mi pare che la “satira menippea” non si proponga (se non casualmente) il fine di divertire il lettore. O almeno, anche se essa lo diverte, il suo è il classico riso amaro.
I sortilegi infatti del Satana di Bulgakov (e della sua “corte”) tendono più allo scherno che allo scherzo e le situazioni che nascono dal suo incontro con gli uomini si risolvono (il maestro e Margherita esclusi) quasi sempre in lutti, umiliazioni e smascheramenti di tipo clamoroso, talvolta grossolano ma non realmente comico.
Del resto, forse Bulgakov nel dipingere il suo Diavolo si ispirò a fonti letterarie e filosofiche antico-russe, che vedevano nel riso satanico e nello sguardo dei damnati componenti ovviamente sacrileghe ed inquietanti.
Infatti “ il diavolo è chiamato in Russia sut (buffone, giullare)”3
Emblematico il caso dello “spettacolo” in cui si esibiscono Woland ed i suoi. Infatti, al presentatore Bengalskij, che continua ad intromettersi, interrompere ed esigere il disvelamento dei “trucchi”, il gatto parlante Ippopotamo strappa la testa dal collo.
“Il sangue usciva zampillando dalle arterie strappate del collo impregnando lo sparato e il frac.”
Poi : “Il gatto consegnò la testa a Fagot, che la sollevò per i capelli mostrandola al pubblico mentre la testa gridava riempiendo della sua voce tutto il teatro:
“Un dottore!”
“Continuerai a biascicare idiozie?” chiese minaccioso Fagot alla testa piangente.
“No, mai più!” rantolava la testa.4
Come vediamo, questa situazione è tutto tranne che comica o divertente.
Sembra però che Woland abbia portato alla luce (lui che è il Principe delle Tenebre) quello che in certi può essere, di fronte ad un insopportabile seccatore, il loro più intimo ed inconfessabile desiderio: quello d’eliminarlo fisicamente.
Del resto, Belganskij avrà la testa strappata proprio dietro richiesta del pubblico.5
Ma naturalmente, qui un eventuale riso sarebbe molto… particolare perché: “Per le persone che non si sono legate a satana esso è tremendo e non ridicolo.”6
Note
1) Questa formula, di ascendenza appunto bachtiana è stata riproposta da Eridano Bazzarelli che scrive: “Difatti, come in questo tipo di satira latina, troviamo nel romanzo l’elemento lirico, quello sentimentale, quello epico, quello buffonesco: tutti questi materiali sono fusi interiormente” E. Bazzarelli, Introduzione a M. A. Bulgakov, Il maestro e Margherita, Bur, Milano, 2006, p.6.
2) Per la definizione di cui sopra cfr. Introduzione a Ulysses, in James Joyce, Telemachia. Episodi I-III, a c. di Giorgio Melchiori, Mondadori, Milano, 1983, p.xvi. Joyce diede ai primi 3 capp. dell’Ulisse il titolo appunto di “Telemachia.”
3) Juri Lotman e Boris Uspenskij, Lo studio della cultura dell’antica Rus’, in AAVV., La cultura nella tradizione russa del XIX e XX secolo, Einaudi Paperbacks, Torino, 1980, p.225. In russo nel testo. Trattazione più sistematica in J. Lotman e B. Uspenskij, cit., pp.226-241. Gli AA. estendono inoltre il concetto dell’estrema negatività del riso anche oltre l’ambito satanico.
4) M.A Bulgakov, Il maestro e Margherita, op. cit., pp.166-167.
5) M. A. Bulgakov, op. cit., p.166.
6) J. Lotman e B. Uspenskij, cit., 226.
martedì 28 settembre 2010
I morti sul lavoro di sabato 11 settembre
Sabato sono morti sul lavoro 4 operai. Le statistiche registrano appunto sul lavoro una media di 3 morti al giorno.1 Nel 2009 sono decedute 1050 persone; per l’Inail questo tragico bilancio è leggermente migliorato rispetto al 2008.2
Ma tale miglioramento dipende parecchio dalla diminuzione dovuta alla crisi economica.3
Sabato a Pescia, in provincia di Pistoia “un romeno di 36 anni, Marius Birt, è rimasto schiacciato da una pressa nell’azienda nella quale lavorava da sette mesi con un regolare contratto”4
A Capua, in provincia di Caserta sono morti tre operai. Erano: Antonio Di Matteo, 63 anni, originario di Macerata Campania e Vincenzo Musso, 43 anni, di Casoria, in provincia di Napoli. I primi 2 sono stati subito “colti da malore.”
“E’ probabile che Giuseppe Cecere, 52 anni, di Capua, che era uno dei decani della squadra addetti alle opere edili e noto per la sua abilità, abbia tentato di aiutarli.”5
Notevoli le analogie tra la tragedia di Capua e quella di Sarroch (Ca) del 26/05/2009; anche là morirono soffocati dalle esalazioni di gas 3 operai addetti alla manutenzione di un silos.
Anche a Sarroch gli operai lavoravano per un’impresa importante: nella cittadina sarda per la Saras, a Capua per la Dsm, “società olandese che produce sostanze per prodotti farmaceutici.”6
A Sarroch come a Capua, gli operai lavoravano per una ditta esterna.
Ma il problema trascende questo o quell’ambito geografico.
Giustamente il ministro Sacconi dichiara: “Colpisce il fatto che ancora una volta siano vittime di infortuni mortali coloro che operano in appalto specificamente nei servizi di manutenzione.”7
Infatti colpisce che persone che per vivere devono lavorare, sul lavoro muoiano; ma non sembra che il problema siano gli appalti quanto il modo in cui essi sono regolati.
Infatti: “Alla parola “appalto”, il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inail, dott. Lotito, “reagisce con durezza.”
“Il problema vero_ dice _ si chiama clausola del massimo ribasso, purtroppo è un problema noto: per avere gli appalti le ditte si offrono a prezzi stracciati ma così facendo poi sono costrette a tagliare i costi. E quali? Quelli per la sicurezza, prima di tutto.”8
Perchè scopriamo che la cisterna in cui si sono calati gli operai di Capua “risultava già bonificata, e i ponteggi che Cecere” ed anche “i suoi colleghi dovevano rimuovere era servito proprio per consentire ad altri tecnici di operare all’interno del serbatoio.”9
Ma la cisterna sembrava bonificata; infatti: “Secondo una ricostruzione della Procura, c’era stato un tentativo “maldestro” di bonifica: era stato fatto uscire solo l’elio, non l’azoto presente all’80%.”10
Ora, dobbiamo sapere che: “Le morti durante le operazioni di pulizia e manutenzione delle cisterne sono diventate una delle cause maggiori di decesso”; “Dal 2006 si contano almeno altri sette episodi di particolare gravità che portano il numero dei lavoratori avvelenati a 26.”11
Ci sarebbe ancora parecchio da dire su questa tremenda piaga sociale-lavorativa che con un ardito neologismo è stata definita “cisternite.”12
Segnalo del resto il giudizio del sostituto procuratore di Santa Maria Capua Vetere, Donato Ceglie, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo; per lui: “Da quanto sta emergendo mi sembra che non ci fosse sufficiente sicurezza e protezione”; infatti, il 20 i carabinieri di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato vari ispettori Asl per falsi certificati relativi proprio alla sicurezza sul lavoro.13
Bisogna ricordare, come dice il dott. Lotito che: “In molti casi, poi, questi sono lavoratori a cottimo”, o per essere più espliciti che: “L’abbattimento dei costi spinge a ricorrere a lavoro dequalificato con turni che si prolungano molto oltre l’orario normale, senza formazione, protezione, dotazione tecnica e sicurezza”14
Bisogna condannare gravi inadempienze da parte dell’imprenditore poiché “in generale” il dott. Lotito afferma che della reale sicurezza del lavoratore, il primo “se ne frega.”15
Infatti, circa quella sicurezza una sentenza della Cassazione ammonisce che “non è sufficiente che i datori impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza.”
Ciò deve avvenire “sino alla pedanteria” affinché “tali norme siano assimilate dai lavoratori nell’ordinaria prassi di lavoro.”
Sono quindi molte le questioni che riguardano gravissime inadempienze e non meno gravi sottovalutazioni del problema delle morti bianche in sede politica, legislativa, imprenditoriale ecc. ….
Certo, le leggi e le regole relative alla sicurezza dei lavoratori non sono un “lusso che non possiamo permetterci”, come dichiarato dal ministro Tremonti alla festa della Lega; infatti, do atto al ministro d’aver corretto questa affermazione.
Concordo quindi in toto col presidente Napolitano che “raccoglie la diffusa indignazione per il ripetersi di incidenti mortali causati da gravi negligenze nel garantire la sicurezza dei lavoratori.”16
E’ infatti importante sottolineare come le cd morti bianche non siano casuali o isolate ma facciano parte di dinamiche che si auto-perpetuano seguendo costanti spesso simili.
Penso quindi che si debba rivedere parecchio, affidarsi di più alla tecnologia (qui concordano sia Lotito che il sen. pdl Tofani) e per Lotito, sul lato giuridico: “Fissare una responsabilità comune, in caso di incidenti, per l’azienda che dà l’appalto e per quella che lo riceve (attualmente, invece, è solo quest’ultima a rispondere degl’infortuni dei suoi operai, ndr)."17
Infine, se la nostra vuol essere realmente una repubblica democratica, non deve mai derogare dall’art. 41 della Costituzione che dice: “L’iniziativa economica è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”18
Note
1) Liberazione, 12/09/2010.
2) Ma su questo dissente G. A. Stella, archiviostorico.corriere.it L’art. si intitola Morti sul lavoro e statistiche. I numeri che ingannano.
3) Liberazione, n° cit. ; su questo concorda abbastanza anche l’Inail.
4) Ansa, 12/09/2010.
5) Ansa, 12/09/2010.
6) Corriere della sera, 12/09/2010.
7) Corriere della sera, n° cit. Il corsivo è mio.
8) Corriere della sera, n° cit.
9) Corriere della sera, n° cit.
10) Ansa, 13/09/2010.
11) Liberazione, n° cit.
12) Cfr. F. Sebastiani su www.controlacrisi.org ; l’art. è dell’11/09/2010 cfr. Prezzo della crisi del 11-09-2010: “Quelle orrende morti in fondo alla cisterna” e sua intervista a G. Norcia, medico del lavoro Inca-Cgil su www.commercialpointjob.it Art. e intervista risalgono al 15/09/2010, tit.: “Il capolavoro di Sacconi e la riforma della legge sulla sicurezza ha tagliato le sanzioni.”
13) Per il giudizio del dott. Ceglie cfr. Liberazione, n° cit. e per gli arresti www.carabinieri.it.
14) Corriere della sera e Liberazione, nn° citt.
15) Corriere della sera, n° cit.
16) Corriere della sera,n° cit.
17) Corriere della sera, n° cit.
18) Il corsivo è mio.
giovedì 2 settembre 2010
3 anni di blog
Sì, 3 anni di blog e… continuo!
“Ebbene sì!”, come direbbe Stanislao Moulinski in uno dei suoi più riusciti travestimenti; tanto per citare dal cartone di Nick Carter.
E questa è per chi, come me, si trova alcuni anni oltre i 40; molti anni…
Ora, nel maggio del 2007 ho iniziato ad infestare il web e devo dire che finora mi sono trovato benissimo.
Certo, avrei dovuto celebrare l’anniversario del blog tre mesi fa; vabbe’, lo faccio ora. L’importante è farle, le cose; come disse il falsario.
In questi 3 anni bloggistici ho incontrato molte persone interessanti, con cui ho avuto scambi di opinioni stimolanti e positivi.
C’è stata anche qualche polemica; come fuori dal web, d’altronde. Tutto ok.
Qualche bloggers e/o commentatore della 1/a ora è scomparso/a (non so bene perché ma mi spiace) e ne sono arrivati di nuovi; a volte i “vecchi” ritornano e così via.
Benissimo: questo blog è come una locanda in cui ogni viaggiatore può fermarsi a scambiare 4 chiacchiere prima di riprendere il suo viaggio.
E naturalmente, chi vuole può fermarsi… quanto vuole.
Altrimenti questa sarebbe una segreta medievale, non un blog.
Ho scelto di dare alla bloglocanda un’impronta prevalentemente artistica, benché poi parli anche di altre cose.
Non parlo molto di me, se non in forma velata e (spero) leggera: scontrandomi con l’Interlocutore Immaginario, per esempio.
Su di me sorvolo ma forse, uno che scrive parla sempre di sé; solo, lo fa in modo nascosto… per insicurezza o per una forma di pudore (magari esagerata) un po’ perché non si considera granché interessante.
Con qualche quintale di sofferenza, qui ho scelto parlare poco di blues, Lennon, Springsteen, Dylan, gli Who, Socrate, Abelardo ed Eloisa, S. Agostino, Gramsci, Dostoevskij, il romanzo di Jean D’Ormesson Dio: vita e opere, il grande Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam (ma forse basto io, trattandosi di follia) ecc. nonchè eccetera.
Ho inoltre deciso di non postare clip musicali (cosa però questa che faccio, talvolta, sulla mia pagina fb) altrimenti non posterei nient’altro.
Non pubblico regolarmente ed a volte inizio cose che non ho il tempo di concludere, oppure trascuro troppo certi “argomenti.”.
Per es., nell’argomento “filosofando” ho parlato dell’impatto devastante che ebbe sugli indios la colonizzazione spagnola… ed il tema necessita di nuovi sviluppi e di una conclusione.
Ancora, in “luoghi e culture” ho pubblicato un solo post.
Sul teatro non scrivo da tantissimo tempo.
Sui mondiali (venendo ora allo sport) nonostante il mio amore per il calcio e lo sport, non ho scritto una riga; neanche una riga e mezza, accidenti!
Ecc. ecc.
Ma del resto, temi complessi ed almeno per me appassionanti richiedono del tempo; né sottovaluterei il fatto che… non mi corre dietro nessuno.
E per una volta, sono d’accordo con me stesso.
Benché abbia pubblicato 3 libri, di loro non parlo molto; in effetti, mi piace parlare anche di quelli degli altri.
Inoltre, nei blogs altrui noto con grande piacere quanti/e sappiano scrivere. Per me, molti/e di loro dovrebbero almeno cercare di pubblicare un libro.
Be’, grazie per l’interesse ed in alcuni casi anche per l’affetto che traspare dalle parole di certi, certe di voi.
A presto!
giovedì 12 agosto 2010
Siate creativi… riciclate!
Grazie a Simona ho conosciuto il riciclo creativo, un modo davvero innovativo di riutilizzare materiali che spesso ma a torto, scartiamo.
E’ impressionante scoprire quante e quali cose si possano realizzare con materiali di solito considerati poco “nobili” come scatole di latta, materiale da imballaggio, bottiglie, cassette di frutta ecc.
In Tailandia, con 1 milione di bottiglie e parecchi tappi, ecco un tempio buddista!
Documentarmi sul riciclo creativo mi ha inoltre risvegliato dei ricordi che pensavo d’aver ormai perduto…
Infatti, culture in prevalenza agropastorali (come quella sarda, benché io appartenga alla zona urbana) in passato hanno già conosciuto forme di quel “riciclo.”
Per es. ricordo che quand’ero bambino, mio nonno tramutava delle assicelle di cassette di frutta in fucilini.
Ed abbiamo conosciuto tutti gli antenati dei go-kart: parlo di quelle assi di legno che con dei cuscinetti a sfera come ruote, sfrecciavano per i vicoli delle città.
Mia madre, con vecchie palline da ping pong, qualche batuffolo di lana e dei pezzetti di fil di ferro creava dei pupazzetti. Le scatole di Ovolmatina rivestite con un po’ di carta da regalo avanzata da precedenti Pasque o Natali, diventavano dei portapenne.
Di recente, il marito di una parente da un vecchio scaldabagno ha ricavato il “kit” per il barbecue!
Vengo ora al punto che esula un po’ dall’Amarcord, mi chiedo infatti: il riciclo creativo, che quindi (in parte) esisteva già in passato, è concepibile solo in società contadine?
Rispondo di no perché come ho letto un forte riciclo creativo consentirebbe d’affrontare positivamente anche il problema dello smaltimento dei rifiuti.
Pur senza idealizzare le società contadine, osservo come (a livello di sistema) esse si servissero di ciò che potevano ragionevolmente pensare di utilizzare/ri-utilizzare.
Tali società puntavano non alla mera sussistenza o sopravvivenza ma ad un’esistenza che potesse prolungarsi nel tempo in modo sensato.
Mentre è chiaro che non vi è niente di sensato in un modello di sviluppo che produca una quantità di materiali da cui rischiamo d’essere soffocati.
N.B.: nell’Oceano Pacifico si trova l’agglomerato del Pacific Trash Vortex: 2500 metri di larghezza per 30 di profondità, composto per l’80% di plastica ed altri residui.
Nell’Atlantico è stato di recente individuato un suo “parente”, che “va” a 10 metri di profondità.
Pensiamo alle conseguenze per l’ecosistema ed i pesci; probabilmente questi enormi ammassi di rifiuti, attraverso la catena alimentare potranno toccare anche il nostro organismo.
Perciò il riciclo creativo non sarà la panacea, il rimedio universale ma intanto potrebbe essere una delle risposte pratiche.
Poi, perché l’arte non potrebbe dare una mano? Poesia viene dal greco poieo, “faccio”; perfino l’arte in apparenza più astratta ha quindi in sé l’idea di un fare, di un agire.
Nella 1/a metà dell’800 la cattedrale di Notre-Dame era quasi un rudere, ma il gran successo dell’omonimo romanzo di Hugo le garantì il recupero ed il restauro.
Peraltro, Notre-Dame era essa stessa un caso di riciclo creativo ante litteram, infatti fu edificata sulle rovine di un precedente tempio gallo-romano.
Sempre a Parigi, il Musèe d’Orsay sorge all’interno di una stazione ferroviaria del 1900.
Insomma, per me il riciclo creativo contribuisce a porci in rapporto con noi stessi e col tipo di mondo in cui vogliamo vivere. Certo, non risolverà ogni problema ecologico e non fornirà sempre soluzioni condivisibili sul piano estetico.
Ma ci farà almeno chiedere se siamo disposti ad usare le cose e come o se vogliamo farci usare da esse.
Nel romanzo di Harry Harrison Bill, eroe galattico spediremo sulle stelle con speciali “trasmettitori di materia” la nostra spazzatura; certo, qualcuna di quelle potrebbe trasformarsi in una supernova ed esplodere spazzando via parecchi pianeti!
Ora, il buon Harry si occupava di fantascienza; ma fino a pochi anni fa lo sembrava anche ipotizzare la costituzione di isole ( o peggio) di plastica.
La P.T. Vortex è grande 3-4 volte il Giappone…una sola bottiglia di plastica impiega almeno 400 anni a distruggersi in mare e circa 100 sulla Terra…
E’ impressionante scoprire quante e quali cose si possano realizzare con materiali di solito considerati poco “nobili” come scatole di latta, materiale da imballaggio, bottiglie, cassette di frutta ecc.
In Tailandia, con 1 milione di bottiglie e parecchi tappi, ecco un tempio buddista!
Documentarmi sul riciclo creativo mi ha inoltre risvegliato dei ricordi che pensavo d’aver ormai perduto…
Infatti, culture in prevalenza agropastorali (come quella sarda, benché io appartenga alla zona urbana) in passato hanno già conosciuto forme di quel “riciclo.”
Per es. ricordo che quand’ero bambino, mio nonno tramutava delle assicelle di cassette di frutta in fucilini.
Ed abbiamo conosciuto tutti gli antenati dei go-kart: parlo di quelle assi di legno che con dei cuscinetti a sfera come ruote, sfrecciavano per i vicoli delle città.
Mia madre, con vecchie palline da ping pong, qualche batuffolo di lana e dei pezzetti di fil di ferro creava dei pupazzetti. Le scatole di Ovolmatina rivestite con un po’ di carta da regalo avanzata da precedenti Pasque o Natali, diventavano dei portapenne.
Di recente, il marito di una parente da un vecchio scaldabagno ha ricavato il “kit” per il barbecue!
Vengo ora al punto che esula un po’ dall’Amarcord, mi chiedo infatti: il riciclo creativo, che quindi (in parte) esisteva già in passato, è concepibile solo in società contadine?
Rispondo di no perché come ho letto un forte riciclo creativo consentirebbe d’affrontare positivamente anche il problema dello smaltimento dei rifiuti.
Pur senza idealizzare le società contadine, osservo come (a livello di sistema) esse si servissero di ciò che potevano ragionevolmente pensare di utilizzare/ri-utilizzare.
Tali società puntavano non alla mera sussistenza o sopravvivenza ma ad un’esistenza che potesse prolungarsi nel tempo in modo sensato.
Mentre è chiaro che non vi è niente di sensato in un modello di sviluppo che produca una quantità di materiali da cui rischiamo d’essere soffocati.
N.B.: nell’Oceano Pacifico si trova l’agglomerato del Pacific Trash Vortex: 2500 metri di larghezza per 30 di profondità, composto per l’80% di plastica ed altri residui.
Nell’Atlantico è stato di recente individuato un suo “parente”, che “va” a 10 metri di profondità.
Pensiamo alle conseguenze per l’ecosistema ed i pesci; probabilmente questi enormi ammassi di rifiuti, attraverso la catena alimentare potranno toccare anche il nostro organismo.
Perciò il riciclo creativo non sarà la panacea, il rimedio universale ma intanto potrebbe essere una delle risposte pratiche.
Poi, perché l’arte non potrebbe dare una mano? Poesia viene dal greco poieo, “faccio”; perfino l’arte in apparenza più astratta ha quindi in sé l’idea di un fare, di un agire.
Nella 1/a metà dell’800 la cattedrale di Notre-Dame era quasi un rudere, ma il gran successo dell’omonimo romanzo di Hugo le garantì il recupero ed il restauro.
Peraltro, Notre-Dame era essa stessa un caso di riciclo creativo ante litteram, infatti fu edificata sulle rovine di un precedente tempio gallo-romano.
Sempre a Parigi, il Musèe d’Orsay sorge all’interno di una stazione ferroviaria del 1900.
Insomma, per me il riciclo creativo contribuisce a porci in rapporto con noi stessi e col tipo di mondo in cui vogliamo vivere. Certo, non risolverà ogni problema ecologico e non fornirà sempre soluzioni condivisibili sul piano estetico.
Ma ci farà almeno chiedere se siamo disposti ad usare le cose e come o se vogliamo farci usare da esse.
Nel romanzo di Harry Harrison Bill, eroe galattico spediremo sulle stelle con speciali “trasmettitori di materia” la nostra spazzatura; certo, qualcuna di quelle potrebbe trasformarsi in una supernova ed esplodere spazzando via parecchi pianeti!
Ora, il buon Harry si occupava di fantascienza; ma fino a pochi anni fa lo sembrava anche ipotizzare la costituzione di isole ( o peggio) di plastica.
La P.T. Vortex è grande 3-4 volte il Giappone…una sola bottiglia di plastica impiega almeno 400 anni a distruggersi in mare e circa 100 sulla Terra…
Iscriviti a:
Post (Atom)