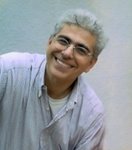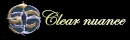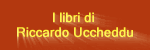giovedì 28 febbraio 2013
La dolce Molly Malone
Molly Malone
è un famoso pezzo irlandese che a me piace molto, noto anche come
Cockles and mussels (arselle
e cozze). Io conosco il brano in questione grazie all'esecuzione del
gruppo folk The dubliners.
Di
solito si attribuisce la paternità della canzone allo scozzese
(dell'800) James Yorkston; qualcuno pensa che con essa intendesse
deridere gli irlandesi che emigrarono appunto in Scozia durante una
devastante crisi economica.
Ma
come vedremo, l'intenzione (di per sé spregevole)
ha ottenuto l'effetto contrario. Chi ascolti la canzone col
cuore solidarizzerà con Molly e
col suo destino.
Ora,
probabilmente non è mai esistita una ragazza come quella cantata da
Yorkston. Le fonti storiche registrano una M.M. che sarebbe morta di
febbre tifoide a fine '600, ma non pare che dicano molto altro.
A
Dublino, per l'esattezza a Grafton Street, esiste una statua dedicata
appunto a Molly e mi è stato assicurato da persone che hanno
vissuto e lavorato in quella città che laggiù il brano è cantato
(e con forte trasporto) praticamente da tutti.
La
questione storica cioè
quella che riguarda la reale esistenza
di Molly, beh, quella non interessa granché: in casi come questi
contano l'aspetto poetico e quello romantico. E secondo me, in un
mondo dannatamente storto, spigoloso, spinoso ed insomma ingiusto
come questo, il romanticismo non
è poi il peggiore dei mali.
Bene,
la canzone è una ballata ed i Dubliners accompagnano
il cantato con una o due chitarre acustiche; forse anche con un banjo
ed un violino (o almeno, io ce li metterei).
Il
giorno di S. Patrizio, io, Little Steven, Elliott Murphy, Van Morrison,
Elvis Costello e Grace Slick l'abbiamo eseguita in versione
folk-rock. Doveva accompagnarci al tamburello Dolores O' Riordan, ma
purtroppo quella sera doveva andare nel bosco a raccogliere mirtilli.
Ma vedo che sto divagando o che addirittura, non mi credete... perciò
proseguiamo.
Celeberrimo
l'inizio del pezzo: “In Dublin's Fair City/ when the
girls are so pretty/ I firts set my eyes on sweet Molly Malone,
nella bella città di Dublino/ dove le ragazze sono tanto carine/
posai per prima lo sguardo sulla dolce Molly Malone.
Il
brano prosegue dicendo che lei conduceva un carretto attraverso ampie
e strette strade gridando: “Cockles and mussels alive,
alive, o!, arselle e cozze
fresche!
Molly
era quindi una “fishmonger”,
una pescivendola e come aggiunge la canzone, di questo non dobbiamo
meravigliarci: lo furono prima di lei già suo padre e sua madre.
Lei
apparteneva quindi ad una classe di lavoratori che cercava di
sbarcare il lunario in qualche modo. Inoltre, dal brano si potrebbe
ipotizzare che alcuni di loro mancassero di un posto di lavoro
stabile, o che ne fossero esclusi... come per esempio da un box al
mercato del pesce.
A
quei lavoratori, che potremmo definire itineranti, occasionali,
avventizi ecc. mancava (ovviamente, parliamo di tanto tempo
fa!) qualsiasi
garanzia di tipo economico, sociale e sanitario; infatti l'ultima
strofa dice: “She died for a fever/ and no one could save
her, morì di febbre/ non
avrebbe potuto salvarla nessuno.
La
fine di Molly ricorda un po' quella di Michael Furey, un povero
“ragazzo che lavorava nell'azienda del gas”, che nel racconto di
Joyce I morti amava
Gretta, futura moglie di Gabriel Conroy.
Sia
Molly che Michael appartengono a quella schiera di umili lavoratori
per i quali esisteva solo una vita fatta di sfibranti sacrifici,
malattie e duro lavoro: fino alla morte.
La
canzone termina infatti così: “But her ghost wheels her
barrow/ through the streets broad and narrow/ crying cockles and
mussels alive, alive o!, ma il
suo fantasma conduce
il suo carretto/ attraverso le ampie e strette strade/ gridando
arselle e cozze fresche!
Insomma,
Molly non trova pace neanche da morta, continua a vagare per le
strade di quella Dublino che aveva già percorso tante volte e con
ogni clima, quando cercava di guadagnarsi almeno il necessario per
vivere.
Joyce,
nel Portrait of the artist as a young man (Ritratto
dell'artista da giovane, da noi
tradotto spesso solo come Dedalus)
sostiene che gli irlandesi sarebbero “sentimentali.”
Non
saprei: non ho mai conosciuto un irlandese o una irlandese di persona
Sempre
gli irlandesi, che in letteratura sanno essere dei gran burloni come
Flann O' Brien; o che possiedono come lo stesso Joyce una forte
inclinazione per la satira e la parodia; o che come Beckett,
possiedono uno spirito piuttosto amaro e caustico, ebbene, essi hanno
fornito della vicenda della povera Molly anche interpretazioni molto
meno romantiche... che però ora
tralascio per non guastare la magia del brano.
Che
dire? Molly e Michael appartengono ad un mondo di fantasia tuttavia
non lontano dalla realtà: per me sono simboli di
fatiche e dolori che torturarono, per generazioni, un'infinità di uomini e donne.
Ne
I morti, a G. Conroy
pare di vedere Michael
e tante altre “figure”, anche queste di morti.
Il
brano di Yorkston continua a tenere viva, pur attraverso la sua
esistenza di spettro, la voce e la persona della “dolce Molly
Malone”... e la semplice ma incisiva melodia del brano rende il
tutto molto malinconico, anche struggente... ma nello stesso tempo,
quasi confortante.
Ora
vado a studiarmi il pezzo con l'armonica.
Ci
vediamo!
giovedì 21 febbraio 2013
La discussione filosofica (riepilogo)*
Poiché questi
articoletti arrivano a distanza anche di mesi l'uno dall'altro, oggi
riassumerò le precedenti parti o “puntate.”
Nella 1/a ho
affrontato il problema di quella che ho definito “ipertrofia
dell'io” (o anche “autoesaltazione”) di cui spesso soffrono
molti filosofi. Si tratta della convinzione, bizzarramente sostenuta
e difesa da molti di loro, d'essere i soli ad aver ragione.
Concludevo però che
denunciare o almeno documentare questo narcisismo intellettuale
non significa svalutare
completamente né la “personalità dei singoli filosofi, né
l'esito delle loro ricerche.”
Infatti,
purtroppo questi due pericoli esistono sempre: è facile attaccare
certi vizi o difetti sì da gettare determinati pensatori in una
sorta di pattumiera della cultura.
E'
facile, certo... ma così non si entra nel merito della filosofia di
uomini spesso geniali o che comunque devono essere criticati da un
punto di vista essenzialmente filosofico.
Nalla
2/a sottolineavo
quanto la dimensione dell'io e
la personalità del philosophus siano
importanti, spesso decisive. Sottolineavo altresì quanto (anche per
il philosophus,
certo!) sia importante il mondo delle emozioni:
ragionavo su quanto conti qualcosa che probabilmente racchiude altre
realtà ed emozioni come per es. l'amore.
Riferendomi
soprattutto alla figura dello scrittore statunitense dell'800 Hawthorne,
nella 3/a spiegavo
come l'amore possa salvare l'essere
umano dal pericolo del solipsismo,
intendendo con questo termine la credenza che un un individuo può
coltivare d'esistere, al mondo, solo lui.
Nella
4/a parte sviluppavo
l'esame del solipsismo,
che in epoca moderna è stato teorizzato soprattutto da Schopenhauer.
Mi collegavo così a Poe, che
visse quella
credenza con un senso d'angoscia, di lacerazione interiore quindi di
serietà esistenziale che
forse Schopenhauer non
provò mai.
Nella
figura poi del Dedalus di
Joyce, il solipsismo
sfocia nell'hybris (tracotanza)
di tipo greco; il che, nella versione cristiano-cattolica è poi la
ribellione di Satana a
Dio.
Nell'uomo
questa ribellione è quella dell'artista,
che nella creazione e diffusione della sua opera rifiuta qualsiasi
legame o responsabilità di tipo morale, familiare, sociale ecc.
Nella
5/a spiegavo come
anche questa ribellione o rivolta, che in Joyce o comunque
nell'artista che spezzi ogni legame si presenta come autoliberazione,
possa però contenere forti scrupoli morali e notevoli ansie di tipo
esistenziale. C'è insomma il classico prezzo da pagare...
Nella
6/a ho cercato
d'evidenziare quanto la passionalità
e talvolta eccessiva emotività dell'artista
possano “captare e decifrare la natura intrinsecamente complessa
del mondo.”
Strano?
Forse. Ma non meno di quanto lo sia appunto il mondo. Anche senza
seguire fino in fondo l'Aristofane che disse: “Il caos
regna sovrano”,
resta
comunque il fatto che il mondo ed anche la conoscenza di noi stessi
sono intessuti di contraddizioni, oscurità, verità parziali,
equivoci e non di rado, anche di vere e proprie assurdità.
Allora
a me sembra piuttosto sensato pensare che tutto ciò possa essere se
non del tutto chiarito, almeno validamente affrontato
da
chi nella contraddizione, nell'oscurità ecc. vive:
appunto dall'artista.
Chissà che opporre al caos dell'altro
caos
non possa essere un buon sistema per arrivare all'armonia!
Del resto, spesso è arduo fidarsi dei filosofi: di fronte
all'incertezza delle loro analisi ed alla problematicità delle loro
soluzioni, si sarebbe tentati di pensarla come il poeta Kurt
Tucholsky. Egli, infatti, parla di una “cesta piena di filosofi”,
che una volta letti vorresti mettere “tra i ferrivecchi”, per
ripetere dentro di te: “Non ne sanno niente. Non ne sanno niente.”1
Ancora:
come possono certi
discettare per delle ore (o per centinaia di pagine) di dubbio,
angoscia,
scelta,
dramma dell'esistenza
ecc. quando la loro è
una vita di tranquilli e ben pagati professori universitari?2
A quel punto non sarebbe meglio rivolgersi a Cechov, Gogol, Dylan
Thomas, Dostoevskij e tanti altri poeti e romanzieri... se non
“darsi” addirittura ai mistici?
Ma senza accantonare questi dubbi e spesso anche una certa
irritazione, dobbiamo però dire che la filosofia, diversamente dalla
letteratura e dall'arte in genere non può permettersi di
fantasticare o di scherzare: neanche in modo grottesco. Del resto,
anche se per Pascal: “Burlarsi della filosofia è veramente
filosofare”3, poi non mi risulta che quello spunto sia mai stato
seguito (dai filosofi) in modo significativo.
Né la filosofia può sperare nelle consolazioni della mistica:
perfino tra i pensatori di ispirazione religiosa come per es. S.
Agostino, Abelardo, Pascal e Kierkegaard serpeggia un sentimento di
dubbio, talvolta anche d'angoscia.
La
filosofia, che per me è vitale quando è non
pensiero “puro”,
slegato quindi dal rapporto con altri esseri umani (come se fosse
quello di un dio che vive lontano dal nostro mondo) bensì
discussione filosofica,
bene, quel tipo
di filosofia
è una sorta di tela di Penelope4: qualcosa quindi che deve essere
continuamente fatto e disfatto... perché le conclusioni a cui arriva
anche se potrebbero
essere certe e
definitive, non lo sono mai per tutti.
Ed
anche quando le conclusioni di cui sopra potrebbero
essere certe e
definitive per tutti, magari si può trovare un modo per renderle
più chiare, certe ecc.
La
filosofia intesa quindi come discussione
e come dialogo deve
rientrare all'interno di un quadro razionale...
Ma come vedremo, la razionalità di questa
filosofia non può né
deve essere ridotta alla sola logica
ed al solo principio
di non contraddizione,
che sono invece fondamentali in matematica, in geometria e nelle
varie scienze
Nella
7/a parte illustravo
sia il “rovescio della medaglia” della creazione artistica: un
complesso insieme di autosuggestione, irrazionalismo, amore da parte
dell'artista per il lato
ludico del proprio
lavoro, sia il suo lato
positivo... vale a dire l'irripetibilità
dell'opera d'arte ed il
porsi l'artista oltre
la dimensione
logica e pratico-dimostrativa.
Beninteso,
questo è solo un riepilogo,
non l'epilogo di
questo post in più parti, che infatti ne prevederà delle altre.
Alla prossima, quindi!
* Ho pubblicato su questo blog le precedenti parti di questo
post rispettivamente: la 1/a il 25 /03/2008; la 2/a il 4/4/2008; la
3/a il 17/6/2010; la 4/a l’11/10/2011, la 5/a il 27/11/2011; la 6/a
il 15/11/2012; la 7/a l'8/12/2012.
Note
1. Helmut
Gollwitzer, Tredicesima
lezione, in H.
Gollwitzer Wilhelm Weischedel, Credere
e pensare. Due prospettive a confronto (1965),
Marietti, Genova, 1982,
p.275
2. Cfr.
Remo Cantoni,
Kierkegaard e la vita etica, in Soeren Kierkegaard, Aut
aut (1956),
Mondadori “Oscar”, Milano, 1984, p.28.
3. Blaise
Pascal, I
pensieri, Edipem, Novara, 1984, 4, p.17.
4. G.
W. F. Hegel, Prefazione a
Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Roma-Bari, 1979, p.4.
L'immagine
è stata ripresa anche da altri: cfr. Pietro Piovani, Indagini
di storia della filosofia. Incontri e confronti, Liguori, Napoli,
2006, p.169.
Se non erro, il Piovani utilizzò questa immagine anche in un altro
testo; cfr. P. Piovani, Principi
di una filosofia della morale, Morano Editore, Napoli, 1972. Al
momento non saprei però indicare con precisione la pagina relativa
appunto all'immagine citata.
sabato 19 gennaio 2013
Amsterdam o Amster-dam?
Quest’estate ho visitato l’Olanda
e le Fiandre. Si è trattato di posti stupendi, che spero proprio di rivedere…
un giorno o l’altro.
Amsterdam, poi, è un sogno. E’
una città che con quella profusione di canali che vanno di qua e di là, canali
che serpeggiano ma senza incrociarsi (o che se lo fanno, lo fanno in modo molto
razionale ed armonioso) mi fa pensare a Bach. Una città-sinfonia, la capitale
olandese… mica scherzo.
Certo, all’inizio rischi un po’
di confonderti: infatti, la cartina della città ti segnala il canale ed
anche la via, che se ho capito bene vanno in parallelo.
Mi spiego: in neerlandese (la
lingua che parlano in Olanda e nelle Fiandre) canale si dice gracht e
via, straat. Evidente, nel 2° caso, la vicinanza con l’inglese street
ed anche (ma meno) col tedesco strasse.
Quindi, a meno che negli ultimi
10 minuti non ti sia bevuto 5 o 6 birre, se cerchi il Koninkgracht è
sufficiente che non lo confonda con la Koninkstraat. Perché in
quest’ultimo caso raggiungi la “strada del re” e non il “canale del re.”
Certo, l’assonanza dei 2 termini
può confondere... ma allora non c’è altro da fare che continuare a
consultare ed a leggere la cartina, senza fidarsi troppo dei suoni. Nei giorni
da noi trascorsi ad Amsterdam, infatti, non ci siamo mai persi (nonostante
qualche momento labirintico).
Insomma, ad A’dam puoi girare
come se stessi esplorando le tue tasche… la città presenta poi il vantaggio di
non essere bucata appunto come le mie tasche.
Ad A’dam se non parli neerlandese (io non lo parlo più da
quando ho smesso di accompagnare Spinoza nei pubs)
è oltremodo consigliato l’inglese, che parlano in parecchi. Io un po’ lo
parlo, o almeno vedo che quando lo bofonchio, mi capiscono. Spero…
Nella capitale olandese ho tenuto
il mio francese in naftalina, anche se penso che lo parlino almeno le persone
dai 50 anni in su; ohi, la mia età!
Tempo fa ho frequentato un corso
di tedesco, ma in Nederland non ho messo alla prova la mia
conoscenza della lingua di Goethe, conoscenza che giudico ancora acerba.
In generale, gli amsterdamesi
sono riservati ma gentili. Qualcuno mi ha detto che sono anche tirchiotti; non
saprei. Certo è un po’ seccante dover pagare ogni volta che ti serve il bagno:
ma spesso questo capita anche a Parigi.
La città è pulitissima, pulita in
modo quasi intimidatorio, come diceva Erica Jong in Paura di volare a
proposito di Vienna; inoltre, non si sente mai urlare né parlare a voce appena
un po’ alta.
Sull’igiene approvo
incondizionatamente.
Approvo senza condizioni anche la
mancanza di chiassate, ma con una precisazione: coi nostri modi, noi latini
tendiamo a fare (voglio dirlo in modo che la cosa risulti almeno un po’
simpatica) del teatro non per volgarissima maleducazione ma solo per una
certa esuberanza.
Certo, chi urla come se lo stessero
scannando: chi spiattella ai 4 venti i propri problemi personali; chi manifesta
stima per l’avvenenza di certe fanciulle in modo cafonesco, beh, quello lo
trovo odioso anch’io. In casi come quelli o simili a quelli, la latinità non
c’entra proprio niente.
Sia perché l’Olanda è una meta
turistica da noi molto ambita, sia perché laggiù c’è stata un po’ d’emigrazione
italiana (benché non paragonabile a quella che toccò Francia, Belgio, Germania
ecc.) qualche olandese ha imparato 2 o 3 parole della nostra lingua.
Magari ho trovato un po’ buffo
che un locale si sia dimostrato colpito dal fatto che diciamo: “Mille grazie.”
Per noi, quella è una formula di cortesia come tante, con la quale non intendiamo esprimere chissà quale riconoscenza.
Di una cosa simile troviamo
traccia in Gramsci, che scrive di quanto la tedesca Clara Zetkin fosse
fosse stata colpita da questo, che gli italiani del sud augurassero non la
semplice “Buona notte” bensì una “Felice” o addirittura “Santa
notte.”
Si tratta, osservava il Nostro,
di semplici locuzioni se non di convenzioni linguistiche; al massimo
possiamo aggiungere che forse esse possono denotare una mentalità
eccessivamente ossequiosa, magari (inconsciamente) legata a miti e rituali di
un passato ormai superato.
Passando ad altro, la nostra
guida olandese (sig. Stibe) insisteva parecchio sul fatto che il nome corretto
del suo Paese è Paesi Bassi, in neerlandese Nederland e non Olanda.
Da loro “Olanda” indica 2 delle province che compongono il Paese.
Aveva ragione, però in molte
lingue europee è preferito il nome “Olanda”, come in italiano; Hollande,
in francese; Holland, in inglese; Holanda, in spagnolo ecc.
Ma perché Paesi Bassi? Per
la sua, particolarissima, conformazione geografica. L’Olanda è… come dire?,
molto piatta, circa un quarto del suo territorio si trova sotto il livello del
mare. Nel romanzo (ambientato nelle Fiandre del 1400) di Gilbert Sinouè Il
ragazzo di Bruges, si parla proprio di plat pays.
Ancora: lo Stibe non diceva
Amsterdam ma Amster-dam. Come saprete, la città fu costruita
verso il 1250, presso la diga che sorgeva sul fiume Amstel. Ed in neerlandese
“diga” si dice dam. Quindi, Amster-dam, diga sul fiume Amstel. Pare che
la dicitura Amsterdam si trovasse già in un documento del 1275.
Sarebbe come se Roma si chiamasse
Teverdiga; Parigi, Seinedigue: diga sul Tevere, diga sulla Senna
ecc.
Unica nota negativa? Le bici,
che sfrecciano per tutta la città ad una velocità impressionante e che
(sebbene abbiano loro strisce e corsie) se non stai attento, possono piombarti
addosso e portarti via una gamba o qualche costola.
Infatti, chi conduce quelle
dannate bici-killer ti avverte con un suonetto che non sentiresti
neanche se ti trovassi dentro il loro campanello; in più, la pista delle
bici è allo stesso livello del marciapiede… se anche del tutto inavvertitamente
scantoni di qualche cm, sei fritto ed impanato.
Ma se sono tornato a casa sano e
salvo io, che sono una delle persone più distratte di tutti i tempi,
beh, allora voi andrete lisci come l’olio,
tranquilli!
Ancora: sapevo di Amsterdam e dei
suoi canali.. ma fin dalla prima sera nella tulipanica città ho avuto
l’impressione di camminare quasi in mezzo al mare!
Non scherzo: mi sembrava che tra i marciapiedi e le strade
ci fossero delle luci, boe di segnalazione ed altra roba del genere… mi
sembrava che l’insieme appunto di semafori, strade e marciapiedi fosse stato
lanciato sul mare, come una sorta di ponte.
In albergo, poi, abbiamo trovato
degli scalini in legno che per colore e fattura facevano pensare proprio a
qualcosa di marinaresco.
Del resto, poco dopo piazza Dam
c’è una via anche piuttosto ampia in cui ancora a fine ‘800 arrivava davvero
il mare!
Spesso quando andavo a dormire avevo la sensazione che la
stanza ballasse, mi sembrava di trovarmi quasi a bordo di una nave o di una barca.
Ho avuto anche l’ispirazione per
un racconto lungo o per un romanzo breve: chissà che non lo scriva, prima o
poi! Però dovrei trasferirmi per qualche settimana ad Amster-dam, là consultare
antiche carte e documenti d’archivio; insomma, dovrei trasferirmi
nell’amstelica città per qualche mese.
Dichiaro quindi la mia
disponibilità a farmi ospitare (a spese dell’amministrazione cittadina o di
quella universitaria) in qualsiasi hotel di A’dam; anche non lussuoso.
Dite che ho una bella faccia
tosta? Non credo proprio: come tutti sanno gli scrittori sono sacri agli Dèi,
quindi…
Quindi, cari sindaco e/o
rettore dell’università di A’dam, non fatemi aspettare mesi o anni.
Sappiate però che:
1) non insidierò le vostre donne
(sono un marito iperfedele);
2) berrò moderatamente;
3) non nuoterò nei canali o
almeno, darò la precedenza ai battelli.
Allora, che cosa rispondete?
Su, non statevene lì come salami,
sappiate che le autorità di Bruges, Anversa, Dublino, Venezia, Bologna e
Liverpool fremono per offrirmi la loro ospitalità!
domenica 13 gennaio 2013
Ricordo di Luigi Morsello
Il 25 gennaio 2012 si è spento a Lodi all’età di 74 anni
Luigi Morsello.
Come leggiamo nella quarta di
copertina del suo libro (che consiglio caldamente di leggere) La mia
vita dentro. Memorie di un direttore di carceri, Infinito Edizioni,
Roma, 2010, Luigi nacque ad Avigliano, Potenza e fu direttore appunto di
carceri dal 1969 al 2005.
Francamente, l’espressione “si è
spento”, se riferita ad un uomo come lui mi sembra... errata: difficile
accettare il fatto che una personalità vivace, multiforme, ironica come la sua
non “bruci” più.
Quel che invece continua a fare
nel suo La mia vita dentro, testo che non racconta sola la sua carriera, ricco come è di spunti di riflessione ed inoltre animato da grande coraggio
civile, spirito critico e… stile. Sì, perché Luigi sapeva anche
scrivere. E bene.
Ci siamo conosciuti solo sul web:
prima attraverso il suo blog http://ilgiornalieri.blogspot.it/ poi sul mio.
Una conoscenza “virtuale”, come
si dice: eppure, non per questo meno forte ed intensa sul piano delle idee e di
una visione della vita basata, per entrambi, su sogni e progetti di giustizia
sociale e di cultura.
Proprio sul mio blog recensii il
libro di Luigi http://riccardo-uccheddu.blogspot.it/2010/06/la-mia-vita-dentro-di-luigi-morsello.html ed il mio pezzo
originò un' interessante ma a tratti anche polemica
discussione, che (di questo mi spiace molto) forse non seppi gestire
adeguatamente.
Purtroppo, poi io e lui non
abbiamo avuto la possibilità di chiarire del tutto la “cosa.”
Probabilmente, discussioni
complesse e delicate richiedono tempi più lunghi e modalità di discussione più
ampie.
O forse, quelle discussioni
richiedono semplicemente personalità più “elastiche” della mia.
Comunque, soprattutto in tempi
come questi, nei quali cioè la Corte europea dei diritti umani accusa l’Italia
di trattamento “inumano e degradante” dei detenuti, trovo fondamentale la
lezione che proviene dal libro e dall’esperienza di Luigi: una lezione
di tolleranza, comprensione e di forte impegno nel recupero e nel riscatto appunto del detenuto.
Quello che per Luigi rimaneva
sempre e comunque un uomo, in linea quindi (non solo teorica!)
col Beccaria e con la nostra Costituzione.
Infatti, nel suo testo Luigi
denuncia anche vuoti legislativi e culturali, facilonerie politiche,
amministrative, crudeltà ecc. che rendono il carcere più un Inferno in terra
che un luogo di recupero e di riscatto umano e sociale.
Ma nelle carceri da lui dirette
il detenuto aveva accesso a dimensioni lavorative e creative.
Eppure su questo fondamentale aspetto,
Luigi non insiste più di tanto: perché secondo me un grande uomo sa
farsi piccolo; lascia il vanto ai vanagloriosi.
I suo interessi comprendevano
diritto, politica, letteratura, giornalismo, musica… ricordo perfino un suo
post su Springsteen!
Una volta rispose ad un mio
commento dicendo più o meno: “In questo momento sto ascoltando un pizzicato che
mi dà una forte emozione.”
Mi pare che stesse ascoltando qualcosa
di Bach o di Rostropovic eseguito al violoncello.
Era un uomo che nonostante una
vita lavorativa fatta di laceranti responsabilità aveva mantenuto o
addirittura esteso i suoi interessi, non restringendo né confinando la
sua personalità alla sola dimensione dell’ex-direttore di carcere e/o a quella
del pensionato. Ed era capace di ironia e di autoironia.
Così, per quanto possibile voglio
concludere questo suo ricordo cercando di mantenermi nel suo spirito.
Infatti, nel 1° capitolo del suo
libro (a p.22) Luigi ricorda gli esordi della sua carriera e parla del
traghetto che prese per raggiungere la Capraia.
Quel traghetto era la Nonno
Beppe e nel racconto di Luigi quel vecchio barcone fa pensare ad un mix di:
baleniera di Braccio di ferro, nave degli emigranti e zattera di Huck resa
celebre da Mark Twain.
Così mi piace pensare che ora
Luigi si trovi su una barca che navigando tra le nuvole, lo sta portando su una
spiaggia tranquilla ed assolata da cui potrà scrutare il mare ed ascoltare dal
vivo i suoi Bach e Rostropovic…
Nel frattempo sorseggerà un caffè
e rivolgerà a noialtri molti suoi sguardi… secondo me, bonariamente ironici.
Buon viaggio, Luigi... buon viaggio.
lunedì 24 dicembre 2012
Il Natale di Giovanni Piras
Le galere del duca non erano proprio l’ideale per passarci
la vigilia di Natale, così siano benedetti quei pochi pezzi d’argento che hanno
favorito la mia fuga. Qualche ora fa stavo tra i topi ed i vermi ma ora sono di
nuovo libero. La notte è buia, per fortuna: per quei cani di spagnoli sarà più
difficile, trovarmi!
Anno Domini 1576, anno del
Signore… ma a volte questi anni e questo mondo sembrano Diaboli, del
Diavolo…
Il povero lavora come una bestia
da soma per il ricco, che così diventa sempre più ricco; donne e vedove sono il
trastullo di qualche puzzolente hidalgo; il bambino è un fragile,
indifeso essere che chiunque può prendere a calci sulla pubblica via, come se
fosse un cane; il prete parla dell’amore di Cristo ma sbava e ringhia
predicandoci l’Inferno; il dotto usa il suo latino e la sua filosofia non per
scacciare le tenebre dell’ignoranza e della superstizione ma per sbertucciarci
e per confonderci.
Fui “preso a lavorare” (come si
dice da noi) dal duca in quel suo schifoso palazzo che andava in rovina ogni
giorno di più; maledetta sia la mia
fama di bravo muratore!
I miei amici dicono che penso
“troppo” e forse è vero, ma secondo me gli uomini non vengono al mondo per
pensare solo al lavoro, al vino ed alle donne. Mah. Certo che il mondo sarà
sempre un grande mistero.
Quando il duca mi prese a
lavorare mi parlò un po’ in sardo ed un po’ in spagnolo; seppi rispondergli in
entrambe le lingue: in sardo perché è la mia lingua, in spagnolo perché è
quella impostaci dai nostri dominatori.
Mi disse qualcosa anche in
latino… attaccava i sardi che tempo prima (in un villaggio alle porte di Caller)
avevano “osato” astenersi dal lavoro per un’intera giornata.
“E questo perché?!”, aveva
ripreso in spagnolo. “Solo perché non li pagavo da qualche mese, o da un anno!
Come se il loro padrone e signore avesse degli obblighi, dei doveri verso
quell’accozzaglia di pastori, minatori, pescatori ed operai!”
Aveva ripreso in latino, ma anche
se da fra’ Mario ne avevo imparato un po’, finsi di non capire; un uomo
istruito, anche se non molto, poteva essere accusato d’eresia… e per
quella c’era il rogo.
Mi piacerebbe studiare, ma
nell’anno Domini 1576 e sotto i re di Spagna, è già tanto se puoi lavorare come
un mulo e non beccare troppe bastonate…
Un amico di fra’ Mario mi ha
prestato dei pezzi, degli estratti (non so come si dica) di libri greci da lui
tradotti in sardo. Ne ricordo soprattutto uno che diceva: “Le leggi si
pronunciano su tutto e tendono all’utile comune.”
Quella frase mi piace molto perché
per me significa che non conta se sei un pastore, un muratore, un principe o un
ufficiale del re: le leggi sono come un padre che pensa a tutti i
suoi figli.
Certo, i nostri padroni non la
pensano così: le leggi che fanno, le fanno solo per il loro utile.
Comunque io ho capito questo: la
giustizia (che come diceva qualcuno è “virtù completa”) non può arrivare da
sola, come per magia; arriva se tu la fai arrivare.
Ecco perché dopo aver corrotto i
miei carcerieri, prima di scappare ho piantato il mio coltello nel petto del
duca… non volevo essere un evaso o un fuggiasco come tanti. Se non vuoi che la
giustizia sia solo roba per filosofi, giudici e poeti, allora devi prendere
qualche scorciatoia.
Di certo non puoi essere gentile
con chi prende a frustate, deruba, oltraggia o spedisce sul rogo te e la tua
gente. Chi è gentile con l’aguzzino e col succhiatore di sangue, beh, allora
vuol dire che gli dà quel diritto. Il duca è stato il primo a pagare
e spero proprio che non sia l’ultimo.
Spesso sogno uomini e donne che
si muovono in massa per la giustizia, sogno case pulite e ben
riscaldate, acqua e cibo per tutti, sogno che anche quelli come me potranno
leggere e scrivere quello che vorranno senza il terrore d’essere scoperti,
sogno un lavoro che non sia più roba da schiavi, che nessun re ci ordini
più di massacrare in guerre senza senso poveracci come me, sogno medicine che
curano e che curano anche la mia gente.
E’ la notte di Natale del 1576 e
mi piace pensare agli uomini ed alle donne che verranno… chissà, tra 100 anni,
tra 200, 300, 400, 500…
Ed anche se sembra un sogno da
fuggiasco o da ubriaco, vorrei augurare ai fratelli non ancora nati un sereno
Natale. Forse quella gente vivrà quello che io posso solo sognare.
lunedì 17 dicembre 2012
Quelli di “Borgo Polesinino”, di Franca Fusetti (1/a parte)
Tempo fa la cara amica blogger Franca Fusetti (Nou) mi
ha inviato alcuni suoi scritti, sia in versi che in prosa. Si tratta di lavori
che nella sua modestia lei non ha ritenuto meritevoli di pubblicazione, ma
per me questo è un male, perché non di rado in libreria troviamo volumi che non
possiedono di certo la freschezza della scrittura appunto di Franca…
Io spero che lei cambi idea, così
come penso che in Veneto non manchino case editrici in grado di “lanciarla”
come merita.
Comunque oggi vorrei parlarvi
della raccolta di racconti Quelli di Borgo Polesinino. Si tratta di
racconti brevi, bozzetti pieni di garbo ma che sono nello stesso testimonianze
autentiche e sofferte di un mondo forse oggi scomparso.
Come leggiamo in Lungo
l’argine: “Borgo Polesinino era una località sperduta, un gruppuscolo di
case”; “Polesnin, così era chiamato il borgo per semplificare.”
Si trattava di una piccola
cittadina situata nel Delta del Po, un micromondo di contadini, artigiani,
pescatori ed altri umili lavoratori che conducevano una dura vita di lavoro ma
che si aiutavano reciprocamente.
L’economia del Borgo non
permetteva troppi sogni o svolazzi, se come leggiamo in Rosa e Tonino il
fatto di sposarsi in inverno era considerato un “vantaggio” perché permetteva
di “aggiungere al corredo un bel cappotto nuovo rispetto a chi sposa nella
stagione calda.”
Ogni passo nella vita delle
persone era insomma strettamente commisurata a quanto ed a quel che
occorreva loro; l’idea del lusso (non parliamo nemmeno dello spreco) non
esisteva proprio.
Sempre in Rosa e Tonino assistiamo
ai preparativi per le nozze ed all’atteggiamento irritante e colpevolizzante
del parroco, che non sopporta affatto il fatto che Rosa debba sposarsi in stato
interessante...
In segno di “penitenza” la peccatrice non poteva
sposarsi con l’abito bianco e quel che è peggio, non durante la messa grande
bensì a quella delle 8 del mattino… come se dovesse nascondere chissà quale
colpa o infamia.
Questo nonostante Bice, la madre
di Rosa, si batta per difendere la figlia da quell’umiliazione. Nella sua
saggezza, infatti, Bice afferma che Rosa e Tonino: “Hanno seguito una legge
naturale”… quella cioè che porta un uomo ed una donna che si amino ad unire
oltre che i loro corpi, anche i cuori.
Ma malgrado l’intransigenza del
sacerdote, che viene percepito come uno che “sembrava contro di loro”,
la comunità accoglie e festeggia i due senza assurdi moralismi… a riprova di
come, tante volte, la cosiddetta povera gente possieda un cuore ben più ricco.
In Inseguendo un toast la
protagonista (Nara) è una ragazza che alle soglie del diploma assiste
all’irruzione all’interno della nostra lingua di varie parole straniere.
“Parole di lingue diverse erano
inserite qua e là con una certa noncuranza, nonchalance appunto, da persone
ricercate nei loro discorsi. Vocaboli come cocktail, sandwich, yogurt,
pass-partout, reception, suite, knock-out ed altri ancora, venivano usati a
profusione.”
Subisce questa irruzione anche
quel mondo rurale a cui Nara appartiene e che Franca sa dipingere con
affettuosa ironia. Ma quel che colpisce la fantasia di Nara e delle sue amiche
è la parola “toast”, alimento di cui lei e la sorella si toglieranno lo sfizio
a Milano.
La pagina in cui le due sorelle e
compagne d’avventura sbarcano alla stazione centrale della metropoli lombarda,
beh, a me ha ricordato la gag di Totò e Peppino in un famoso film… con in più,
da parte delle ragazze della provincia veneta, una grande compostezza, un… aplomb
di tutto rispetto.
Del resto: “Contrariamente alle
sue abitudini, Nara lasciò un pourboire.”
Molto bello l’incontro di Nara
con alcuni ragazzi delle borgate romane da lei incontrati “quando, con la
solita valigia, modello emigrante, Nara scese dall’autobus in Via Appia
Nuova.”
In Viaggio a Roma Nara
presenta questi ragazzini senza pesanti finalità pedagogiche; del resto, loro
non le mancarono di rispetto anzi la scortarono “a destinazione, in Via Appia
Antica, dove la stavano aspettando.”
In Ragazza alla pari troviamo
Nara a Bruxelles. In seguito alla tragica alluvione del 4 o 5 novembre del 1966
la Nostra perse l’impiego che aveva a Ca’ Tiepolo ma nella capitale belga sa
farsi benvolere; inoltre acquisisce “un buon livello di conoscenza del francese
parlato e scritto.”
Il carattere di Nara:
quando M.me Dumais (la donna del cui bebè si occupa) si pone come intermediaria
tra lei ed un suo lontano parente… ed inoltre si offre di trovarle un impiego
presso l’ambasciata italiana… ma a quel punto Nara opta per il rientro in patria.
Forse altre donne avrebbero colto
quelle occasioni al volo: un possibile marito (probabilmente ricco) ed un
lavoro sicuro… ma non Nara, che volle rimanere padrona della sua vita. E lo
rimase.
Benché i racconti di Borgo siano
tutti in italiano, ogni fa tanto fa capolino anche il dialetto veneto, con
effetti devo dire spesso molto divertenti.
Per es., in Comari si
parla di uomini ormai attempati che riprendono a “vardarse”, guardarsi
(attorno). Ma: “Tanto cossa voto che i trova? Più de qualche gallinassa
vecia, gnanca più bona per el brodo, no ghe xe altro in giro!” Più di
qualche vecchia gallina, neanche più buona per fare il brodo, in giro non c’è
altro!”
Franca mi scuserà se la mia traduzione non è abbastanza
accurata; del resto, spesso i dialetti possiedono un’incisività che talvolta
alla lingua manca. Tuttavia io ho capito sempre almeno il senso delle frasi in
veneto.
In Nina e Baldo troviamo
una famiglia il cui capo (?) beve troppo e picchia la moglie, tanto che “un
infausto giorno sono intervenute le assistenti sociali togliendo loro le
figlie.”
Questi dell’alcol e della
violenza domestica sono problemi che in varie parti del Paese rendono la vita
di molte famiglie un inferno, ma Franca ha saputo affrontarli evitando
d’assumere “abiti” morbosi o scandalistici… ma senza per questo dimostrare
superficialità o fatalismo.
2/a parte
Per ragioni di spazio non posso
parlare di tutti i racconti di Borgo, comunque ora vorrei ricordare Parole,
in cui Franca cede la… parola alla signora Elena Zerbin.
La signora appartiene ad un tempo
in cui, come scrive: “Non si conosceva nemmeno una stuffa a legna e si poteva
anche contrarre il tifo ma: “Allora si pagava tutto, medicine e pure
l’ospedale.”
La vita, nella valle del Po, era
durissima: si lavorava nelle risaie, anche: “Dieci campi di risaia, come dire,
melma si zappava! Non ci conoscevamo se eravamo persone o bestie: tutti
pieni di terra sporca. E a fine anno quando andavamo a fare i conti col
padrone, eravamo rimasti in debito.”
La drammaticità di questo quadro
era poi simile a quella di tantissime famiglie operaie e contadine del nostro
Paese e questo, per tanto, troppo tempo. Così è fondamentale che certe realtà
siano ricordate e denunciate da chi le visse sulla propria pelle e non cede
alla tentazione o alla menzogna del “bel tempo antico.”
La signora Elena ricorda inoltre
il suo sicuro rifiuto del nazifascismo quando dice: “Dentro di me non mi
sentivo per quel fare, mi sentivo ad essere alleata con tutti e
aiutarsi nel modo più umano della nostra vita.”
Ecco, forse è questa la sintesi
migliore sia del suo breve scritto che delle prose di Franca: questo sentimento
di umanità e di giustizia che rifugge dalla retorica, dalla violenza e
dall’inganno perché si desidera ardentemente un mondo più giusto… che non sia
insomma né una giungla né una caserma.
3/a ed ultima parte
Ciò che costituisce la parte più
autentica di uomini e donne oggi anziani e che furono duri ed umili lavoratori,
è questo profondo sentimento e desiderio di una vita migliore: una vita cioè
che non punta certo a lussi, applausi e riverenze ma solo a potersi godere in
pace i frutti del loro lavoro coi loro cari, senza essere più tormentati dagli
spettri della fame, della guerra e dell’ingiustizia… che purtroppo, ai nostri
giorni sono ben più che spettri!
Per quegli anziani ed anche per
noi, una vita migliore significa davvero “aiutarsi nel modo più umano”; il che
non significa né correre come dannati per ammassare più danaro possibile,
magari calpestando gli altri né vivere nell’ozio.
No, vuol dire fare in modo che
ognuno possa avere qualcosa in proporzione a quanto ha fatto ed a quanto gli
spetta.
Spesso è difficile, a volte
sembra quasi impossibile esprimere con parole chiare queste più che legittime
aspirazioni: ma quali mezzi possiamo utilizzare se non le parole? E
talvolta quelle possono essere fraintese: non sempre in buona fede.
Ma come dice benissimo Franca:
“Elena, abbiamo scritto le nostre parole. Ora si sono incamminate. Non
conosceremo il loro percorso. Sicuramente non cesseranno, mai più, di vivere.”
E questo è verissimo: soprattutto quando si tratta di parole che nascono dall'esperienza e dal cuore di persone generose.... persone che oltretutto non hanno subito la vita ma hanno cercato di capirne il senso, hanno tentato (secondo me con successo) di ricomporre quello che spesso sembra un puzzle assurdo, incomprensibile e talvolta anche crudele.
sabato 8 dicembre 2012
La discussione filosofica (parte settima)*
Ma anche quanto detto finora su sensibilità e dimensione
intuitiva dell’artista presenta il classico rovescio della medaglia, l’altra parte dello specchio o come vogliamo dire.
Infatti, proprio il complesso e
spesso contraddittorio sentire dell’artista può presentarsi come il suo
punto debole, poiché si fonda su elementi se non irrazionali almeno a-razionali
o meta-razionali, che quindi non si oppongono necessariamente alla
dimensione logico-razionale…
Ma nella mente e nel cuore
dell’artista gli altri elementi premono con tutta la loro drammaticità
ed urgenza fino a non fargli considerare la dimensione appunto
razionale, fondamentale e forse, neanche tanto auspicabile.
Egli, infatti, vede (o crede
di vedere, ma in campo artistico questa distinzione ha davvero poca importanza)
lati che prescindono dalla razionalità o che la superano.
Inoltre, l’importanza della fantasia,
della creatività, il ruolo insomma che nella creazione artistica riveste
l’aspetto ludico, di gioco1, tutto questo può condurre l’artista
o a credere egli nelle sue creazioni.
O ad instillare negli altri
l’idea che esse siano reali.
O ad entrambe le cose.
Comunque non dimentichiamo quella
che per me (e forse anche per tanti e tante) deve essere la stella polare della creazione artistica… come diceva
infatti il Socrate di Platone: “Un poeta per essere veramente tale deve
scrivere per immagini e non per deduzioni logiche.”2
L’artista che crei così cioè
in modo, come potrei dire, oltrelogico sarà davvero un artista perché
sapràabbandonarsi alla forza
della sua ispirazione senza temere di passare per un adolescente, un folle, un
ingenuo, un romantico fuori tempo massimo o chissà che altro ancora.
Le creazione di quel tipo
di creatore (ovviamente bisognerà giudicare anche la qualità, il valore delle
sue opere) saranno così fonte o occasione di godimento estetico, di sogno e di
stimolo anche sul piano filosofico.
E la natura non logico-razionale
dell’opera d’arte e dell’artista era del resto provata e difesa da un uomo ben
poco incline a concessioni romantiche come Kant, che scrisse: “Il genio
è il talento (dono naturale) che dà la regola all’arte.”3
Questa frase sintetizza la
convinzione fondamentale di Kant rispetto al problema estetico: non può
esistere alcun criterio oggettivo del gusto, che non può essere inculcato
da argomenti, tesi, ragionamenti, prove ecc.
Infatti, l’opera d’arte è libera
da qualsiasi regola o complesso di norme e “il genio stesso non può mostrare
scientificamente come le idee si trovino in lui.”4
Note
Le precedenti parti di questo
post sono comparse su questo blog rispettivamente: la 1/a il 25 /03/2008; la
2/a il 4/4/2008; la 3/a il 17/6/2010; la 4/a l’11/10/2011, la 5/a il
27/11/2011; la 6/a il 15/11/2012.
1) E’
stato osservato che nel caso per es. di un’opera di Joyce come l’Ulisse il
suo “modello (non solo strutturale) era quello del poema eroicomico in
prosa. Così: “Il modello è sempre il medesimo: anche Finnegans Wake è
un poema eroicomico in prosa; troppo spesso ci si dimentica che alla base delle
due opere maggiori di Joyce vi è un elemento ludico, di gioco, di divertimento.
Anzi, questo elemento è ancora più accentuato in Finnegans Wake, dove la
parodia diviene struttura portante sul piano linguistico.” Giorgio Melchiori, Introduzione
a James Joyce, Finnegans Wake, Mondatori, Milano, 1982, p.XI.
Cfr. anche G. Melchiori, “I funamboli
del romanzo: il manierismo nella letteratura inglese da Joyce ai giovani arrabbiati, Einaudi, Torino, 1974, pp. 48-64.
2) Platone,
Fedone, Garzanti, Milano, 1980, IV, p. 77.
3) Immanuel
Kant, Critica del giudizio, Laterza, Roma-Bari, 1982, p. 166.
4) I
Kant, Critica del giudizio, op. cit., pp. 166-167.
Per una trattazione più sistematica ed esaustiva di questi temi in Kant cfr.
almeno Ibid., pp. 134-221.
lunedì 26 novembre 2012
“La casa dei ricordi”, di Fabio Melis
Questo bel libro di Fabio Melis
ha come sottotitolo Una storia cagliaritana, che però lui ha avuto il
merito di non circoscrivere solo all’ambiente sardo ed appunto cagliaritano.
Egli ha insomma utilizzato la sua (che è anche la mia) città come
specchio o lente per scrutare il mondo.
Pare che una volta Tolstoj abbia
detto: “Parla di Parigi e sarai provinciale; parla del tuo villaggio e sarai
universale.”
Penso che intendesse dire che
data la fondamentale (benchè non assoluta) somiglianza dei sentimenti e delle
passioni umane in tutto il mondo, uno scrittore che sia dotato di
talento saprà descrivere gli uni e le altre partendo da una realtà anche
piccola… per poi allargare il suo sguardo sul mondo.
Ed è proprio quello che ha fatto
Fabio.
Ora, al protagonista della
storia, Andrea Manca, tocca un compito davvero ingrato: occuparsi della vendita
della casa di famiglia. Per lui (e forse per tanti di noi) quella non una
casa ma la casa.
Quella in cui sei cresciuto e che
ti ha visto trasformarti dal bambino che eri in uomo. La casa in cui hai visto
invecchiare e morire i tuoi genitori… il luogo che ha custodito gli
affetti, accolto le nascite, l’amore ma che ha anche covato scontri, noia,
solitudine.
Su tutte le figure del libro
spicca quella della madre di Andrea, Letizia… una figura di donna forte e molto
dolce ma nello stesso tempo quasi tragica. La dimensione appunto tragica di
Letizia risalta soprattutto da come, progressivamente, lei viene fagocitata da
un grave disturbo della personalità… al quale peraltro Fabio accenna con
evidente dolore ma anche con grande pudore.
Di lei, che aveva come solo svago
l’esecuzione al piano di brani di musica classica, Fabio scrive: “Il pianoforte
le fatto compagnia sino all’ultimo, quando è rimasta sola coi suoi ossessivi
ricordi e non veniva neanche più l’accordatore a donare un po’ d’armonia e
dolcezza al suono del suo strumento. E’ stato allora che la sua melodia… si è
lentamente involuta in un’atroce agonia.”
Ecco, queste frasi sono così
struggenti nella loro bellezza che non saprei proprio commentarle… preferisco
evitare.
Inoltre, finchè la signora stava
bene, aveva un modo d’essere che ad Andrea ricordava L’onorevole Angelina,
il grande personaggio interpretato dalla grandissima Anna Magnani:
“Determinata, generosa, libera, creativa, amante della giustizia, simpatica e
spontanea.”
Da La casa dei ricordi emerge
il quadro di una famiglia felice ma la cui felicità non è sempre piena o
assoluta, una famiglia in cui si scherza e si discute molto (per es. di Brera
ed anche di Pasolini) e che tutto sommato, vive in armonia ed è piuttosto
unita.
In casa Manca c’è tutto il
necessario, ma benché il capofamiglia sia uno stimatissimo professore di liceo, si è ben
lontani da quel vivere (come talvolta dice qualcuno che dovrebbe documentarsi
meglio) al di sopra delle proprie possibilità che viene rimproverato
alle famiglie italiane.
Dai Manca si vive dignitosamente
ma la loro vita è fatta di economie, lavoro, rinunce. E’ una vita quindi non di
lusso ma di sacrificio.
Molte delle cose di cui parla Fabio sono tipiche della nostra
generazione: per esempio il programma radio Alto gradimento coi suoi
stralunati personaggi, l’annuncio pubblicitario della Stock di Trieste
che precedeva l’altra trasmissione radiofonica, la calcistica Tutto il
calcio minuto per minuto.. che con mio padre, seguivo anch’io.
Appartengono un po’ alla nostra
generazione anche Gigi Riva, Corto Maltese, i Beatles, l’allunaggio ecc. ma
Fabio ha “reso” tutto ciò con affetto ma senza lacrimosa nostalgia. Non si
tratta insomma di un libro solo per noi che ormai siamo negli anta!
Inoltre, luoghi, fatti e persone
di quegli anni sono presentati in un modo che risulterà chiaro anche a chi è
molto più giovane, o non cagliaritano.
N.B: le stesse frasi o battute in
sardo o in dialetto cagliaritano sono tradotte.
Vorrei dire ancora tanto ma è meglio di no: leggete questo libro, che sa
dire parecchio da solo… leggetelo, non ve ne pentirete.Ah, dimenticavo, Fabio: chapeau!
giovedì 15 novembre 2012
La discussione filosofica (parte sesta)*
Ora, io credo che talvolta certi artisti
più che tanti filosofi di professione possano pervenire ad una profonda
comprensione di problemi storico-sociali, relativi all’etica, alla natura della
conoscenza, dell’amore e dell’odio ecc.
Forse ciò accade perché la loro passionalità
e la sfera dei loro sentimenti, delle loro emozioni ed il complesso delle
loro sensazioni è più viva che in altri.
Così, l’inquietudine che li muove
agisce probabilmente come una sorta di potentissima lente d’ingrandimento del
reale, o come un raffinatissimo strumento in grado di captare o decifrare la
natura intrinsecamente complessa di quel mondo che Gramsci definiva “grande e
terribile e complicato.”1
Nel dir questo penso a Poe ed
al suo forte interesse per l’orrore e
la violenza che talvolta esplodono in modo del tutto imprevedibile nel quotidiano
(pensiamo almeno agli Assassinii della Rue Morgue), ma anche a come
Thoreau, il teorico della disobbedienza civile presentiva l’avvicinarsi della meccanizzazione
dell’uomo.
Penso al travaglio di Dostoevskij
per il dolore dei bambini, tanto che nei Fratelli Karamazov leggiamo che
non sarebbe lecito “mettere alla tortura anche soltanto un piccolo essere”:
nemmeno se con ciò si potesse “rendere definitivamente felici gli uomini.”
Se cioè con questo si potesse far sparire per sempre dal mondo il male,
l’ingiustizia ed ogni angoscia ed insomma portare per così dire il Paradiso in
terra.2
Penso col Piovani a come
scrittori quali Proust, Kafka e Joyce
siano assimilabili a un “palombaro che sondi”.3
L’artista, infatti,
esplora profondità psicologiche ed esistenziali che tanti filosofi di
professione sarebbero tentati di fissare in categorie concettuali rigide,
quindi ben poco dialettiche ed insomma non del tutto filosofiche.
Ancora, la grande capacità intro-spettiva
degli artisti, la loro capacità di saper guardare dentro le cose, al
loro interno, davvero nel loro in-timo è stata rappresentata al meglio dal Dostoevskij
dei Ricordi dal sottosuolo...
In quel particolarissimo romanzo (che è insieme invettiva, confessione e demolizione d'ogni e troppo consolatoria visione estetica o filosofica), il protagonista afferma la propria
esigenza di isolamento ma non di solitudine
Egli afferma inoltre l'esigenza di voler difendere la
sua individualità da masse che perlopiù non sarebbero composte da esseri
realmente coscienti… e che perciò non costituirebbero ancora una società. Eppure, come potrebbe un misantropo come questo vivere in società?
Il Dedalus di Joyce può comunque dimostrare se non “rigore scientifico” almeno un certo grado di “intuizione” e
di persuasione.4
Note
* Le precedenti parti di questo post sono comparse su questo blog
rispettivamente: la 1/a il 25/03/2008; la 2/a il 4/4/2008; la
3/a il 17/6/2010; la 4/a l’11/10/2011, la 5/a il 27/11/2011.
1) Antonio
Gramsci, Lettere dal carcere, a Giulia, 18 maggio 1931, Editrice
L’Unione Sarda, Cagliari, 2003, p.243.
2) Cfr. Charles Journet, Il male. Saggio teologico, Borla, Torino, 1963, p.220.
3) Pietro Piovani, Principi di una filosofia della morale, Morano, Napoli, 1972, p.13.
2) Cfr. Charles Journet, Il male. Saggio teologico, Borla, Torino, 1963, p.220.
3) Pietro Piovani, Principi di una filosofia della morale, Morano, Napoli, 1972, p.13.
4) Umberto Eco, Il
problema estetico in Tommaso D’Aquino, Bompiani, Milano, 1982, p.152.
La stima di Eco per Joyce dipende qui dall’analisi che Dedalus conduce attorno
al termine claritas come si trova nell’Aquinate; cfr. J. Joyce, Dedalus,
Mondatori, Milano, 1986, pp.248-249.
sabato 13 ottobre 2012
Qualche scemenza su qualcosa che non lo è
Lo metti
tra i raggi della tua bicicletta,
tra le speranze inacidite,
le tue carte e i tuoi ricordi…
lo metti
e a volte lo trovi
in progetti che non realizzerai,
lo cerchi
e non lo trovi
in incubi senza consolazione…
è il bacio di una ruspa a forma
di nostalgia,
è un angelo e a volte un vampiro.
Me ne cibo
ma devo assassinare il mio
orgoglio,
è un vecchio orsacchiotto
che sogna fiumi in cui non sa
nuotare
ma ti offre il suo salvagente,
gli piace cantare
quando non hai altra musica che
un rauco silenzio.
Penso che quando sarò troppo
vecchio, stanco
ma ancora abbastanza affamato
e sarò magari un barbone
o un moderno tipo di monaco
lo metterò
in un sacchetto di carta
e mi sdraierò da qualche parte
a mangiarlo,
l’amore.
venerdì 31 agosto 2012
On the road again (di nuovo sulla strada)
Come tanti, anch’io viaggio d’estate… cioè quando con la
famiglia siamo liberi dal lavoro e dalla scuola; secondo me, quella è la
stagione ideale per visitare e gustare panorami.
Certo, può esserci il problema
del caldo. Per questo spesso scegliamo climi e Paesi freschi.
Fosse per me, che non soffro proprio il caldo, potremmo
andare in vacanza anche nel Sahara… o giù di lì. Solo, dubito che la mia famiglia
gradirebbe!
Bene, finora abbiamo visitato
soltanto l’estero, ma ci tengo a sottolineare che prima o poi non ci dispiacerà
per niente visitare anche l’Italie.
Il nostro patrimonio
storico-artistico è tra i migliori del mondo: ma forse il fatto di conoscerlo
(voglio dire a livello di studio, precedenti e singoli viaggi, internet,
giornali ecc.) può forse renderlo scontato mentre ovviamente, non lo è.
Bene, tra i Paesi da me-noi finora visitati, ho sempre
apprezzato quelli latini… per via della mentalità e del modo di essere, che ho
sempre trovato in sintonia con noi del Belpaese.
Ricordo infatti che nel 1996 a
Toledo la guida spagnola ci disse (criticandola un po’) che a Siviglia la gente
diceva spesso mañana, domani;
come a volte si pensa che facciano i messicani…
Ma forse, spesso si volge in
caricatura una tendenza dello spirito latino ed anche mediterraneo a
prendere le cose con calma, non ad evitare di farle.
Gli antichi Romani dicevano festina
lente, affrettati lentamente; eppure conquistarono e civilizzarono quasi
tutto il mondo allora conosciuto.
Un giornalista svedese raccontava
che durante un suo soggiorno in Tunisia doveva fare delle cose urgenti
all’ufficio postale. Così entrò trafelato nell’ufficio in questione, ma
l’impiegato disse: “Prima di tutto, buongiorno.”
Ecco, non è detto che la velocità
e l’efficienza debbano farci trascurare la cortesia o trasformarci in robots
che corrono come schegge impazzite. Velocità, efficienza e cortesia possono
star benissimo insieme.
Nel caso poi della Spagna, ho
avvertito un’affinità particolare non solo col carattere italiano, ma anche con
ciò che caratterizza noi sardi… cioè un’apparente lentezza.
Il nostro scrittore Giuseppe
Dessì diceva in Sale e tempo (cfr. G. Dessì, Un pezzo di luna,
Edizioni della torre, Cagliari, 1987, p.41) che gli aveva fatto
perdere del tempo solo l’ansia di perderlo.
Egli spiegava che una volta
libero dagli obblighi e dai doveri impostigli da genitori, insegnanti ecc.,
capì che la sua non era (ciò di cui lo accusavano) pigrizia ma volontà e
capacità di guardare le cose, gustarle, ricrearle nel suo cuore e nella sua
mente. In tal modo padroneggiandolo, quel benedetto tempo…
Del resto, come mi faceva notare
giorni fa in Olanda un mio anziano conterraneo (certo dotato di competenze nel
lavoro contadino), spesso quando ammiriamo l’efficienza e l’organizzazione
agricola olandese, non dobbiamo scordare l’influenza che su tutto questo
esercita il clima.
Piogge per almeno 3/4 dell’anno;
di conseguenza, pascoli abbondanti; temperature che a parte il periodo invernale
non sono mai troppo rigide… né calde o torride durante il resto dell’anno.
Su quest’ultimo punto, molti
amici di Nuoro città (e dintorni) mi hanno sempre detto che da loro, in
Barbagia, in inverno nevica parecchio ed il clima è molto freddo almeno fino ad
aprile.
Poi, in circa metà della Sardegna
(da Oristano in giù) la primavera e l’estate fanno registrare temperature che
vanno dai 20 ai 35 gradi abbondanti… e con piogge davvero scarse, in confronto
alla media olandese.
Certo, agli olandesi dobbiamo riconoscere
qualcosa che non può derivare dal clima, intendo programmazione economica, studio e conoscenza del territorio,
utilizzo dei mezzi tecnici e finanziari senza sprechi né ruberie, inesistenza
di tangenti e corruzione, bassa evasione fiscale ecc. Non mi sembra poco!
Ma se anche qualcuna di queste
ultime cose dovesse esistere, non impedisce il buon funzionamento delle cose.
Sul piano del carattere un
mio amico (memore del Montesquieu de Lo spirito delle leggi e dei luoghi)
sottolinea come il clima influenzi appunto il carattere ed i costumi
degli esseri umani. I climi freddi ci chiudono nell’ambito della nostra
famiglia o al massimo di ristrette cerchie d’amici.
Quelli caldi ci invitano
alla vita all’aperto, nelle piazze, nelle strade, ci rendono più espansivi
anche verso gli sconosciuti.
E’ questa, prosegue l’amico, una
caratteristica dei latini e dei mediterranei.
Condivido la sua tesi, ma con qualche riserva: amici ed alcuni
miei nipoti, che hanno lavorato e lavorano tuttora a Dublino, in Irlanda, mi
parlano dei locali proprio quasi come se fossero italiani, spagnoli, greci ecc.
Il mio amico Max, valente
chitarrista, durante le sue scorribande rock-alcolico-musicali (sulle altre massimo
riserbo) mi ha dipinto i bretoni con colori latino-mediterranei. Eppure, la
Bretagna si trova nel nord della Francia.
Io ho conosciuto gente di Parigi
molto affabile; altrettanto dicasi d’alcuni inglesi e tedeschi.
Ma certo, da un punto di vista generale
direi che esista un’influenza del clima sul carattere.
Io, per esempio, mi sento molto latino ma ho spesso dei momenti in
cui mi estranio da tutto e da tutti per immergermi nei miei pensieri, nei miei
sogni ed anche in qualche… incubo. Sì, perché ci sono anche quelli: se
vuoi il sogno non puoi schivare l’incubo; troppo comodo, cocco!
Proseguiamo.
Arrivati
all’isolotto di Marken, la nostra guida (il sig. Ben Stipe) ci ha raccomandato
di non fare chiasso.
Questa raccomandazione sarebbe
stata inutile per degli olandesi, per dei tedeschi, danesi ecc., ma utilissima
per dei latini (però forse noi sardi possediamo un certo autocontrollo). In
effetti, noi che abitiamo da Parigi in giù, con la nostra espansività potremmo
risultare fastidiosi ad occhi e ad orecchie nordiche.
Vedete, Marken è stata fino ad un
po’ di tempo fa una cittadina di gente di mare e di pescatori… e non per hobby.
Tantissima parte del territorio
olandese è stata letteralmente sottratta al mare o comunque a corsi d’acqua che
la percorrevano, la solcavano e circondavano… mettendo non di rado a rischio
l’esistenza della terra e la vita delle stesse persone.
Per me, nella lotta condotta sia
dall’antica che dalla moderna gente d’Olanda contro il mare, è stato creato un prodigio di fronte al quale
sfigurano perfino le piramidi.
Ora a Marken non si vive
più di pesca: secondo Ben, almeno l’80% dei suoi abitanti lavora ad Amsterdam o
alla sua periferia. Ma quando l’abbiamo visitata noi (a ferragosto) erano tutti
in ferie e chi si trovava in casa aveva bisogno di riposare. Da qui la
raccomandazione del buon Ben.
Marken… casette in legno molto
basse risalenti ad alcuni decenni fa ma perfettamente curate, inoltre disposte
su alcune file a ragionevole distanza le une dalle altre, verde ovunque,
vialetti perfetti, le barche anch’esse disposte secondo un ordine quasi
geometrico (sarebbe il caso di dire… spinoziano!), nessun tanfo di nafta
né (perfino) di salsedine, nessun frastuono di radio né di tv, nessuno che
trincasse o urlasse per strada…
Poi, in un bar in rigoroso legno
marinaresco, ho visto delle foto degli antichi abitanti…
Quelle foto, che
risalivano a fine ‘800 inizio ‘900, mostravano della gente fiera, anche dura;
mostravano uomini, donne ed anche bambini dalla facce scavate dal lavoro, dal
gelo e dal vento.
Perfino i bambini avevano un’aria
indifferente all’obiettivo… ma nello stesso tempo, quasi spaurita. Ed in quelle
foto, non sorrideva nessuno.
Ecco, io ho trovato questo molto
interessante: perché gente come quella aveva ben poco da sorridere e
vedere quei volti mi ha dato una certa tristezza… uomini, donne, bambini: tutti
condannati, se volevano vivere (ma era vita?) a tantissimi stenti ed a
parecchie privazioni; condannati, non di rado, anche alla morte.
Ad un livello più generale, ho
pensato a perché mai nelle foto si debba (quasi per forza) sorridere.
Io, poi, “esco” sempre con una smorfia a metà tra Jack lo squartatore ed una
maestrina dell’’800.
Comunque, dopo Marken siamo
tornati ad Amsterdam.
Ma racconterò questa storia un’altra volta.
venerdì 3 agosto 2012
L’ultimo mandante (Bologna, 2 agosto 1980- Bologna, 2 agosto 2…)
Per molti era il senatore;
per qualcuno, il paracadutista.
Ma per tutti era il dottore:
sì, un titolo quasi umile, quest’ultimo… ma lui coltivava una sottile, ipocrita
umiltà.
Anni prima aveva pubblicato il
saggio Sul valore del male in cui sosteneva che non era difficile essere
onesti, altruisti, sinceri ecc. ma che tutto ciò era “bovino, asinino, tipico di chi teme la vita e non sa assaporarla.”
Era scoppiato uno scandalo così
decise di interrompere la propria carriera di saggista; si era trattato del suo
solo passo falso.
Ma da allora aveva iniziato a
tessere i fili della sua oscura ed in apparenza poco redditizia ragnatela, che
per sua scelta non l’aveva condotto (per decenni) ai vertici del potere.
Ed
aveva i suoi dossiers, le sue intercettazioni, registrazioni, foto, video,
documenti ecc.
Perché tenere sotto controllo il
tenentino, lo scribacchino di provincia, il sindaco di paese, l’industrialotto?
Questo gli chiedevano i suoi amici.
Che domande!
Lui sentiva che il
tenentino sarebbe diventato generale, l’industrialotto un grande imprenditore;
il sindaco, ministro o boss di una grande banca; lo scribacchino, influente
opinionista tv.
E non sbagliava quasi mai.
Al momento giusto quei piccoli
sarebbero diventati grandi, utili e ricattabili.
Ed aveva capito che se sali
troppo, quando cadi sei finito.
Molto meglio stare in basso…
Da
dove puoi osservare la caduta dei grandi, magari attutire la loro caduta ed
aiutare a salire gli ancora piccoli… così avrai la riconoscenza e l’appoggio
degli uni e degli altri ed accumulerai potere… che utilizzerai al momento
giusto.
Importante non puntare
all’esercizio diretto del potere ma stare nell’ombra, prendere e/o
fingere di prendere accordi, progettare nuove alleanze da intrecciare alle
vecchie, essere severi custodi degli antichi valori ma entusiasti sostenitori
dei nuovi.
Certo, ogni tanto il Paese aveva
bisogno di qualche scappellotto: come aveva scritto qualcuno, da noi “lo stragismo”
è stata la modalità normale di gestione del potere… almeno dai tempi del
Valentino, tanto ammirato da Machiavelli!
Che cosa non avevano fatto, loro…
Poi non era importante (e forse
neanche possibile) stabilire chi fossero, appunto loro…
I vari dominatori che si
erano succeduti alla guida del Paese dal Medioevo ad oggi, le tante mafie, la
massoneria, i servizi segreti deviati?
I vertici di polizia, Chiesa,
industria, magistratura, media, sindacati compiacenti?
Terroristi d’ogni colore,
intellettuali da salotto, artisti vanesi o deliranti?
Sì, loro erano tutto questo e molto
più di questo.
E trovavano ulteriore forza
pescando in quella zona grigia priva di qualsiasi confine e consistenza…
che così dava sempre più il Paese in mano a loro: oxfordiani o francescani di
fuori, banditi di strada di dentro. E per sempre.
Sì, ogni tanto qualcuno urlava il
suo no! Gente come Gramsci, Pasolini, Falcone e Borsellino. Ma erano
pochi e stroncarli, facilissimo.
In un Paese in cui quasi tutti
temono più di passare per fessi che risultare assassini, cavernicoli, erotomani
o ladri, loro avrebbero regnato in saecula saeculorum.
Ed ogni tanto una bella strage, lo
scappellotto teneva il Paese buono per 15-20 anni.
Negli ultimi tempi lui aveva
finalmente accettato incarichi importanti: prima a Bruxelles poi nel governo
italiano.
Ora, a 40 (o erano 50?) anni
dalla strage di Bologna era ministro della difesa ma stranamente, aveva
iniziato a provare una nuova sensazione… come di rimorso, se non di pentimento.
Molti di quelli che avevano tramato con lui erano morti… ma non tutti. E
lui era il mandante più potente: anche perché aveva tutto quel materiale…
Forse era arrivato il momento di
spezzare quella catena di menzogne, depistaggi, massacri e connivenze che
durava da un tempo schifosamente infinito.
Padre Mario era stato chiaro:
“Senza riparazione non può esistere assoluzione. Insomma, vada a dire
tutto quello che sa, che ha fatto e che ha fatto fare,
assassino!”, aveva concluso urlando.
‘sti preti che parlano come
guerriglieri sudamericani!, aveva pensato lui, stizzito. Ai vecchi tempi aveva
prestato la sua consulenza d’esperto torturatore in Argentina ed in Cile…
Ma il gesuita aveva ragione,
doveva parlare.
Ora l’aveva fatto e tutto
era stato messo a verbale, ma capì subito che provava vergogna, non rimorso o
pentimento. Avrebbe voluto pentirsi ma non ci riusciva.
Ormai il cancro gli lasciava solo
altri 2 mesi, presto avrebbe dovuto presentarsi davanti ad Autorità ben più
potenti e scaltre di lui.
Dovrò bruciare all’Inferno, pensò
con amarezza.
Improvvisamente ebbe una chiara
visione del nulla che era nonché una lacerante percezione della sua
inumanità e di tutta la morte che aveva causato.
Invocò disperatamente il dono del
pentimento, che però non venne; pensò che era giusto così perché in fondo,
anche ora, cercava solo una via di scampo.
Ma stavolta non ci sarebbe stato
nessun depistaggio o cavillo, prescrizione, falsa testimonianza, ragion di
Stato, immunità diplomatica, aereo che lo trasportava in Paesi compiacenti nè nient’altro di simile.
Stavolta era solo e disperato.
E lo sarebbe stato per sempre.
In questa e nell’altra vita.
Per l’eternità.
Iscriviti a:
Post (Atom)