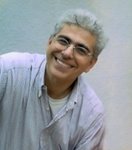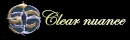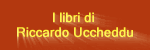venerdì 3 agosto 2012
L’ultimo mandante (Bologna, 2 agosto 1980- Bologna, 2 agosto 2…)
Per molti era il senatore;
per qualcuno, il paracadutista.
Ma per tutti era il dottore:
sì, un titolo quasi umile, quest’ultimo… ma lui coltivava una sottile, ipocrita
umiltà.
Anni prima aveva pubblicato il
saggio Sul valore del male in cui sosteneva che non era difficile essere
onesti, altruisti, sinceri ecc. ma che tutto ciò era “bovino, asinino, tipico di chi teme la vita e non sa assaporarla.”
Era scoppiato uno scandalo così
decise di interrompere la propria carriera di saggista; si era trattato del suo
solo passo falso.
Ma da allora aveva iniziato a
tessere i fili della sua oscura ed in apparenza poco redditizia ragnatela, che
per sua scelta non l’aveva condotto (per decenni) ai vertici del potere.
Ed
aveva i suoi dossiers, le sue intercettazioni, registrazioni, foto, video,
documenti ecc.
Perché tenere sotto controllo il
tenentino, lo scribacchino di provincia, il sindaco di paese, l’industrialotto?
Questo gli chiedevano i suoi amici.
Che domande!
Lui sentiva che il
tenentino sarebbe diventato generale, l’industrialotto un grande imprenditore;
il sindaco, ministro o boss di una grande banca; lo scribacchino, influente
opinionista tv.
E non sbagliava quasi mai.
Al momento giusto quei piccoli
sarebbero diventati grandi, utili e ricattabili.
Ed aveva capito che se sali
troppo, quando cadi sei finito.
Molto meglio stare in basso…
Da
dove puoi osservare la caduta dei grandi, magari attutire la loro caduta ed
aiutare a salire gli ancora piccoli… così avrai la riconoscenza e l’appoggio
degli uni e degli altri ed accumulerai potere… che utilizzerai al momento
giusto.
Importante non puntare
all’esercizio diretto del potere ma stare nell’ombra, prendere e/o
fingere di prendere accordi, progettare nuove alleanze da intrecciare alle
vecchie, essere severi custodi degli antichi valori ma entusiasti sostenitori
dei nuovi.
Certo, ogni tanto il Paese aveva
bisogno di qualche scappellotto: come aveva scritto qualcuno, da noi “lo stragismo”
è stata la modalità normale di gestione del potere… almeno dai tempi del
Valentino, tanto ammirato da Machiavelli!
Che cosa non avevano fatto, loro…
Poi non era importante (e forse
neanche possibile) stabilire chi fossero, appunto loro…
I vari dominatori che si
erano succeduti alla guida del Paese dal Medioevo ad oggi, le tante mafie, la
massoneria, i servizi segreti deviati?
I vertici di polizia, Chiesa,
industria, magistratura, media, sindacati compiacenti?
Terroristi d’ogni colore,
intellettuali da salotto, artisti vanesi o deliranti?
Sì, loro erano tutto questo e molto
più di questo.
E trovavano ulteriore forza
pescando in quella zona grigia priva di qualsiasi confine e consistenza…
che così dava sempre più il Paese in mano a loro: oxfordiani o francescani di
fuori, banditi di strada di dentro. E per sempre.
Sì, ogni tanto qualcuno urlava il
suo no! Gente come Gramsci, Pasolini, Falcone e Borsellino. Ma erano
pochi e stroncarli, facilissimo.
In un Paese in cui quasi tutti
temono più di passare per fessi che risultare assassini, cavernicoli, erotomani
o ladri, loro avrebbero regnato in saecula saeculorum.
Ed ogni tanto una bella strage, lo
scappellotto teneva il Paese buono per 15-20 anni.
Negli ultimi tempi lui aveva
finalmente accettato incarichi importanti: prima a Bruxelles poi nel governo
italiano.
Ora, a 40 (o erano 50?) anni
dalla strage di Bologna era ministro della difesa ma stranamente, aveva
iniziato a provare una nuova sensazione… come di rimorso, se non di pentimento.
Molti di quelli che avevano tramato con lui erano morti… ma non tutti. E
lui era il mandante più potente: anche perché aveva tutto quel materiale…
Forse era arrivato il momento di
spezzare quella catena di menzogne, depistaggi, massacri e connivenze che
durava da un tempo schifosamente infinito.
Padre Mario era stato chiaro:
“Senza riparazione non può esistere assoluzione. Insomma, vada a dire
tutto quello che sa, che ha fatto e che ha fatto fare,
assassino!”, aveva concluso urlando.
‘sti preti che parlano come
guerriglieri sudamericani!, aveva pensato lui, stizzito. Ai vecchi tempi aveva
prestato la sua consulenza d’esperto torturatore in Argentina ed in Cile…
Ma il gesuita aveva ragione,
doveva parlare.
Ora l’aveva fatto e tutto
era stato messo a verbale, ma capì subito che provava vergogna, non rimorso o
pentimento. Avrebbe voluto pentirsi ma non ci riusciva.
Ormai il cancro gli lasciava solo
altri 2 mesi, presto avrebbe dovuto presentarsi davanti ad Autorità ben più
potenti e scaltre di lui.
Dovrò bruciare all’Inferno, pensò
con amarezza.
Improvvisamente ebbe una chiara
visione del nulla che era nonché una lacerante percezione della sua
inumanità e di tutta la morte che aveva causato.
Invocò disperatamente il dono del
pentimento, che però non venne; pensò che era giusto così perché in fondo,
anche ora, cercava solo una via di scampo.
Ma stavolta non ci sarebbe stato
nessun depistaggio o cavillo, prescrizione, falsa testimonianza, ragion di
Stato, immunità diplomatica, aereo che lo trasportava in Paesi compiacenti nè nient’altro di simile.
Stavolta era solo e disperato.
E lo sarebbe stato per sempre.
In questa e nell’altra vita.
Per l’eternità.
martedì 17 luglio 2012
Un’estate piena di…
Auguro un’estate piena di…
lavoro stabile, diritti e
giustizia sociale a chiunque sia precario, disoccupato o anche occupato ma a
rischio licenziamento (non per sua colpa).
Spero che ovunque vadano i
turisti trovino, oltre al riposo ed al divertimento, anche strutture e
personale che li introduca alle particolarità ed ai “misteri” che ogni terra
racchiude.
Ciò ha a che fare (oltre che con
mare, laghi, montagne e divertimenti vari) anche con la storia e cultura di
quei luoghi.
Forse questo riguarda soprattutto
il patrimonio artistico del nostro Paese (uno dei più grandi del mondo!) la cui
cura potrebbe inoltre creare tanti posti di lavoro.
Speriamo in tanti investimenti,
studi, ricerche e progetti per quel patrimonio…
Naturalmente, in questo momento il
mio pensiero va… soprattuttissimamente al patrimonio storico-artistico
dell’Emilia-Romagna!
Oltre che (in modo altrettanto naturale) alle sue
popolazioni…
Ancora. Come ricorda Guido
Liguori, “lo storico statunitense John M. Cammett ha raccolto una bibliografia su
Gramsci tra il 1922 ed il 1993 di oltre diecimila titoli.”1
Bene, dal ’93 quella bibliografia
è probabilmente cresciuta. Ma in Italia gli studi su Gramsci cioè su un uomo
ormai studiato e da tempo in tutto il mondo, non sono più tanti.
E quest’ultimo punto è stato in
effetti riconosciuto proprio qui, a Cagliari, nel corso di una recente presentazione del
Dizionario gramsciano, dallo stesso Liguori (presidente
dell’International Gramsci Society Italia).
Ora, mi sia perdonata
un’autocitazione, “segnalo che il 19 ottobre 2007 presso l’istituto di studi
filosofici di Napoli è stata presentata l’edizione in lingua cinese delle
Lettere dal carcere.”2
E proprio qui in Sardegna abbiamo
uno studioso come Gianni Fresu che sul pensiero di Gramsci ha pubblicato un
testo sistematico, rigoroso ed insieme scorrevole.3
Qualche citazione da Gramsci, che
su punti rilevanti della dimensione storica, sociale e culturale (e non solo
culturale in senso accademico) prova tutta l’attualità del suo pensiero.
Sulla mediocrità intellettuale e
morale di tanti politici italiani, il Nostro scrive: “Non hanno il senso
dell’universalità della legge”, infatti “sono gli ultimi relitti di
un’italianità decrepita, uscita dalle sètte, dalle logge (…). Un’italianità
piccina, pidocchiosa, che contrappone all’autorità dispotica dei principotti
una nuova autorità demagogica non meno bestiale e deprimente.”4
E nel condannare il salasso di soldi
pubblici ad esclusivo vantaggio di pochi privati, egli osservò che
così nascono “elefantiaci bambinelli industriali, che vivono solo in quanto
abbondantemente sfamati dall’erario nazionale.”5
Ed i nostri governanti?
Bisogna che s’adattino a queste
condizioni: essi non sono responsabili dinanzi a un partito che voglia
difendere il suo prestigio e quindi li controlli e li obblighi a dimettersi se
deviano; non hanno responsabilità di sorta, rispondono del loro operato a
forze occulte, insindacabili, che tengono poco al prestigio e tengono
invece molto ai privilegi parassitari.”6
E potremmo continuare…
Aggiungo solo questo: in Gramsci,
oltre ad un livello sociale e storico-filosofico (quello più chiaramente
riscontrabile nei Quaderni, ne La questione meridionale ecc.) e
ad un livello autobiografico ed
introspettivo (le Lettere) si trovano vari altri livelli…
Livelli che per così dire sposano
la dimensione pubblicistica con una anche saggistica, se non addirittura
filosofica “forte.”
Al riguardo si leggano almeno
scritti come Odio gli indifferenti7, L’ indifferenza e La
storia8, La storia è sempre contemporanea9, Cocaina10 ecc.
Io credo che tutto ciò si trovi
anche in scritti di taglio soprattutto giornalistico (qui penso soprattutto a
quelli raccolti in Sotto la Mole (1916-1920).11
Ed anche su questo (ma a Gianni
ne ho accennato) penso che ci sia molto da lavorare; nel mio piccolo, per non
dire nel mio minuscolo, ci sto provando.
Perciò: un’estate piena di tante e durature soddisfazioni a tutti gli
studiosi e gli editori che vorranno riprendere ad occuparsi del grande
pensatore e rivoluzionario!
Spero poi che quest’estate
contenga un n° pressoché infinito di micidiali ceffoni per: mafiosi, speculatori finanziari, licenziatori senza
giusta causa;
chi trattò con la mafia;
razzisti, pedofili, stupratori,
trafficanti d’armi e di droga;
usurai, torturatori,
guerrafondai, fanatici religiosi e terroristi in genere;
violatori delle norme di
sicurezza sul lavoro e costruttori “disinvoltini.”
Passando ad altro cioè in
particolare a me…
In questo momento sto ascoltando
l’ultimo disco di Springsteen, Wrecking ball. Clarence Clemons, Big
man è morto da 1 anno e spesso, ora quando ascolto zio Bruce provo
tristezza.
Va bene, sarà ridicolo provare un
sentimento come questo per uno che non ho mai conosciuto di persona; sarà
assurdo affezionarsi ad un musicista… rock, oltretutto. Sarà da adolescenti molto
fuori tempo massimo; in effetti, tra soli 50 anni ne compirò 100!
Be’, pazienza: perché il sax di
Clemons mi ha sempre sollevato da terra.
Quando ascolto il solo di Jungleland
e Bru canta di una strada in fiamme “in un autentico valzer di
morte/ sospesa tra la carne e la fantasia”… ed i poeti/ cercano di resistere/
ma cadono infine feriti/ non ancora morti,/ stanotte, nella giungla
d’asfalto”…12
Bene, a quel punto l’arte, la
visione, la musica (la mia follia, se volete) mi porta oltre ed
altrove, laddove cioè il dolore sparisce… almeno per un po’.
Sarà ridicolo, da scemi ecc.
sentire tutto questo quando si ascoltano certe canzoni, ma a chi trova una
goccia nell’amaro, non importa.
Spero che sotto il mio ombrellone
ci siano molte di quelle gocce: anche perché spesso il mio amaro guasta
l’armonia di chi mi sta attorno.
La mia stessa armonia,
poi, è una vita che la guasta.
Insomma, è una vita che mi guasto
l’armonia.
Tutto chiaro, no?
Quest’estate spero di trovare
anche qualche goccia di storia: infatti le voci dei fantasmi d’alcuni minatori
cominciano a farsi sentire in modo piuttosto insistente…
A presto, perché (nonostante
l’estate) cercherò di continuare ad infestare il mio e spero anche i vostri
blog.
Note
1) Riccardo
Uccheddu, Introduzione a Antonio Gramsci, Lettere dal carcere, Davide Zedda
Editore, Cagliari, 2008, p.7, n.2, appendice di
Stefania Calledda.
2) R.
Uccheddu, Introduzione a A.Gramsci, Lettere dal carcere, op. cit.,
p.7, n.2; cfr. poi Liberazione, 18/10/2007, p.10.
Il corsivo è mio.
3) G.
Fresu, Il diavolo nell’ampolla, La Città del sole, Napoli, 2005.
4) A.
Gramsci, La scimmia giacobina, in Id., Piove, governo ladro!, a c. di
Antonio A. Santucci, Editori Riuniti, Roma, 1996, p. 83.
5) A.
Gramsci, Il regime dei pascià, in Id., Piove, governo ladro!, op.
cit., p.113.
6) Ibid.,
p.113. I corsivi sono miei.
7) A.
Gramsci, Odio gli indifferenti, in Id., Odio gli indifferenti,
Instant Book Chiarelettere, Milano, pp.3-6.
8) Cfr.
rispettivamente A. Gramsci, L’indifferenza, in Id., Piove, governo
ladro!, op. cit., pp. 59-60 e nello stesso vol. citato
La storia, pp. 60-62.
9) A. Gramsci, La storia è sempre
contemporanea, in Odio gli indifferenti, op. cit., pp.54-56.
10) A. Gramsci, Cocaina, in Id., Piove,
governo ladro!, op. cit., pp. 100-103.
11) Id., Sotto la Mole (1916-1920), Einaudi,
Torino, 1960.
12) B. Springsteen, Tutti i testi con
traduzione a fronte, a c. di Guido Harari, Arcana editrice, Milano,
1985, pp.114-115.
sabato 2 giugno 2012
Vivere interi
Mario era seduto al tavolo di
cucina; si sentiva sereno.
Gli ultimi tempi erano stati
brutti: amici bravissimi a fingersi tali, donne troppo fredde, lavori
mal pagati ed anche umilianti. Parenti perfettini e sprezzanti; in definitiva,
insopportabili. E Dio un po’ troppo distratto.
Bevve il caffè con calma e dopo
una decina di minuti passò all’acquavite.
Pioveva. Fuori, pioveva,
ma c’era stato un tempo in cui aveva abitato in case in cui pioveva anche dentro.
Accese la radio e pescò You
can’t get always what you want dei Rolling Stones… non puoi ottenere sempre
quello che vuoi. Verissimo.
Gli piacevano, le Pietre
Rotolanti, con quelle chitarre sporche ed essenziali; a Mario piaceva
soprattutto Keith Richards. Gli Stones: l’ultima forma di civiltà (o quasi) prima che il
mondo sprofondasse nel caos.
Continuava a piovere.
Di solito nei films o nei romanzi
quando qualcuno se ne sta da solo in una sera di pioggia, sembra sempre (o
quasi) alle prese con ricordi o pene più o meno struggenti d’amor perduto.
Lui no. Per lui quando
l’amore finiva doveva essere archiviato e stop. Stop.
“Stranissimo, questo, da parte di
uno che si è laureato in lettere con una tesi sui poeti provenzali”, commentava
Veronica.
“Il massimo del cinismo”, diceva
invece, lapidaria, Mariuccia.
Che cosa dicesse poi Albertina,
lui non l’aveva mai capito: parlava, parlava, parlava ed alla fine gli sembrava
che non avesse detto niente.
Altra acquavite, grazie.
Mario pensò che per avere quasi
50 anni poteva sembrare inconsueto il fatto che avesse avuto solo 3 donne,
comunque non gli importava: secondo lui l’amore era sopravvalutato.
Squillò il telefono, era il dr.
Congiu.
“Salve, caro professor Atzeri.
Come sta?”
“Starei benissimo se coi vostri
cavilli legali non mi aveste tagliato gli ultimi compensi.”
“Un momento, carissimo…”
Carissimo?!
“Come lei senz’altro saprà, fare
da cavia non è una prassi ufficialmente riconosciuta: quindi eventuali
ritardi (non tagli ) nei pagamenti dipendono da una questione di
prudenza. Sa, il ministero della salute si trova in causa con quello della
giustizia, perciò al momento non possiamo esporci troppo. Ma riconosciamo tutti
il coraggio e la costanza da lei dimostrate sia nel donare il sangue che nel
farsi asportare e/o installare diversi blocchi di memoria e di percezione. E le
abbiamo appena inviato un assegno di 35 euro. E’ contento?”
Mario chiuse la comunicazione.
Era umiliante fare da cavia in
ospedale ed in vari laboratori: perfino i medici, i
ricercatori e gli infermieri avevano ancora verso gente come lui certe antiche
prevenzioni… quando tutti sapevano che le cavie erano ergastolani,
pazzi, malati terminali di aids o comunque “soggetti socialmente
pericolosi.”
Ma lui era soltanto un
disoccupato, sia pure laureato. Ci mancava solo ‘sto scemo che lo trattava come
un ragazzino a cui si dava la paghetta! Perché non ci provava lui, a dare il
sangue 6-7 volte al mese e a farsi frugare il cervello?
Mario decise d’uscire: col suo lasciapassare poteva attraversare 3 quartieri della città, poi nel suo era stata aperta una clinica clandestina che pagava il
sangue anche 6 euro e 20, anziché i soliti 5 e 90 degli ospedali legali. Certo,
nei “legali” non ti beccavi virus ed infezioni varie, ma diciamo la verità: al
giorno d’oggi chi poteva permettersi di sputare su 30 centesimi in più?
Il bar di Nello era deserto,
eppure lui gli offrì gratis un bicchiere d’acqua, del pane e 5 olive. Gli
disse soltanto: “Prometti che non ti farai impiantare nuovi blocchi di memoria
o frammenti di percezione di qualcun altro.”
“Nello, quella è chirurgia
psichiatrica sperimentale: ti danno anche 7 euro e 80 a blocco. Se poi ti
fai fare almeno 2 elettroshock, becchi altri 20 euro.”
“Bravo, così entro 2 anni diventi
una specie di deficiente! Semmai, fatti levare un rene oppure 2 dita.”
“Ho 49 anni, sul mercato i miei
reni o le mie dita non valgono granchè.”
Con la sua parrucca viola si
avvicinò Gina che lo fissò per tanti, troppi secondi poi disse: “Vuoi sposarmi,
Pierre? Ti amerò sempre ed anche per sempre.”
Lui rispose di no con tutta la
gentilezza di cui era capace quindi salutò lei e Nello, si alzò ed uscì dal
bar.
Una volta fuori, perso o
abbandonato al gelido vento che veniva dal mare, Mario fissò il porto in rovina
da cui, anche a distanza di anni continuava ad arrivare la puzza di nafta e di
fumo… che però una volta era stato profumo di lavoro.
Provò rabbia e rimpianto per
quello che era stato e che non era più ed insieme, trovò inutili le idee stesse
di rabbia e di rimpianto.
Perso nel nauseante tanfo della
salsedine, della nafta, delle alghe marce e nel dolce-amaro dei ricordi, gli
venne quasi da piangere.
E poi che mondo era, quello in
cui la gente solo per sopravvivere era costretta a trasformare il proprio corpo
e la propria mente in un magazzino vivente di pezzi di ricambio?
Squillò il cellulare, era Gina.
“Che fai, Pierre?”
“Niente. Penso. Cammino e penso.
Penso, ricordo, immagino, sogno… cose così.”
La comunicazione si interruppe.
Succedeva sempre più spesso, negli ultimi tempi: sentivi un “clic” quasi
impercettibile poi cadeva la linea.
Ma non si poteva parlare di controllo:
“tecnicamente” eravamo ancora in democrazia. Il parlamento esisteva ancora,
anche se si riuniva perlopiù per festeggiare il Natale, Halloween e le vittorie
della nazionale ai mondiali di calcio. Esistevano ancora le libertà di stampa,
opinione, riunione ecc., benché sottoposte alla “tutela” di prefettura,
ministero degli interni e polizia.
Certo, la Costituzione (in seguito alle stragi di
Torino e di Roma) era stata “temporaneamente” sospesa nel 2140; quella
sospensione durava però da 15 anni.
Mario entrò in una gelateria,
ordinò un sorbetto che la ragazza al banco gli servì con aria piuttosto tesa
per poi dirgli: “Senta, consumi in fretta perché stiamo chiudendo. Aspetti,
aspetti, ci sono le ultime notizie alla netv.”
Mentre sullo schermo scorrevano
le immagini di combattimenti alternate a spogliarelli, una voce concitata
disse: “La notizia del giorno è che il presidente del consiglio è stato
riconosciuto colpevole anche nell’ultimo grado di giudizio. Il pm ha dimostrato
che quando il presidente era ministro degli interni (negli anni compresi quindi
tra il 2135 ed il 2138) organizzò una task-force di militari e uomini dei
servizi segreti che scatenò le stragi di Torino del 2137 e di Roma del 2138, in
cui morirono 192 innocenti. Ricordiamo i provvedimenti da lui presi:
“sospensione temporanea per motivi d’ordine pubblico” della Costituzione,
scioglimento dei sindacati, ripristino della pena di morte, ricorso “limitato”
alla tortura. Ma… notizia d’agenzia! Il presidente si è appena suicidato! Scusate,
controlliamo lo share perché deve essere schizzato alle stelle!”
Allora la ragazza sintonizzò su un sito
più serio.
Il commentatore, in effetti
compassato, quasi ingessato stava dicendo: “I ministri degli interni e della
giustizia si sono appena dimessi, quello della difesa e lo stesso presidente
della repubblica sono irreperibili dalle 9 di stamattina; si sospetta che il
ministro della giustizia abbia coperto le stragi del ’37 e del ’38. Penso che
entro poche ore si dimetteranno tutti i membri dell’attuale governo: possiamo
quindi ritenere che al momento, il Paese si trovi senza alcuna guida
politico-istituzionale. Cedo ora la parola al nostro politologo, il prof Loni. Salve, professore. Ci dica, come vede la situazione?”
“Salve a lei ed a tutto il nostro
pubblico, dottor Tonelli. Beh, più che di situazione parlerei di caos:
il peggiore degli ultimi 200 anni. Il governo si è sgretolato, sono state
accertate le tremende responsabilità del presidente nelle più sanguinose stragi
della repubblica ed intanto, il gen. Narduzzi ha assunto tutti i poteri e fatto
schierare “a difesa” (dice lui) della capitale 20mila soldati. Questo folle ha ordinato
la chiusura dello spazio aereo su tutto il territorio nazionale nonché il
coprifuoco e la legge marziale.”
“Si parla anche di certi gruppi
autodefinitisi Combattenti per la giustizia e la libertà che avrebbero
liberato varie città del centro-nord e di scioperi spontanei un po’ in tutta
Italia…”
“Sì, ma è tutto ancora incerto.
Saranno determinanti il controllo dei cieli e l’atteggiamento della
popolazione, che è stanca della lunga tirannide ma ancora molto spaventata e
confusa. Poi, non dimentichiamo che un regime in agonia può tentare i classici
colpi di coda…. Speriamo comunque di trovarci sulla strada che potrà ricondurci
alla democrazia…”
Loni non riuscì a proseguire
per la commozione.
La ragazza spense e mi chiese: “Ma… allora…. Che cosa devo
fare, il coprifuoco c’è o non c’è… ed il regime è davvero finito? Io mica lo
so, come devo regolarmi!”
“E’ sicura di non saperlo? Ci
pensi: lei che cosa vuol fare?”
“Io? Voglio smettere d’aver
paura. Non voglio più passare il mio tempo a sentirmi come se fossi in gabbia;
sono stanca di vivere a metà, o anche a meno. Voglio… come dire, come dire”, sembrava
imbarazzata ma anche molto contenta, “vorrei vivere intera! Non so,
forse secondo lei ho detto una scemenza”, concluse con un filo di voce.
“Una scemenza? Per niente,
proprio per niente”, rispose Mario, ammirato.
Quindi pagò ed uscì.
Dal porto veniva il solito tanfo,
ma che adesso era più sopportabile; molto più sopportabile. In quel
momento a Mario parve che la vita fosse di nuovo intera.
martedì 1 maggio 2012
Giovanni, Antonio e Marco (3/a e ultima parte)
Così, forse dopo quella massima
non occorrono ulteriori ricorsi ad antiche o anche a moderne analisi
filosofiche, sebbene ritenga che dagli illuministi (qui penso soprattutto a
Rousseau) a Marx fino ai giorni nostri i concetti di diritto, giustizia,
uguaglianza ecc. siano stati fortemente sottolineati e difesi (sia pure non
sempre con risultati straordinari sul piano pratico).
Ma vorrei ricordare, almeno en
passant come nel 1600, in un’Europa ed in un’Olanda ancora devastate da
guerre, persecuzioni e controversie religiose di vario tipo e natura, Grozio avesse ben chiaro che per “ingiustizia”
si deve intendere “ciò che contrasta necessariamente con la natura razionale
e sociale.”1
E Hegel segnalava quanto sia
negativo il prevalere (all’interno della vita sociale e statale) di interessi privati
o anche esclusivi o tipici di singoli membri della società civile.
“I membri appunto della società
civile sono anzi, come tali, quelli che hanno come movente prossimo il loro
interesse particolare e, come accade specialmente nel feudalesimo,
quello della loro corporazione privilegiata.”2
Da qui nasce in alcuni di essi
una forte indifferenza se non avversione per il bene comune, che
viene inteso come limitazione di quello personale. Da qui l’insofferenza
per il diritto, l’incomprensione o il rifiuto della dimensione intrinsecamente egualitaria
della giustizia ecc.
Per Hegel, quando si guarda (come
nel caso dell’Inghilterra del suo tempo) a Paesi in cui prevalgano idee come
quelle, si nota un complessivo ritardo… e questo appunto perché “la libertà
oggettiva cioè il diritto razionale, è anzi sacrificato alla libertà
formale e all’interesse privato particolare.”3
Ma non si tratta certo di negare
libertà ed esigenze dei singoli individui bensì d’impedire che esse
annullino o limitino gravemente libertà ed esigenze dell’insieme dei
cittadini, o quelle di consistenti fasce sociali e lavorative.
Purché quindi l’individuo
rispetti questa elementare regola di convivenza umana e civile, non sorge
nessun problema: una società degna di questo nome esiste realmente solo
se il tuo diritto non schiaccia il mio.
Per essere più chiari: “La
libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce agli altri. Così,
l’esercizio dei diritti naturali di ciascun individuo non ha altri limiti se
non quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di
quegli stessi diritti.”4
Certo, le sentenze che danno
torto non fanno piacere. Ma del resto, come notava Gramsci: “Ogni legge fatta
per l’utilità collettiva danneggia qualche singolo: ciò è ineluttabile. Il
codice penale danneggia enormemente i ladri e gli assassini.”5
Senza voler certo paragonare la
dirigenza Fiat alle categorie citate da Gramsci, ci auguriamo tutti che la legge
sia rispettata ed applicata: infatti la sua non-applicazione è quanto di
più antieconomico e di illogico possa esistere, poiché crea un malessere
sociale che non di rado può diventare ingovernabile ed impedire la stessa
attività industriale ed imprenditoriale.
Per non parlare del devastante
disagio che si causerebbe ai lavoratori: la parte più debole. Insomma, di tutto
abbiamo bisogno nel nostro Paese, già straziato dall’attuale crisi
economico-sociale, tranne che di veder compiersi un’inammissibile ed
incomprensibile negazione dei diritti appunto dei lavoratori.
Il caso quindi di Giovanni, Antonio e Marco è secondo me
una buona “spia” di una situazione che quando qualcuno voglia sottrarsi alle
regole democratiche e del diritto, può “recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana.”6
Perciò quel caso (come
anche altri che si sono già presentati o che dovessero presentarsi) va perfino oltre
una vicenda come quella, pur evidentemente molto dolorosa e
bisognosa di giustizia, trasfigurandosi fino ad assumere i tratti di una
questione di civiltà che interroga e riguarda tutti.
Anzi, secondo me le questioni di
civiltà urlano, così voglio sperare che sia i vertici Fiat che certi
settori del sindacato spesso poco ricettivi possano sentirlo, quell’urlo.
Perché come si chiedeva S.
Agostino: “Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?”,
cioè: “Bandita la giustizia, che altro sono i regni” (in questo caso per
“regni” possiamo intendere gli Stati e le società), “se non grandi associazioni
di delinquenti?”7
Note
1) Ugo
Grozio, Il diritto della guerra e della pace, Cedam, Padova, 2010, I, II, 3,
p.71. Il corsivo è mio.
2) G.W.F.
Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, Laterza,
Roma-Bari, 1980, vol.II, §544, p.514. I corsivi sono miei.
3) G.W.F.
Hegel, Enciclopedia, op. cit., §544, p.515. Il
corsivo è dell’A. Per un più specifico inquadramento del problema cfr. Ibid., pp.513-515.
4) Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino, art.4, in Rosario Villari, Storia
moderna, Laterza, Roma-Bari, 1973, p.353. Dobbiamo la Dichiarazione
ai “rappresentanti del popolo francese, costituiti in assemblea nazionale” il
26 agosto, quindi solo un mese dopo la Rivoluzione del 1789.
5) Antonio
Gramsci, Piove, governo ladro!, a c. di A. Santucci, Editori Riuniti,
Roma, 1996, p.28. Il passo citato è contenuto nell’articolo
intitolato L’esercente degli ubriachi, pubblicato il 28 marzo 1916.
L’art. in questione comparve anonimo (come vari altri) “tra il 1916 ed il 1918
nella rubrica ‘Sotto la mole” della pagina torinese dell’Avanti!” Cfr.
A. Santucci, Introduzione a A. Gramsci, Piove, governo ladro!,op. cit.,
p.12.
6) Costituzione
della Repubblica italiana, art.41.
7) S.
Agostino, La Città di Dio, Edizioni Paoline, Roma, 1979, IV, 4, p.215.
Ritroviamo questo passo di Agostino anche in una recente enciclica; cfr. Benedetto
XVI, Deus caritas est, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 28,
pp.58-59. Comunque l’attuale pontefice, che quando era prefetto
della Congregazione per la difesa della fede, l’ex-Sant’Uffizio avversò
qualsiasi progetto di trasformazione radicale delle strutture economico-sociali
(fu infatti un fiero oppositore della teologia della liberazione, soprattutto
di quella latinoamericana) considera strumento più valido o più completo
appunto la carità.
Ma trovo significativo almeno il fatto che egli abbia preso o
ripreso in considerazione il problema della giustizia, che sta alla base
di qualsiasi tipo di società: anche non cristiana né religiosa.
Giovanni, Antonio e Marco (parte 2/a)
Invece già da Platone1 per
continuare con Aristotele fino ad arrivare alla formulazione classica di giustizia
che dobbiamo ai giuristi romani… continuando nel 1600 con l’olandese Grozio
ecc., una linea giuridica, filosofica ed etica almeno bimillenaria ha
sempre posto al centro della sua riflessione l’idea della validità universale
della legge e dell’uguaglianza di fronte ad essa di tutti gli
uomini.
Per Aristotele: “Le leggi si
pronunciano su tutto e tendono all’utile comune.”2
Qui con leggi (nomoi)
egli intende non solo qualcosa di legale ma soprattutto di morale e
che va ad abbracciare una dimensione più ampia, più vasta, se appunto il Nostro
aggiunge che “noi diciamo ‘giusto’ ciò che produce e preserva la felicità, e le
parti di essa, nell’interesse della comunità politica.”3
Possiamo intendere il termine
“comunità politica” nel senso di società, insieme appunto organizzato ed
associato di uomini; in un senso quindi forse meno limitato di quello che diamo
oggi a “comunità politica” (insieme solo di partiti, istituzioni statali e
simili), comunque penso che sull’essenziale possiamo intenderci.
La legge non è comunque per
Aristotele mero fatto specialistico (confinato quindi in un ambito particolare
come la giurisprudenza) bensì autentico ponte sociale… e ponte in quanto
evita di porre o proporre barriere o muri tra gli uomini.
Barriere o muri che invece a mio
avviso nascono quando l’universalità della legge non viene riconosciuta. A quel
punto sorgono dei gruppetti di persone, di fatto dei privilegiati che coltivano
l’assurda e pericolosa convinzione di potersi esimere dall’osservanza della
giustizia… una noiosa faccenda a cui possono (eventualmente) sottomettersi in
base alla convenienza, all’estro del momento o anche dopo aver dimostrato altre
o ipotetiche doti o virtù.
Invece Aristotele definisce
l’applicazione ed il rispetto della legge come giustizia e come “virtù
completa”; anzi per lui la giustizia è la “virtù più eccellente.”4 E questo
perché “colui che la possiede è capace di servirsi della virtù anche nei
riguardi del prossimo, e non solo in relazione a se stesso.”5
Qui vediamo come Aristotele non
parli di semplice virtù personale, individuale ma intenda la giustizia
come qualcosa che dall’ambito individuale ed in fondo egoistico (comunque
socialmente sterile) si estende fino a raggiungere anche gli altri
uomini.
Superiamo così limiti ed ambiti
di varia natura, che spesso servono solo per giustificare egoismi, ottusità,
debolezze ecc.6
E Cicerone, benché come parecchi
Romani fosse scettico verso la filosofia greca o comunque verso una ricerca
culturale che non fosse direttamente collegata alla dimensione pratica,
tuttavia si occupò anch’egli dei temi che stiamo ora esaminando.
Così, per lui “siamo nati alla
giustizia” e “il diritto non è stato fondato per una convenzione, ma dalla
natura stessa.” Egli aggiunge: “E ciò sarà ormai chiaro, se esaminiamo la
società ed il legame reciproco degli uomini.”7
Tale legame, che unisce appunto
gli uomini in società, è per Cicerone la ratio, la ragione che al di là
delle differenze con cui essa è posseduta ed utilizzata da ogni singolo uomo,
“è certamente comune, differente per preparazione, ma eguale quanto
a facoltà di apprendere.”8
Il diritto, che è quindi
un elemento fondamentale proprio nel senso che fonda l’umana convivenza,
non può fare come se alcuni fossero totalmente privi di ragione da non essere
considerati appunto uomini. Da qui, come osserva benissimo Abbagnano,
Cicerone può passare a teorizzare l’uguaglianza tra gli esseri umani.9
Infatti, poiché ogni uomo è
dotato di ragione, ognuno di essi possiede una capacità oltre che intellettiva
anche pratico-sociale d’agire e di scegliere in funzione del proprio benessere,
così come possiede il diritto alla salvaguardia di quel benessere;
naturalmente, il tutto in ambito sociale e nel sicuro ed effettivo rispetto dei diritti e
del benessere altrui.
Ma non può esistere alcun
benessere ove esso non sia garantito dalla giustizia e da una reale uguaglianza…
quel che spetta ad ognuno di noi.
Mancando infatti quegli elementi
si avrebbe solo bellum omnium contra omnes, la guerra di tutti contro
tutti, per citare la nota formula dell’inglese Thomas Hobbes quando si
riferiva allo stato di natura… quello quindi in cui non sarebbero esistite o
non esisterebbero delle società o degli stati organizzati.10
Eccoci ora alla limpidissima
formulazione del grande Ulpiano (II sec. a. C.) per il quale: “La giustizia
consiste nella costante e perpetua volontà d’attribuire a ciascuno il proprio
diritto. I precetti del diritto sono questi: vivere onestamente, non
danneggiare gli altri, attribuire a ciascuno il suo.”11
Benché la mia analisi sia
esclusivamente morale e filosofico-sociale (non essendo io né un avvocato né un
giurista, un giudice ecc.) penso comunque che non rispettare determinate
sentenze e certi diritti non faccia altro che confliggere coi precetti di
Ulpiano, oltre che danneggiare in modo direi piuttosto evidente i 3 di Melfi.
Così
non trovo necessario (tanto mi sembra chiara) commentare la celeberrima massima
di Ulpiano.
Note
1) Platone,
La repubblica, Laterza, Roma-Bari, 1970, I, p.28 sgg.
2) Aristotele,
Etica nicomachea, Laterza, Roma-Bari, 2001, V, 1129 b, p.175.
3) Aristotele,
Etica nicomachea, op. cit., p.175
4) Aristotele,
Etica nicomachea, op. cit., p. 175.
5) Ibid.
I corsivi sono miei.
6) Cfr.
comunque Ibid., n. 418, p.488.
7) M.T.
Cicerone, Le leggi, Utet, Torino, 1992, I, 28, p.437. Il corsivo
è mio.
8) M.
T. Cicerone, Le leggi, op. cit., p.437. I corsivi
sono miei.
9) Nicola
Abbagnano, Dizionario filosofico, Tea, p.251.
10) T. Hobbes, Il
Leviatano, I, XIII. Non è qui importante, in un lavoro senza pretese di
tipo scientifico come un post, stabilire se la celebre frase, così come la non
meno celebre homo homini lupus cioè l’uomo è un lupo per l’altro uomo
(che risale a Plauto) sia originale di Hobbes.
11) Ulpiano, Digesto,
1. 1. 10. Il corsivo è mio.
Giovanni, Antonio e Marco (parte 1/a)
Giovanni Barozzino, Antonio Lamorte e Marco Pignatelli
sono 3 operai della Fiat (Sata) di Melfi. Giovanni ed Antonio sono delegati
della Fiom (Federazione italiana operai metallurgici), Marco è un tesserato
Fiom.
Fin qui niente di strano: sono
degli operai e fanno parte del sindacato dal quale si sentono maggiormente
tutelati
Ma sono stati accusati dalla
Fiat.
“L’accusa era di aver bloccato un
carrello_ cioè la produzione_ nel corso di uno sciopero indetto unitariamente
da tutte le organizzazioni sindacali.”1
Bene, la Corte d’assise di
Potenza ha dato ragione a loro ed alla Fiom, sì che: “Alberto Piccinini, uno
dei legali della Fiom, ha precisato che il reintegro è stato chiesto, e
ottenuto, per antisindacalità”; perciò ora, a norma di legge Giovanni,
Antonio e Marco devono essere (come ricorda Piccinini) “immediatamente
reintegrati” al lavoro.2
Molto importante: nelle motivazioni della
sentenza si legge che gli operai “non hanno avuto nessun gesto di sfida nei
confronti dell’azienda”, né dimostrato “nessuna volontà diretta a impedire
l’attività produttiva.”
Così, quei licenziamenti
rappresentano “nulla più che misure adottate per liberarsi di sindacalisti che
avevano assunto posizioni di forte antagonismo.” Quelle misure hanno quindi
recato “conseguente immediato pregiudizio per l’azione e la libertà sindacale.”
I giudici hanno poi rimarcato che
Giovanni, Antonio e Marco “hanno esercitato un “diritto costituzionalmente
garantito” come lo sciopero e ciò “senza valicarne i limiti.”3
Non meno severi sono stati i
legali della Fiom cioè oltre al già citato Piccinini, gli avvocati Focareta,
Grossi e Vaggi.4
Ma Giovanni, Antonio e Marco
hanno solo esercitato un loro diritto, peraltro sancito dall’art. 40
della Costituzione, ribadito dallo Statuto dei lavoratori nonché
dall’Oil (organizzazione internazionale del lavoro, in inglese Ilo).
E contro discriminazioni
antisindacali e comunque contrarie alla dignità dei lavoratori esistono del resto la
Carta sociale europea, la Carta di Nizza del 2000, il Patto Internazionale sui
Diritti Civili e Politici…5
Ora, in democrazia esiste una ben
precisa dialettica di doveri e di diritti; ma venendo lesi, feriti i
diritti, finiscono per sorgere delle situazioni ben poco democratiche, che
quindi si trovano in stridente contraddizione appunto con la democrazia.
E che mettono in discussione i
suoi stessi fondamenti.. perciò per evitare questo pericolo bisogna rispettare
i diritti. Sempre.
Purtroppo la Fiat ha comunicato
ai 3 operai la sua intenzione di corrispondere loro stipendi ed arretrati, ma
non di reintegrarli nel loro posto di lavoro.
Male, perché oltre ai diritti vanno
rispettate anche le sentenze: perfino quando danno ragione ad altri: non
ci sarebbe infatti proprio niente di straordinario nel rispettare delle sentenze che… ci
danno ragione!
Già il Socrate protagonista della
Repubblica di Platone difendeva, in modo solo apparentemente paradossale
l’esigenza e l’esistenza di regole di giustizia perfino tra i
delinquenti.6
E nel testo platonico leggiamo infatti che “l’ingiustizia fa nascere fra gli uomini odi e lotte mentre la
giustizia produce accordo e amicizia.”7
Inoltre la nostra Costituzione
dice chiaramente che: “L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.”8 E la
nostra Carta aggiunge che: “L’organizzazione sindacale è libera.”9
Pertanto l’esercizio di libertà sindacali non va soggetta a limitazioni,
punizioni, licenziamenti ecc.
E’ poi tutelato il diritto di
sciopero (art.40) ed un altro articolo recita che l’iniziativa economica:
“Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”10
Né tale “iniziativa” può ovviamente prescindere da “fini sociali” e
la stessa proprietà privata ha una “funzione sociale.”11
Con queste e consimili norme i Padri costituenti segnarono,
per l’Italia appena uscita dalla guerra e dalla barbarie nazifascista ed
anche per l’Italia futura una “rotta” democratica e fortemente orientata al
progresso sociale, alla giustizia ed alla difesa del mondo del lavoro.
Purtroppo, come scrive Andrea Pubusa, docente di diritto
amministrativo all’università di Cagliari, spesso si assiste ad uno
“svuotamento” delle Carte costituzionali, che rimangono in vigore solo in
teoria e vengono quindi di fatto ignorate.
Esempio di tale svuotamento sono per il Pubusa anche le:
“Libertà sindacali e la contrattazione collettiva.” Egli denuncia infatti una
palese violazione dell’art.39, concludendo che: “La storia insegna che uno
svuotamento di fatto delle Carte democratiche, se non c’è una forte reazione
delle forze progressiste, finisce solitamente in tragedia.”12
In modo analogo si è espresso Franco Ragusa, ricordando
quanti e quali articoli della Costituzione si trovino a rischio, ove
l’iniziativa economica dovesse mancare dei legittimi freni e prescindere dai
non meno legittimi fini.13
Insomma, i diritti dei lavoratori sono parte integrante
della loro dignità e sono garantiti dalla Costituzione e le sentenze dei
giudici vanno sempre rispettate ed applicate. Da tutti: anche da una
delle più grandi imprese del mondo.
Del resto, le imprese in questione potrebbero ricavare
dall’osservanza delle norme che regolano la vita in un Paese democratico, un
certo vantaggio sul piano del prestigio e dell’immagine.
Si dirà: ma il motto la legge è uguale per tutti è
antico, retorico ecc.
Però io con certe critiche… frenerei, perché uno
potrebbe pensare che c’è chi si considera legibus solutus cioè sciolto,
libero dalle leggi…
Il che avveniva nel Medioevo e fino al Re Sole, quando una
ristretta cerchia di persone (re, nobili, membri dell’alto clero e pochissimi
altri) riconosceva solo quel diritto che coincideva con propri privilegi e
benessere personale.
Note
1) Loris
Campetti, Melfi, il diritto torna in Fiat, Il manifesto, 24/02/2012, p.2.
2) L. Campetti, art. cit. I
corsivi sono miei.
3) Fiat
fu anti-sindacale, in www.lettera43.it 23/03/2012. Il corsivo è mio.
4) Licenziamenti
Melfi. Fiom: Fiat è arrogante, http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=163158
http://247.libero.it/focus/21408275/43/licenziamenti-b-melfi-b-fiom-fiat-arrogante/
26/03/2012. Le dichiarazioni dei legali Fiom si riferiscono alla volontà
comunicata dall’azienda di non reintegrare i 3.
5) Per
tutto questo cfr. Valerio Valentini, Tutte le norme che inchiodano
Marchionne, http://www.byoblu.com/post/2012/02/15/Tutte-le-norme-che-inchiodano-Marchionne.aspx
6) Platone,
La repubblica, Laterza, Roma-Bari, 1970, I, 350,351, pp.55-56.
7) Platone,
La repubblica, op. cit., p.56.
8) Costituzione
della Repubblica italiana, art.1. Il corsivo è mio.
9) Costituzione,
art.39. Il corsivo è mio.
10) Costituzione,
art.41. I corsivi sono miei.
11) Costituzione,
artt. 41 e 42.
12) A. Pubusa, Cambiando
la Carta democratica democrazia in bilico, Sardegna, 15/12/2011, p.4.
Il Sardegna è un quotidiano che si stampa a Cagliari.
13) Cfr.
Franco Ragusa, Se a Pomigliano è piovuto, a Mirafiori tira aria di tempesta,
http://www.riforme.net/editoriali/ed2010-19.htm
(27/12/210).
martedì 24 aprile 2012
“Le luci del ‘45”, di Antonia Arslan
Si tratta di un racconto di A.
Arslan, docente, saggista e scrittrice padovana d’origine armena. Le luci possiede,
nonostante l’epoca storica in cui si colloca e gli avvenimenti di cui si
occupa, una grazia particolare.
E’ come se l’Autrice avesse
ceduto la parola alla bambina che era in quegli anni: con tutta l’ingenuità ma
anche la tristezza che appunto una bambina poteva provare in un’Italia
straziata dalla barbarie nazifascista e dalle distruzioni della guerra.
Ma si tratta di un insieme di
emozioni, ricordi e sensazioni non certo infantili, direi invece piuttosto
maturi e consapevoli.
La vicenda si dipana dal febbraio
del ’45 nella zona di Dolo (a metà strada tra Venezia e Padova) ed il 25
aprile, quando la famiglia Arslan ritorna appunto a Padova.
Oltre alla piccola Antonia,
secondo me spicca la figura di nonno Yerwant, il patriarca della famiglia:
nobile figura di medico che gira la campagna in calesse e cura le persone per
poche uova… che accetta a malincuore.
Egli è amareggiato dagli orrori
della guerra e ricorda il genocidio del suo popolo, che decenni prima vide
trucidate dai turchi oltre un milione di persone.
Antonia dice con straordinario
candore: “Avevamo degli stretti golf a quadretti, fatti di lana ricuperata di
tutti i colori, e le guance rosse dal freddo.”1
In effetti, ancora molto tempo
dopo la fine della guerra molte famiglie italiane (boom o non boom) dovettero
fare parecchi sacrifici: sul vestiario (e non solo) quando per es. i fratelli o
le sorelle più grandi passavano ai più piccoli i loro vecchi maglioni, o
giacche, scarpe ecc.…
L’ingenuità dei piccoli Arslan fa
chiamare un aereo Alleato Pippo, comunque essi sono adorabilmente
lontani dai moralismi dei “grandi”. Infatti di Teresa, “la bambinaia che amava
molto i soldati”, perché come diceva: “Sono così bisognosi di affetto,
poverini, e io li consolo”2, non pensano niente di male.
Inoltre, nessuno si scandalizza
per le prostitute che all’alba sono ospitate per un pasto ed un po’ di fuoco
nella cucina della casa. Anzi, l’A. le presenta quasi come delle figure da
sogno, con parrucche, trucchi fantasiosi “e un bisbigliare di vocette
squillanti, come di uccellini.”3
E spesso una di loro, Noemi,
libera dagli abiti che doveva indossare per la sua attività, “si annodava in testa
un fazzoletto a scacchi” e con un grembiulone lavorava in casa Arslan. La
piccola Antonia dice: “E io la seguivo dappertutto, persa in ammirazione.”4
In questo rispetto, direi anzi in
questo affetto trovo un’eco, sia pure inconsapevole dell’atteggiamento assunto
da Cristo verso la Maddalena.
Ne Le luci troviamo anche
personaggi particolari, dei veri originali, figure stralunate di tipo quasi
felliniano come per esempio “Bugno Luigia”, per la quale (a circa 200 anni dalla
fine della potenza e dai fasti di Venezia) “la Repubblica Serenissima esisteva
ancora.”5
Nel racconto troviamo anche
dell’altro, che può risultare buffo ed anche tenero: per es., l’A. ricorda che
“con la seta bianca del paracadute” di Bob, un parà inglese, le avevano fatto
“il vestito per la prima comunione.”6
Ma Le luci testimoniano
anche la reale e rischiosissima solidarietà dimostrata dagli Arslan e
dai loro vicini per Bob, che non denunciano né consegnano ai nazifascisti ma
che anzi nascondono nel granaio.
La stessa Noemi, che in un’Italia
straziata da fame, bombardamenti, deportazioni, rastrellamenti, torture, saccheggi e
stupri vende il suo corpo per sopravvivere, perse in precedenza due gemelli
sotto un bombardamento ed ha il marito disperso in Russia.7
E la presenza, costante e mista a
terrore della morte è un elemento in apparenza nascosto di questo
testo… ma sempre ricorrente.
Così come la presenza della fame, che compare quando l’A.
ricorda che c’era chi finiva per mangiarsi i topi.8
Eppure, gli Arslan
nascondono e salvano (oltre a Bob) anche alcuni armeni.
Le luci prova come la
Resistenza al nazifascismo sia stata fenomeno non solo militare (benché sacrosanto)
ma qualcosa che ha inoltre goduto del sostegno e dei valori di tanta parte del nostro
popolo… che amava la giustizia, la pace, il lavoro e dimostrava la solidarietà
in modo concreto: spesso rischiando la vita ed altrettanto spesso, perdendola.
Del resto, molte zone strappate
ai nazifascisti vedevano sorgere varie iniziative oltre che politiche anche a
carattere sociale, scolastico, artistico, di partecipazione dal basso alla
gestione del territorio: quel che talvolta conduceva al recupero d’usi e
costumi direi di tipo comunitario.9
Torniamo ora alla piccola
Antonia. Il 21 aprile annuncia per il 30 (giorno del suo compleanno) la fine
della guerra; le crede solo nonno Yerwant: egli allude al dono della profezia,
che al suo Paese natale si ritiene appartenga spesso si bambini.10
Antonia sbagliò di poco perché il
25 avverrà la Liberazione e poi, curioso(!), la credenza del nonno è molto
vicina ad una simile ebraica.11
Ed il 25 aprile del ’45, come
sappiamo, il nostro Paese fu finalmente liberato dal nazifascismo ed in tutte
le case si accesero le luci; non solo quelle elettriche.
Note
1) A.
Arslan, Le luci del ’45, Corriere della sera, Inediti d’Autore, pp.11-12.
2) A.
Arslan, Le luci del ’45, op. cit., p.24.
3) A. Arslan,
op. cit., p.37.
4) Ibid.,
p.38.
5) Ibid.,
p.34.
6) Ibid.,
p.32.
7) Ibid.,
p.38.
8) Ibid.,
p. 35.
9) Roberto
Battaglia Giuseppe Garritano, Breve storia della Resistenza italiana,
Editori Riuniti, Roma, 1997, pp. 171-183 e pp. 225-226.
10)
A.
Arslan, op. cit., pp. 39-40.
11) Cfr. Elio Toaff, Perfidi
giudei, fratelli maggiori, Mondadori “Oscar”, Milano, 1990, p.109 e
Dr. A. Cohen, Il Talmud (1935), Laterza, Bari, 1989, p.162.
L’espressione, davvero odiosa “perfidi giudei”, era contenuta nella liturgia
del sabato santo; cfr. E. Toaff, Perfidi giudei, fratelli maggiori, op. cit.,
p. 219.
Lo stesso termine “giudeo”, anche quando non sia preceduta da
“perfido”, contiene fortissime connotazioni antisemite. Come ricorda Toaff, si
deve a Giovanni XXIII l’abolizione di questa sconcertante preghiera; cfr. E.
Toaff, op. cit., p. 219.
sabato 7 aprile 2012
Buona Pasqua!
Lo so, mancavo dal blog… e non da pochi minuti!
Ma un giorno qualcuno (eventualmente, me stesso) dovrà spiegarmi perché mai scriva tanti post che poi, per un motivo o per l’altro non ho:
il tempo;
o
la voglia di pubblicare.
Incapacità nel gestire il mio tempo?
Sovrabbondanza di idee?
Idee sovrabbondanti ma magari scarsucce dal punto di vista qualitativo?
Sfiducia in me stesso?
Paura dei venditori di uova pasquali?
Ecco, questa è un’eventualità che non avevo ancora considerato.
O che almeno non avevo ancora considerato fino a quest’ora… che mi convenga allora entrare nel racket dei dolciumi?
Perché scartare un’eventualità come questa?
Certo, preferirei entrare nel racket dei salumi, dei vini e delle birre, ma quando ormai si va per i 50, non è il caso di far tanto gli schizzinosi, no?
Be’, scherzi a parte auguro a tutte/i voi una Pasqua serena e piena di gioia… una parola, questa, che forse non prendiamo molto in considerazione.
Per non parlare del viverla!
I tempi… mi pare che diventino sempre più duri…
E non certo per colpa di tutta la povera gente che lotta ogni giorno per portare a casa un pezzo di pane e che invece, spesso a casa porta solo ansia, amarezza ed il terrore di perdere il suo lavoro.
Ed i suoi diritti… molte volte, c’è chi non riesce neanche a portare sé stesso a casa… vivo.
Speriamo che la resurrezione tocchi anche chi una crisi economico-sociale come questa, sicuramente la più devastante degli ultimi decenni, non ha di certo contribuito a crearla ma la sta solo subendo. Ogni giorno di più.
Buona Pasqua, comunque… e tante cose buone.
Soprattutto buone!
sabato 24 dicembre 2011
Natale in blues
Il blues parla di dolore, solitudine, razzismo, miseria, disoccupazione, inoltre parla anche del Diavolo, di alcol e di sesso.
Possiamo perciò escludere che i suoi versi siano natalizi…
O tradizionalmente natalizi.
Ma… ne siamo proprio sicuri?
Bisogna infatti capire di quale Natale parliamo.
Io immagino un’antica famiglia palestinese che in una terra dominata da truppe d’occupazione, dopo un lungo viaggio (in una notte d’inverno) va in cerca di cibo e di un tetto…
E si sente dire che non c’è posto.
Ancora oggi ci sono truppe d’occupazione e gente per la quale “non c’è posto”!
Io sento di lavoratori che per difendere il loro posto di lavoro stanno di notte su gru o comunque molto in alto a 7 sotto zero… come ieri, a Torino.
Erano lavoratori del servizio notturno dei treni: circa un migliaio di loro rischia il licenziamento, anche se pare che si troverà una soluzione. Pare…
Poi (che coincidenza, eh?!) leggo nel libro di F. Valentini, Sulle strade del blues che già negli anni ’30 negli Usa, erano “frequenti gli scioperi degli inservienti dei vagoni-letto, in maggioranza di colore.”
Penso allo spiritual Oh, happy day in cui si dice che Gesù mostrerà the way, la strada.
E ricordo che Martin Luther King affermò che per i suoi antenati schiavi gli spirituals erano una sorta di “codice”…
Gli ebrei erano loro, gli uomini che lavoravano in condizioni inumane nelle piantagioni; il faraone lo schiavista o il proprietario della piantagione.
Un altro famoso spiritual, Swing slow, sweet chariot parla di un chariot, un cocchio che probabilmente un veicolo che porterà in salvo e liberi gli schiavi.
Ancora: l’espressione to catch the train, prendere (o acciuffare) il treno significava nel gergo della cultura nera appunto la fuga o in ogni caso la soluzione di un grave problema pratico ed esistenziale.
Angela Davis spiegava bene come ciò che conta non sia un’astratta libertà quanto l’effettivo, reale processo di liberazione.
Infatti l’ex-schiavo Frederick Douglass si rifiutò di tenere un discorso in occasione del 4 luglio; rivolgendosi agli americani bianchi chiese giustamente: “Che cos’è, per lo schiavo americano, il vostro 4 di luglio? Le vostra grida di libertà ed eguaglianza, vana parodia; le vostre preghiere e i vostri inni, i vostri sermoni e i vostri ringraziamenti, le vostre parate religiose sono… magniloquenza, frode, inganno, empietà e ipocrisia.”
Di recente ho confrontato molte di queste mie opinioni con A. Portelli, il celebre americanista, che si è detto d’accordo con me.
Egli mi ha inoltre messo a disposizione un suo lavoro proprio su Douglass; grazie, prof!
B.B. King, il cui blues non mi sembra sia molto stimato, cantava in Why I sing the blues: “La prima volta che ho incontrato i blues
Fu quando mi portarono qui su una nave
C’erano uomini su di me; molti altri usavano la frusta
Adesso tutti vogliono sapere
Perché canto i blues…”
Forse lo spiritual e più tardi anche il blues furono dei codici che permisero la comunicazione tra i neri, in alcuni casi anche la fuga e (avrei voluto vedere il contrario!) anche delle rivolte armate.
Un uomo solo nella sua casa o nella sua baracca con in mano una vecchia chitarra o un’armonica non è insomma solo un poveraccio che canta storie di bad luck, sfortuna.
Un coro gospel che farebbe ballare anche i morti… beh, chissà che non lo faccia davvero!
Comunque…
E nonostante tutto…
Buon Natale e felice anno nuovo: non potrà andare male per sempre!
La schiavitù, anche quella moderna (per es. quella finaziaria) e più o meno elegantemente camuffata, finirà…
domenica 27 novembre 2011
La discussione filosofica (parte quinta)1
Ma la visione per così dire di “satanismo umano” o di superomismo, che da parte di chi la rifiuti o la contesti può essere considerata come blasfema, irrazionale o ridicola, è però sostenuta in Dedalus da una sorta di ammirazione per il non serviam di Lucifero.
Nel corso di una predica sull’Inferno (torniamo sempre lì!) tenuta dal gesuita padre Arnall,2 circa il peccato appunto di Lucifero si dice: “Quale fu il suo peccato, non siamo in grado di dirlo. I teologi ritengono che sia stato il peccato d’orgoglio, il pensiero peccaminoso concepito in un istante: non serviam, non voglio servire.”3
Per Dedalus-Joyce il non serviam è un’affermazione o una dichiarazione di libertà o meglio, di auto-liberazione.
Esso vien fatto valere contro qualsiasi legame con altri esseri umani, che è concepito come falso, ipocrita, opprimente, come qualcosa che mutila la sensibilità dell’artista e sfigura il senso e la bellezza della sua opera.
Tuttavia, ad un livello meno astratto o comunque più drammatico, alcuni punti di certe opere di Joyce rivelano il suo dolore o il suo senso di colpa per non aver voluto pregare per la madre morente, benché ribadisca comunque il non serviam.4
E nel dramma Exiles Bertha, la moglie di una altro suo alter-ego (lo scrittore Richard Rowan) lo chiama womankiller, uccisore di donne.5
Eppure Joyce si sposò, ebbe dei figli ed il rapporto con la moglie fu per lui sempre molto importante (benché forse esso fosse limitato al solo lato erotico-passionale). Egli frequentava altri letterati, da essi era stimato ed incoraggiato, addirittura ne scoprì qualcuno: pensiamo al nostro Svevo.
Inoltre, pare che anche nei confronti dei suoi antichi maestri gesuiti abbia mantenuto rapporti tutto sommato amichevoli.
Insomma, perfino Joyce aveva una certa difficoltà o felice incoerenza nel sostenere o vivere fino in fondo determinate convinzioni.
Tuttavia è evidente che con uomini come Schopenhauer, Poe, Joyce e comunque coi solipsisti una vera discussione filosofica è impossibile: persone come quelle o pensano che tu non esista, o che (anche se esisti) tu sia un… gigantesco somaro!
Del resto, lo stesso Joyce non riusciva a far capire la sua opera alla moglie ed anzi, talvolta lei assunse sia verso di lui che appunto verso le sue creazioni atteggiamenti provocatori, quando non apertamente provocatori.
Se partiamo da un dato che mi pare la critica considera ormai da tempo acclarato cioè la forte dimensione autobiografica degli scritti joyciani, ebbene allora dobbiamo riservare a certi passi di alcune opere del grande irlandese qualcosa di più che un interesse puramente estetico.
Per esempio in Exiles Bertha esclama: “Felice! Ma se non capisco niente di quello che scrive e non posso aiutarlo in nessun modo! A volte non capisco neanche la metà di ciò che mi dice!”6
Circa gli atteggiamenti provocatori o offensivi di sua moglie Nora ricordiamo che non appena uscì il primo dei capolavori del marito cioè l’Ulisse, Joyce gliene fece dono e lei subito (sotto l’apparenza dello scherzo) chiese ad un amico se fosse disposto a comprarglielo. Ciò provocò in Joyce vivo imbarazzo, imbarazzo che cercò di nascondere sotto uno stentato sorriso.
Note
1) Le precedenti parti di questo post sono comparse su questo blog rispettivamente: la 1/a il 25 marzo 2008, la 2/a il 4 aprile 2008, la 3/a il 17 giugno 2010, la 4/a l’11 ottobre 2011.
2) In realtà pare che Joyce abbia riportato una predica che fu pronunciata nel ‘600 da un gesuita italiano.
3) James Joyce, Dedalus, Mondadori, Milano, 1986, pp.152-153.
4) Cfr. Introduzione a Ulysses, in J. Joyce, Ulisse: Telemachia. Episodi I-III, a c. di Giorgio Melchiori, Mondadori, Milano, 1983, p.XXV; J. Joyce, Ulisse, Mondadori, Milano, 1985, pp.769-773. Per il riferimento al peccato d’orgoglio di Lucifero cfr. Ibid., p.772.
5) Il biografo di Joyce Richard Ellman osserva come l’epiteto in questione fosse stato usato già prima dalla moglie Nora Barnacle, quindi nella realtà; cfr. Masolino D’Amico, Introduzione a Exiles, Edizioni Studio Tesi, Pordenone, 1985, p.XX.
6) J. Joyce, Exiles, op. cit., p.203.
sabato 5 novembre 2011
Un punto di vista forse inedito su Bukowski
Quando si parla di Bukowski, istintivamente molti pensano a lui come ad uno scrittore che scriveva solo d’alcol e di sesso.
Ora, i suoi temi erano in prevalenza quelli, ma secondo me rientravano in una dimensione più ampia: quella del suo dolore, che in un artista assumono una rilevanza (data la natura piuttosto passionale di quel tipo umano) davvero particolare.
In tutte le sue opere Bukowski ha sempre manifestato un fastidio quasi fisico per il noioso, insopportabile “giochetto di iniziati che si dicono paroline fra loro”1: il giochetto cioè di chi scrive cose magari anche molto curate sul piano stilistico, ma che spesso è solo una sorta di codice tra e per eruditi.
Qualcosa insomma di molto lontano dalla vita reale e dalla sofferenza di cui essa è piena. Lui invece dichiara: “Nessuno è mai venuto fuori a dire: “Cristo, (sic) sto male da crepare.”2
Quindi Bacco e Venere, di cui egli parla in parecchi libri (ma non in tutti) non sono da intendersi come una celebrazione vitalistica, divertimento folle ecc. ma al contrario come la denuncia di un profondo disagio esistenziale.
Infatti, raramente nelle opere di Bukowski troviamo autentica gioia o soddisfazione…. perché: “Esser vivi era già una vittoria.”3 Insomma, spesso quella vita è pura, semplice sopravvivenza.
Comunque rimando chi voglia approfondire la dimensione culturale del Nostro, più complessa di quanto non sembri, alla “mappa” fornita da David Stephen Calonne.4
Ora, non intendo certo beatificare Bukowski, che avrebbe trovato la cosa insopportabile.
Tuttavia ricordo che come dice in modo abbastanza plausibile l’editore neozelandese Trevor Reeves, in Bukowski si trovava un “elemento religioso.”5 Religioso non nel senso dell’appartenenza ad una religione ma in senso più ampio, filosofico ed insieme pratico cioè come pratica di virtù morali di “compassione ed onestà.”6
Del resto, Christy ricorda un episodio in cui il protagonista (l’alter-ego di B. Henry Chinaski) di un suo romanzo entra in un bar, una banda di motociclisti in probabile stile Hell’s Angels lo riconosce e benché in modo piuttosto grossolano gli tributa una sorta di acclamazione.
Bene, Bukowski scrive che gli: “Venne voglia di prenderli fra le braccia, di consolarli e di abbracciarli come un qualche Dostoevskij, ma sapevo che non avrebbe portato a niente, salvo al ridicolo e all’umiliazione, per me e per loro. Chissà come, il mondo si era allontanato troppo e mai più sarebbe stato così facile essere spontaneamente gentili. Era una cosa per cui avremmo dovuto sgobbare di nuovo tutti quanti.”7
Al riguardo, Christy osserva (certo esagerando) che: “Bukowski è più importante di Hemingway”; ma certo Christy ha ragione di dire che: “Hemingway, sconfitto dalla fama, col suo mito della virilità, non avrebbe avuto il fegato di scrivere una cose del genere.”8
Sul piano morale ed indirettamente anche su quello letterario, se cioè non vogliamo considerare la letteratura solo come uno sterile esercizio di stile ma come un fenomeno più complesso, Bukowski fu davvero più coraggioso di Hemingway.
Egli infatti scrisse: “La tragedia è la situazione americana nella quale bisogna essere sempre vincenti. Nessuna alternativa è accettabile. E quando il vincitore cade non salva nulla.”9
Ecco perché, come nel caso di Ernest Hemingway, che secondo B. viveva “considerando la vittoria come unica possibilità”10 si può arrivare anche al suicidio. Perché chi punti solo alla vittoria non può accettare la vita per quello che è…e finisce per stroncarla, per stroncarsi.
Ma come dice il Nostro: “No, Ernest si sbagliava: l’Uomo è fatto per la sconfitta. L’Uomo può essere distrutto e sconfitto. Finché l’Uomo si accontenterà del piolo più alto e non prevederà di precipitare, l’Uomo sarà sconfitto, distrutto e sconfitto e sconfitto e distrutto. Solo quando l’Uomo imparerà a salvare ciò che potrà allora sarà sconfitto meno e distrutto meno.”11
Il sentirsi vicino agli sconfitti portò l’ormai ricco e famoso Bukowski a favorire attivamente la riscoperta di John Fante, lo scrittore italoamericano A. del grande Chiedi alla polvere, che Bukowski omaggia come maestro ed a cui con grande generosità confessò d’aver “preso in prestito” un po’ di stile.12
Nella poesia I giovani il Nostro li osserva correre in moto “a manetta lacerando la notte di rumore.”13 Sì, e nonostante l’apparente sicurezza se non arroganza, la vita dei giovani non gli sembra poi così piena di… vita.
Sono solo bande di ragazzi che si incontrano o forse si scontrano, ma il divertimento e la spensieratezza sono lontanissimi.
Penso che qui B. riprenda quanto aveva già detto in Hollywood ( si trattava anche lì di motociclisti): “Di nuovo notai i loro giacconi di pelle e la vacuità dei loro volti e la sensazione che in nessuno di loro c’era molta gioia o molta audacia.”14 La vacuità, ciò quindi che riguarda il vuoto, un vuoto quotidiano ed interiore che resiste a qualsiasi atteggiamento da “duri”, sembra caratterizzare anche i giovani.
Ma Bukowski non indossa i panni del moralista o del predicatore: capisce anzi la loro sensazione di solitudine, noia ed impotenza se dice:
“mi vien voglia
di andar lì e dire: “dai, troviamo qualcosa da fare...”15
Ma è consapevole di come la mancanza di conoscenza e di coraggio sua e dei giovani vanificherebbe questo slancio. Così aggiunge:
“Anch’io ho sbattuto il mio entusiasmo contro un muro,
lo prendevo a pugni fino a sanguinare e continuavo a
picchiare, ma il mondo restava com’era,
spiacevole, mostruoso, letale.”16
Quindi essere vecchi o giovani non conta: il mondo è intrinsecamente sbagliato, sorta di macchina del nulla che inghiotte o svuota tutti, negandoci qualsiasi gioia, ogni giustizia e fantasia. E certo non aiuta la mancanza di entusiasmo, quel qualcosa cioè che potrebbe aiutarci a reagire, a riempire il nulla di qualcosa che valga…
Ognuno di noi può ricordare quando da giovane non avesse granché da fare, tranne (soprattutto noi maschi) dare l’anima in partite di calcio e sassaiole. Come scordare quello starsene inerti, seduti su uno scalino ad aspettare chissà che cosa… magari infilzato dai sorrisetti di quelli che si sentivano superiori perché non si entusiasmavano mai davvero né si facevano uno straccio di domanda…
Un po’ come la situazione cantata da Neil Young in Trashers, quando parla dei suoi amici (Ugo Polli http://totanisognanti.blogspot.com/2011/07/thrasher-di-neil-young.htmlhttp://totanisognanti.blogspot.com/2011/07/thrasher-di-neil-young.html ipotizza che egli alluda a Crosby, Stills e Nash) che
“sui marciapiedi
e nelle stazioni
aspettavano, aspettavano”
ma non c’era niente che cercassero o di cui avessero realmente bisogno.
Ora, i giovani di cui parla Bukowski sono “fottuti, castrati, spogliati senza speranza.”17 Ma:
“Il passaggio della fiaccola nei secoli,
e adesso ce l’hanno in mano loro.”18
Eppure c’è sempre quel: “dai, troviamo qualcosa da fare .” Insomma, forse la partita della vita non è chiusa.
I poeti e gli scrittori possono solo scrivere con tutto il loro cuore e con tutta la loro intelligenza, sperando che versi, racconti, poesie, romanzi e saggi siano raccolti da chi arriva dopo di loro… anche in sella ad una moto, perché no?
L’importante è che sia raccolto il senso della loro arte senza che si badi troppo agli elementi più “spettacolari” come l’alcol ed il sesso.
E certo, chi non è moralista capisce che gli esseri umani necessitano anche di Bacco e Venere ma alla fine, forse il solo modo di mettere nel sacco la Morte è come dice Bukowski proprio l’arte, soprattutto quella della parola perché:
“il lampo abbagliante della
parola
batte la vita in vita,
e la morte arriva troppo tardi
per vincere davvero
contro
di te.”19
Note
1) Fernanda Pivano, Introduzione a Charles Bukowski, Quello che mi importa è grattarmi sotto le ascelle, Sugarco, Milano, 1982, p.53.
2) F. Pivano, Introduzione, op. cit., p.53.
3) C. Bukowski, Donne, Sugarco, Milano, 1980, p.150.
4) D.S. Calonne, Introduzione a C. Bukowski, Azzeccare i cavalli vincenti, Feltrinelli, Milano, 2008, pp. 7-19. Utili anche le osservazioni della Pivano, che ricorda l’ammirazione di Bukowski per il Decamerone di Boccaccio ed il suo interesse per “la musica classica e le letture raffinate”; cfr. F. Pivano, Introduzione, op. cit., pp. 19 e 44.
5) Jim Christy, La sconcia vita di Charles Bukowski, Feltrinelli, Milano, 1998, p.47.
6) J. Christy, La sconcia vita di Charles Bukowski, op. cit., p.47.
7) C. Bukowski, Hollywood, Hollywood, Feltrinelli, Milano, 1992, p.44.
8) J. Christy, op. cit., pp.89.
9) C. Bukowski, Azzeccare i cavalli vincenti, op. cit., p.74.
10) C. Bukowski, Azzeccare, op. cit., 74.
11) C. Bukowski, Azzeccare, op. cit., p.74. I corsivi sono dell’A.
12) C. Bukowski, Azzeccare, op. cit., p.233. Nel racconto Incontro il maestro, contenuto nel cit. Azzeccare egli ricorda il suo incontro con Fante (nel racconto Bante) ormai con le gambe amputate causa diabete, prossimo alla morte ed abbandonato da tutti. Per i debiti stilistici contratti da B. verso Fante cfr. almeno F. Pivano, op. cit., p.40 e C. Bukowski, Prefazione a J. Fante, Chiedi alla polvere, Sugarco, Milano,1983, pp.7-10. Fante è nominato anche in C. Bukowski, Donne, op. cit., p.208.
13) C. Bukowski, The young, in Id., Il grande. Poesie II, Feltrinelli, Milano, 2002, p.33.
14) C. Bukowski, Hollywood, Hollywood, op. cit., p.44. Corsivo dell’A.
15) C. Bukowski, The young, op. cit., p.33.
16) C. Bukowski, op. cit., p.33.
17) Ibid., p.33.
18) Ibid., p.35.
19) C. Bukowski, Puntare sulla musa, in Id., Le ragazze che seguivamo, Guanda, Parma, 1996, p.83.
Iscriviti a:
Post (Atom)