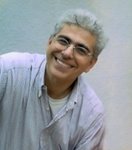giovedì 19 giugno 2014
Esplorando Thomas Bernhard
Thomas Bernhard nacque a
Heerlen, in Olanda nel 1931 e morì a Gmunden, in Austria nel 1989.
Straordinaria la frase con cui la nonna gli trovò un lavoro in un
giornale austriaco: “E' mio nipote, non sa fare niente; sa soltanto
scrivere.”
La caustica frase dell'anziana
signora era probabilmente tipica di una mentalità, non so se
austriaca o solo salisburghese (la
città dei genitori di Bernhard) contro cui lo scrittore si sarebbe
scontrato per tutta la vita... L'idea cioè che l'arte ed in fondo
anche la filosofia debbano essere schivate come la peste; insomma,
Dante, Socrate, Goethe, Kant ecc. ecc. sarebbero stati dei
grandissimi idioti. Del problema si occupò anche Achille Campanile
nel suo Vite degli
uomini illustri.
Ma Bernhard
non si arrese mai a questa mentalità.
In
ogni caso, a 16 anni lasciò il ginnasio ed iniziò a lavorare come
apprendista in un negozio di generi alimentari nel quartiere,
considerato malfamato, di Scherzhauserfeld; è questo il tema del
romanzo autobiografico La cantina (T.
Bernhard, La cantina (1976),
Adelphi, Milano, 1984).
Nota bene:
egli fece questo di propria iniziativa, non col consenso né su
imposizione della famiglia. Così, appena adolescente iniziò a
sgobbare alla grande; comunque come scrisse ne La cantina,
al ginnasio aveva voglia di suicidarsi.
Ma lavorando a Scherzhauserfeld... rinacque!
Chi legga le
opere di Bernhard può accusarlo di misantropia; facile accusa. E'
misantropo chi detesta o addirittura odia l'umanità. Certo,
spesso lui polemizza con tanta gente e la sua penna ferisce.
Ma
io penso che Thomas non sopportasse chi finge di
esserti amico e chi pretende di conoscerti perfettamente quando
questo è impossibile anche a noi stessi...
egli detestava poi l'intervistatore che gli rivolgeva delle domande
assurde o banali e si infuriava quando qualcuno invadeva i suoi
momenti di riflessione. E gli piacevano le persone corrette, non
quelle fintamente buone.
Inoltre
denunciava il miscuglio, in Austria, di cattolicesimo e mentalità
nazista che a suo avviso esisteva ancora, a decenni dalla
fine della guerra. E pare che su questo punto tra gli artisti
d'Austria concordassero il marito di Maxie Wander, Fred, la
scrittrice Jelfriede Jelinek e la poetessa Ingeborg Bachmann.
Thomas,
inoltre, non aveva timori reverenziali verso certi mostri sacri della
cultura: per esempio, in
Antichi maestri attacca
Heidegger del quale
dice: “Heidegger è il filosofo dei tedeschi in pantofole
e berretto da notte.” Ed
aggiunge: “Heidegger è un piatto forte della filosofia tedesca, e
fa sempre un figurone, lo si può servire ovunque e a qualsiasi
ora(...), è un budino di letture,
insapore ma facilmente digeribile per
l'anima tedesca media.”
Se
non erro, in un punto di Goethe muore,
Bernhard attacca con discreta violenza anche Popper.
Leggendo
T. Bernhard, che secondo me doveva avere molto dello spirito giocoso
ed irriverente di Mozart, (altro enfant terrible di
Salisburgo) in lui si coglie anche della voglia di divertirsi... non
solo di fustigare uomini o costumi. Penso che tutto questo risulti
dalle espressioni usate dal Nostro, per quanto colleriche possano
sembrare.
In
Conversazioni con Thomas Bernhard egli
osserva infatti che: “Ci sono persone tanto tenaci, che non
capiscono o non sentono assolutamente niente. Diventano subito
insolenti se, per esempio, non si apre la porta, allora picchiano
con questo batacchio, come se la
volessero fare a pezzi dalla rabbia, e i vicini dicono 'E'
in casa.' A Vienna vivo
addirittura nell'anonimato.”
In
effetti, è il sogno soprattutto dell'artista,
quello di vivere in splendida solitudine (che non è isolamento)
per poter creare senza interferenze da parte del mondo esterno.
L'artista che perda questa sua volontaria solitudine
finisce per vivere male e per creare peggio.
Del resto, lui non va in giro a seccare nessuno, allora perché gli
altri lo fanno?!
Qui
ci troviamo di fronte ad una contraddizione, che però per me è solo
apparente: come diceva Lennon, un artista lavora soprattutto a
casa. L'artista potrà anche
fare tutte le esperienze di questo mondo, ma poi deve concretizzare,
dare forma compiuta ad esse... e per farlo deve rimanere da solo e
tranquillo. Nessuno può creare
davvero con una folla che gli invade la casa e gli fracassa
concentrazione ed ispirazione.
Comunque
sempre nelle Conversazioni citate
Bernhard, benché consapevole che: “Nessuno dovrebbe rinchiudersi e
sbarrare tutto”, aggiunge “ma se apro la porta la gente entra
dentro; vengono qui pensando di essere a casa propria. Come se io
fossi una specie di giraffa che si può guardare,
che è comunque a disposizione del pubblico.”
Allora,
l'artista che non voglia passare da “giraffa”, sa che: “Ogni
persona vuole partecipare a qualcosa e nello stesso tempo essere
lasciata in pace. Siccome le due cose, in realtà, sono
inconciliabili, si è sempre in conflitto con sé stessi.”
E
davvero il dissidio tra inclinazione a creare e desiderio di stare
con gli altri è lacerante. Penso che seguendo la prima
strada ci sia il rischio di
realizzarsi come artista ma di fallire come essere umano; seguendo la
seconda, si può fallire come
artista e realizzarsi come uomo, o come donna.
Ma forse le
cose non sono poi così tragiche, magari sono solo un un tantino
drammatiche. Credo che Bernhard ci avrebbe riso sopra. Senz'altro. E
quasi quasi, lo faccio anch'io. Perché un artista sa sempre che cosa
fare; soprattutto quando non lo sa.
venerdì 13 giugno 2014
La discussione filosofica (16/a parte)*
Spesso chi voglia ragionare di
filosofia si lancia in lunghe, talvolta interminabili polemiche. Non
di rado questi infuocati polemisti difettano d'effettiva
padronanza della materia e degli
argomenti che affrontano.
Ora, questo
non è necessariamente un male: anzi io apprezzo l'entusiasmo e che
alcuni/e vogliano dedicare parte del loro tempo a qualcosa di così
difficile ed anche poco divertente come appunto è la filosofia.
Quel
che conta è che queste persone siano disposte a prendere sul
serio la discussione filosofica:
il che significa cercare di capire le tesi del loro interlocutore ed
eventualmente accettare la correzione dei loro errori.
Purtroppo,
questo capita di rado. Già Platone osservava che per es. “i
giovincelli, quando la prima volta assaggiano l'arte del ragionare,
ne usano come di un gioco, servendosene sempre per
contraddire; e scimmiottando
quei che li confutano, van loro confutando altri, godendo come dei
cagnolini a trascinare e sbranare coi ragionamenti chi si trovi via
via loro vicino.”1
Ma
per me tale discorso non riguarda solo i giovincelli.
Comunque, il sopraggiungere della cosiddetta “maturità” conduce
tanti/e a considerare le questioni più importanti ( il
problema del bene e del male, quello della giustizia, della
conoscenza, di una umana convivenza
civile ecc.) roba da idealisti o da... perdigiorno!
Ammucchiare
(spesso non onestamente) danaro,
lanciarsi in avventure in fondo pseudopolitiche (perchè in esse ci
si disinteressa del bene comune),
scolpire il proprio corpo in palestra, considerare le donne o gli
uomini semplici prede sessuali, non perdersi una partita di calcio
ecc. ecc., tutto questo dalla maggior parte delle persone è
considerato davvero
importante.
Ma
in filosofia il duro
ed umile tirocinio passa per folle o inutile. Così, certo giustamente, si pensa che per qualsiasi scienza, mestiere, tecnica o
professione serva una preparazione specifica. Addirittura: “Si
ammette che per fare una scarpa, bisogni avere appreso ed esercitato
il mestiere del calzolaio”, ma: “Solo pel filosofare non
sarebbero richiesti né studio, né apprendimento, né fatica.”2
Così,
spesso pensa di capire la filosofia perfino chi possegga il
“fondamento di un'ordinaria cultura” e soprattutto chi si affida
a dei “sentimenti religiosi”3, peraltro genericamente intesi.
Tutto questo spiega perché tante persone dimostrino tanta sicurezza
in fatto di filosofia, laddove un certo Socrate (che
come è noto asseriva di non sapere)
doveva capirne pochino...
Ma il vero problema nasce quando la discussione filosofica avviene con
chi della disciplina ha una conoscenza ma cerca il cavillo o come si
dice popolarmente, va a cercare il pelo nell'uovo. Infatti, poiché
in filosofia direi qualsiasi argomentazione, idea o teoria conterrà
sempre qualcosa di non totalmente esatto
(i filosofi non sono divini),
questo permetterà al cavillatore di scovare senz'altro qualcosa a
cui aggrapparsi per “dimostrare” che la tesi altrui è errata.
Così
questo simpatico personaggio, olimpicamente indifferente al senso
complessivo del pensiero da lui
criticato, senso che peraltro gli è chiaro,
bollerà indifferentemente l'altrui
pensiero di astrattezza o all'opposto, di ovvietà. Di
sentimentalismo o di
cinismo. Di ignoranza o di
esibizionismo culturale. Di illogicità o
di pedanteria...
L'accusa,
condotta sul filo di una polemica in apparenza bonaria ma in realtà
parecchio astiosa, attribuirà all'avversario e/o alle sue tesi colpe
e difetti d'ogni tipo.
Del
resto, per chi abbia una purchessia preparazione
filosofica e soprattutto una certa attitudine al cavillo,
un'operazione come quella risulta facile: gli basterà fondare le sue
critiche sul “buon senso” che porta l'uomo della strada a
diffidare di qualsiasi cosa si allontani di un cm dal suo naso e dal
ritenere “illogico” l'uso di alcuni termini. Crederà così
d'aver ridotto la filosofia ad una sorta di delirio che non
reggerebbe il confronto col più scalcinato dei telequiz: nei quali,
almeno: “A è a e b è b, diamine!”
L'esasperato
culto quindi della logica formale,
quella che è stata codificata da Aristotele (e che si fonda sul
principio di non contraddizione) viene utilizzato come un killer per
assassinare qualsiasi tesi non rientri in un quadro evidentemente già
dato, precostituito. Un po' come se uno dicesse: “Va' dove vuoi, ma
non uscire da questa stanza.”
A
fine '600 commise questo errore perfino il filosofo tedesco Leibniz,
che attribuì alla personalità ed al pensiero di Abelardo
un'irrazionale ed irritante inclinazione a contraddire comunque
il prossimo. “Perché in
fondo, non si trattava che di una logomachia: egli alterava l'uso dei
termini.”4
Letteralmente,
logomachia significa
“battaglia di parole.” Per Leibniz uno dei filosofi più
importanti del Medioevo era solo un noioso parolaio.
Eppure, già
Cicerone aveva chiarito quel che ribadirà Abelardo nel XII secolo:
“Soprattutto ci ostruisce il cammino verso la comprensione
l'insolita forma dell'espressione e il più delle volte il diverso
significato delle medesime parole, per il fatto che lo stesso termine
in alcuni casi è utilizzato in un significato, in altri in un
altro.”5
Nessuna
alterazione dei
termini quindi ma semmai un loro ragionato e ragionevole
(perciò prudente ed onesto)
utilizzo.
Di
un problema simile si occuperà nel '900 anche Gramsci
quando osserverà che: “Tutto il linguaggio è diventato una metafora e la storia della semantica è anche un aspetto della storia
della cultura: il linguaggio è una cosa vivente e nello stesso tempo un museo
di fossili della vita passata. Quando io adopero la parola "disastro" nessuno può
imputarmi di credenze astrologiche, o quando dico “per Bacco”
nessuno può credere che io sia una adoratore delle divinità pagane,
tuttavia quelle espressioni sono una prova che la civiltà moderna è anche uno sviluppo del paganesimo e dell'astrologia.”6
Ma ripeto, chi
insista sulla sola logica formale finisce per sembrare più realista
del re, poiché né l'ambiente di studi studi aristotelico (il Liceo)
né lo stesso Aristotele diedero appunto alla logica particolare
importanza.7
Che dire? Purtroppo
saranno sempre all'erta quelli che esamineranno con comica anzi ridicola severità
(ben lontani quindi dalla latina gravitas)
le tesi altrui. Abelardo chiamò costoro “pseudodialettici” cioè
falsi dialettici: si
riferiva a quei “professori di dialettica” che presumevano di
poter spingere il proprio pensiero oltre quello
di chiunque altro.8
Ma
in questo, essi finivano paradossalmente per assolutizzare
la loro filosofia: il paradosso
consiste nel fatto che l'autentica dialettica,
la vera filosofia deve criticare anche sé stessa e
se non fa questo, della vera dialettica ha solo la maschera.
La
vera dialettica deve invece trovare alimento anche nei propri
errori, vale a dire
correggendoli in modo da far progredire realmente il proprio
discorso... e forse, contribuendo in questo al miglioramento anche
alle riflessioni altrui. Una filosofia così intesa si presenta
quindi come un sistema animato da una permanente, continua volontà
di automiglioramento.
Bene,con
questa 16/a parte chiudo con l'esame dell'eccesso di
critica, esame che spero d'aver
concluso in modo soddisfacente.
Buoni
mondiali!
Note
*
Ho pubblicato su questo blog le precedenti parti di questo post
rispettivamente: la 1/a il 25 /03/2008; la 2/a il 4/4/2008; la 3/a il
17/6/2010; la 4/a l’11/10/2011, la 5/a il 27/11/2011;
La
6/a il 15/11/2012; la 7/a l'8/12/2012.
Il
riepilogo di questo post (sino alla 7/a parte) è stato pubblicato il
21/02/2013.
Ho pubblicato l'8/a parte il 20/03/2013 e la 9/a il 14/09/2013; la 10/a il 5/10/2013, l'11/a il 30/10/2013, la 12/a il 16/11/213.
Ho pubblicato l'8/a parte il 20/03/2013 e la 9/a il 14/09/2013; la 10/a il 5/10/2013, l'11/a il 30/10/2013, la 12/a il 16/11/213.
Il
riepilogo di questo post (dall'8/a all'11/a parte) è stato
pubblicato il 13/12/2013.
La
13/a parte è stata pubblicata il 19/01/2014 e la 14/a l'8/02/2014.
La 15/a è stata pubblicata l'8/03/2104.1 Platone, La repubblica, Fabbri Editori/Bur, Milano, 2000, vol. II, p.276. Il corsivo è mio.
2 G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, Laterza, Roma-Bari, 1980, Vol. I, §5, p.8.
3 G. W. F. Hegel, Enciclopedia, op. cit.,p.8.
4 Pietro Abelardo, Teologia del sommo bene, a cura di Marco Rossini, Rusconi, Milano, 1996, p.45.
5 M. Rossini,
Introduzione a P. Abelardo, Teologia del sommo bene, op. cit.,
p.23. La citazione è tratta dal Prologo alla
più nota e controversa opera di Abelardo, il Sic et non (Sì
e no).
6 Antonio
Gramsci, Quaderni del carcere, Edizione critica dell'Istituto
Gramsci, a cura di Valentino Gerratana, Einaudi, Torino, 2007, p.438.
7 Eric Weil,
Filosofia e politica, Vallecchi Editore, Firenze, 1965, pp.51-52.
8 P. Abelardo,
Teologia del sommo bene, op. cit., p.100.
lunedì 2 giugno 2014
Cronaca di un simpatico pomeriggio
In questo momento sono le 16.45
del 21 ottobre 2013; quindi sono passati 51 anni dalla mia irruzione in this
world, insomma in questo mondo.
Sono comodamente assiso sul 19 (un
bus ultramoderno) e viaggio in compagnia del Bue Muto e della Vecchia
Signora, destinazione Quartu S. Elena.
Farei a meno dell'aria
condizionata ma visto che a Kalaris,
Caller, Kar-El, Casteddu, insomma Cagliari stiamo
ancora andando al mare, penso che vada bene anche l'aria complessata;
pardon, condizionata...
Non so se la
Vecchia Signora ed il Bue Muto accetteranno di farsi mettere alla
porta, ma in questo periodo ho altro ed altri per la testa.
Per
esempio (o come dicono i Tedeutschi, zumspiel)
rimettere mano a quel libro di filosofia che secondo me, vorrebbe
farsi finire di scrivere.
Oppure
comprarmi una bicicletta, o clettabici che dir si voglia.
O anche
cercarmi una nuova casa editrice... visto che la vecchia ha chiuso.
Soprattutto,
cucinare quella cena medievale di cui parlo invano da tanti, troppi
anni.
Insomma,
la Alte Dame ed il Bue
Muto dovranno aver pazienza... come dicevano le belve ai cristiani
mentre li divoravano.
La serata non
è più calda ma è ancora tiepida. Signor autista, perchè non
spegne la maledetta aria condizionata? Sento un freddino...
Mi
ricordo della visita alla Grande Diga (Groet Dam,
in olandese?) di Volendam. Si trattava di Volendam, ja?
Devo chiederlo a mia moglie, lei lo ricorderà senz'altro.
Ah: non devo
dimenticare, a giugno, di presentare le domande di supplenza.
Ora una
piccola pausa, ladies and gentleman: sto per arrivare a Quartu, devo
prepararmi per scendere dal bus... conservare la penna, il quaderno,
rimettermi gli occhiali ecc. A tra poco, non cambiate blog.
Rieccomi!
Sapete
che la Vecchia ed il Bue hanno hanno fatto un sacco di
storie, per scendere dal pulmo?
Ho dovuto prenderli a calci.
In
biblio (teca) la bibliotecaria aveva in mano dei cd dei … Kiss!
Volevo chiederle. “Ah, segue anche lei i Kiss?”
Ma non ne ho
avuto il coraggio.
Così
ho preso in prestito qualcosa sulla Germania di Nicolao Merker e sono
scappato via mentre la Vecchia Signora si è staccata una gamba di
legno (o di ferro) e brandendo quella ha iniziato a rincorrermi fino
alla fermata del QS.
Il Bue Muto,
invece, muggiva in latino!
Uno scandalo,
amici miei... una vergogna, amiche mie!
Comunque la
serata è ancora molto tiepida e mi sto immettendo in un viale
Marconi inondato di sole ottobrino ed appena velato da un leggero
pulviscolo... o forse, si tratta di una delicata nebbiolina.
Sono le 17.53
del 21 ottobre 2013 ed anche se leggerete questo pezzo con mesi di
ritardo, sappiate che son contento.
Un salutone a
tutte voi ed
a tutti voi!
sabato 24 maggio 2014
Su “Senza tregua”, di Giovanni Pesce
Presentazione generale
Giovanni
Pesce (1918-2007) è stato uno dei grandi comandanti dei GAP
(Gruppi
di azione patriottica) una formazione partigiana che durante la
Resistenza davvero non diede tregua
ai
nazifascisti. Il suo libro non possiede però il carattere spesso
retorico o accademico della memorialistica e di certi lavori
storici, quel che non di rado allontana molti lettori.
Senza
tregua è
infatti scritto col ritmo e la densa concisione di un ottimo romanzo,
ma le vicende narrate dall'A. non sono frutto di fantasia: le scene
delle battaglie contro i franchisti (i fascisti spagnoli), quelle
delle azioni contro le spie repubblichine (i fascisti italiani che
aderirono al regime-fantoccio di Salò, che agiva alle dirette
dipendenze dei nazisti)
sono vere, così come lo sono le descrizioni dei vari scontri armati
in montagna ed in città, l'esecuzione di traditori, torturatori
(nazisti e fascisti), di soldati e poliziotti, rastrellatori ecc.
Né è meno vera la
descrizione di quel perverso insieme di ferocia e scherno che guidava
l'azione repressiva e criminale oltre che dei nazisti, anche dei loro
complici fascisti: quel che si manifestava perfino davanti ai corpi
“massacrati” e “quasi irriconoscibili” di quindici uomini
appena fucilati e lasciati per quasi una giornata sotto il sole,
senza sepoltura, a cui si negarono i conforti religiosi ed
ammucchiati per strada come nient'altro che spazzatura.1
Eppure
Giovanni non indugia su questi orrori: li ricorda con grande dolore e
con un senso di umana pietas,
così come denuncia con un senso di repulsione il “volto” di un
repubblichino che di fronte allo scempio fatto da lui e dai suoi
compagni di quelle povere vite, “ride istericamente”2
Ma
poi Giovanni va avanti, perché sa leggere le vicende di quella
guerra in un modo che non si limita solo ad essa: egli inquadra
infatti gli scontri della II guerra mondiale come uno scontro tra
visioni inconciliabili
della
vita e del mondo.
Lo scenario
nazifascista
Del
resto, i nazisti cercarono di giustificare la loro barbarie con la
“proclamazione del principio della superiorità del popolo
germanico come Herrenvolk”;3
Herrenvolk cioè popolo
di signori mentre
pressoché tutti gli altri “gruppi etnici o anche sociali” erano
considerati “minderwertig
(inferiori) razzialmente.”4
Queste
deliranti idee prevedevano l'occupazione di vastissime aree di
territori europei (soprattutto ad est), la loro “germanizzazione”,
ciò che comportava come conseguenza finale la progressiva
soppressione
fisica dei
popoli ivi residenti.5
All'eliminazione
quindi di circa 6 milioni di ebrei, 3 di zingari, 1 di omosessuali e
di varie centinaia di migliaia di resistenti, avrebbe dovuto seguire
anche quella di vari altri milioni di slavi, persone per vari motivi
ritenute anch'esse inferiori come per es. artisti “depravati”,
vecchi, oppositori politici, “asociali”, uomini e donne con
gravi handicap fisici, mentali ecc. Ed in non piccola misura, il
regime hitleriano realizzò questi piani.
Comunque,
alla fine della guerra si contarono oltre 50
milioni di morti
e le crudeltà e le violazioni di ogni norma morale, civile,
razionale e giuridica da parte nazifascista sono rimaste tragicamente
proverbiali.
Basti
pensare oltre ai lager
ed
alle camere a gas, alle stragi di Marzabotto, Sant'Anna, Cefalonia,
Fosse Ardeatine ecc., all'esempio costituito dalla città olandese di
Rotterdam.
I militari olandesi accettarono la resa imposta dai nazisti che
avevano minacciato “di radere al suolo la città. Gli olandesi
accettarono la resa, ma mentre si svolgevano le trattative, la
Luftwaffe, a buon conto, distrusse la città.”6 Tale bombardamento
costò la vita a circa 900 persone e provocò quasi 80mila
senzatetto.
Ed il regime
fascista condivise i piani nazisti, rendendosi per esempio complice
della deportazione degli ebrei italiani.7
Del
resto, a riprova del carattere indiscutibilmente criminale del
fascismo, Mussolini dichiarò che esso: “Non crede alla possibilità
né all'utilità
della pace perpetua”;
per esso: “Solo
la guerra porta
al massimo di tensione tutte le energie umane e imprime un sigillo
di nobiltà ai
popoli che hanno la
virtù di
affrontarla.”8
L'esaltazione
quindi della guerra, considerata dal fascismo addirittura come fatto
dotato di dignità morale,
il disprezzo per i valori della pace, della giustizia e della
riflessione critica, si collegavano alla negazione
della
stessa uguaglianza,
se Mussolini disse che: “Il Fascismo (…) afferma la
disuguaglianza
irrimediabile e feconda e benefica degli uomini.”9
Esisteva
dunque tra fascismo e nazismo un'affinità,
un forte e comune sentire che condusse i due regimi ad un'alleanza
che si rivelò del tutto naturale. Questo, benchè la Germania
nazista possedesse rispetto all'Italia fascista una netta superiorità
economica, tecnologica e militare che del resto, Hitler non mancava
mai di far pesare all'alleato italiano. Si tratta: “Dell'ambigua
situazione dell''alleato occupato' ricostruita di recente dal
Klinkhammer”, alleato cui però Hitler riconosceva una
“'primogenitura' sul piano politico”10
La guerra di
Giovanni e dei GAP
Giovanni,
nome di battaglia Visone
(probabilmente
perché originario di Visone d'Acqui, in Piemonte) esordì come
combattente antifascista nella guerra civile spagnola.11
Già
nei primissimi capitoli del libro si spiegano bene senso
e direzione della
lotta di quest'uomo, che non si atteggia mai a “superuomo” (falso
mito, quello, tipico della sottocultura nazifascista): Giovanni, che
da ragazzo fu minatore
sente
per natura un legame
speciale col
mondo del lavoro ed appunto coi suoi componenti, se scrive: “Cento
fili mi legavano ai minatori: i loro sigari e le loro pipe m'erano
familiari non meno del cigolio intermittente della porta d'ingresso:
di ognuno conoscevo il volto, l'umore, anche se non capivo sempre la
lingua.” 12
L'incomprensione
(iniziale) della lingua derivava dall'essere egli “il figlio
dell'operaio piemontese fuggito in Francia per non subire la
prepotenza dei Cesarini di ieri e di oggi.”13 Cesarini,
responsabile della deportazione di “centinaia di operai e di
tecnici, quasi tutti ad Auschwitz”, era infatti “l'immagine
stessa del fascismo repubblichino.”14
Così,
ogni partigiano conduceva una lotta che non era solo militare ma che
anzi coinvolgeva visioni morali, politiche, culturali diametralmente
opposte a quelle nazifasciste. Infatti, ad un certo punto Visone
scrive:
“Mando a dire ai miei gappisti che ci sarà una breve pausa e che
ne approfittino per
leggere e studiare,
come insegnava Gramsci.”15
Possiamo
immaginare un ufficiale nazista o repubblichino raccomandare ai suoi
sgherri di leggere alcunché? E' molto più facile che invece costoro
andassero (come testimonia Visone)
per bar ed osterie, dove si rilassavano dopo un'infame giornata di
rastrellamenti, torture e massacri, in compagnia di prostitute e
dandosi a grossolane chiassate, volgari scherzi, sbronze ecc.
Ben diversa la
statura morale di un uomo come Curiel 16 , così come quella di
Matteotti, di Gobetti, don Minzoni, Pertini, Gramsci, dello stesso
Pesce e di tanti altri, grandi figure di uomini e donne rimaste
magari anonime.
Qui
penso alle staffette,
penso soprattutto a certe giovanissime ragazze che pur consapevoli
dei rischi mortali e delle intollerabili offese che potevano subire
sul piano intimo, non solo accettarono di correre certi rischi, ma
mantennero una freschezza ed una naturalezza davvero commoventi. E
con pochi ma poetici tratti di penna, l'A. ha saputo consegnarle al
nostro ricordo. Ed alla nostra riconoscenza.
Del resto quel
legame speciale che il movimento partigiano ebbe con la classe
operaia e col mondo contadino, dipendeva dal provenire partigiani/e
proprio da quello, o (quando l'origine sociale di alcuni/e di loro
era altra), comunque dal loro battersi per chi ha sempre subito il
peso della struttura sociale. Partigiani come “avanguardia in armi”
dei lavoratori17; lavoratori che col grandioso sciopero del marzo
1944 nell'Italia del nord, che la “Voce di Londra” definì
“unico, finora, nella storia della guerra”18, diedero alla lotta
contro il nazifascismo uno straordinario appoggio morale, politico ed
anche pratico: per es. sabotando la produzione bellica di cui
appunto il nazifascismo si avvaleva.19
Certo non vi sarebbe
stata liberazione dal nazifascismo se la Resistenza non avesse potuto
contare su un coraggioso e costante appoggio popolare. Come
dice magistralmente Giovanni, si trattava di: “Brava gente che non
aveva nulla da guadagnare con me, ma tutto da perdere.”; ed
aggiunge: “Questo è qualcosa di più della bontà. E'
l'antica aspirazione alla giustizia.”20
Giustizia e diritto
di resistenza
La distinzione di
cui sopra è fondamentale perché quelle che Gramsci ha definito
“classi subalterne”, hanno dovuto vivere una bontà che
era poi sottomissione, rinuncia ai propri diritti e
spesso alla stessa vita, accettazione di abusi, umiliazioni,
sfruttamento lavorativo, abbruttimento psicofisico, violazione della
propria sfera intima, repressione militare e poliziesca... negazione
insomma di quella irrinunciabile dignità cui ha diritto
ogni essere umano.
Ma la giustizia
distrugge questa crudele e complessa trappola: la giustizia, che
Ulpiano definì come “volontà costante e perpetua di dare a
ciascuno il suo”21 e che per Aristotele è la “virtù più
eccellente”: anche perchè appunto egli citando il poeta Teognide
la dipinge come ciò in cui “si riassume ogni virtù.”22 E tutto
questo perché chi possiede ed attua la virtù della giustizia
è capace di servirsene “anche nei riguardi del prossimo; e non
solo in relazione a se stesso”; soprattutto, “noi diciamo
'giusto' ciò che produce e preserva la felicità, e le parti di
essa, nell'interesse della comunità politica.”23
Attenzione: il Greco
parla di comunità politica, non di alcune sue parti o
di determinate classi; parla quindi di una giustizia che deve
esistere per tutta la comunità e senza limitazioni di
tempo, di spazio, di cultura ecc. Per essere tale, la giustizia deve
quindi essere completa, totale: di essa, insomma, devono godere tutti
e sempre.
Ma quando sia negata
la natura sociale ed egualitaria appunto della giustizia,
allora non si potrà pretendere che chi subisce la violenza di un
potere ingiusto, continui a subirlo. La stessa bontà fornirebbe
il miglior puntello ad una tirannide che a quel punto non
incontrerebbe più alcuna opposizione.
Nel corso della
storia tanti pensatori hanno elaborato il concetto di un diritto
di resistenza dei popoli ad un potere che violi le leggi di
giustizia. Già nel XII secolo un allievo di Abelardo, Giovanni di
Salisbury, parlò della legittimità del tirannicidio che
consiste nell'uccisione di un sovrano ingiusto o comunque nella
ribellione ad un potere brutale.24 Tali atti sono giustificati dal
fatto che chi governa è tenuto alla strettissima osservanza
di legge ed appunto giustizia, sì che propriamente parlando, egli
più che un governante è un servo di legge e bene comune: che
non può tradire in nessun caso.25
Dopo l'uomo di
Salisbury il concetto di tirannicidio fu ripreso anche da
altri26 e perfino prima che ai rivoluzionari francesi, a
quelli marxisti o a quelli anarchici, dobbiamo ad un teorico del
liberalismo (!) come l'inglese Locke un'esplicita
teorizzazione del diritto di resistenza, che lui chiama anche di
guerra. Egli formula chiaramente quel diritto nell'opera Due
trattati sul governo (1689). 27
Conclusioni
Si vede quindi bene
come nel nostro (ed in ogni altro) Paese ferocemente
oltraggiato dal nazifascismo, il diritto di resistenza fosse
indiscutibile. Inoltre, tale diritto condusse all'effettiva
liberazione perché tra masse popolari e movimento partigiano
si realizzò una fortissima e naturale saldatura.
Quel che sarebbe
stato impossibile se di fronte ad uno spietato ed organizzatissimo
avversario come quello nazifascista e di fronte al servile complice
fascista, lo scontro si fosse svolto solo sul terreno militare:
dimensione in cui la Resistenza era più debole.
Ma la Liberazione
avvenne perché (per citare Pascal): “Il cuore ha delle ragioni che
la ragione non conosce.”28
La ragione avrebbe detto ai resistenti che i nazisti erano invincibili, o almeno che era meglio attendere l'arrivo degli Alleati; il cuore diceva che bisognava battersi comunque e quello, il cuore, vinse.
La ragione avrebbe detto ai resistenti che i nazisti erano invincibili, o almeno che era meglio attendere l'arrivo degli Alleati; il cuore diceva che bisognava battersi comunque e quello, il cuore, vinse.
Così, ricordando il
25 aprile a Milano, Giovanni scrive: “Io, in mezzo a tutta questa
gente, a questi operai, a questi giovani, a queste donne mi sento
immerso in un grande mare di affetto”; ed ancora: “Dietro di noi
a sorreggerci, ad aiutarci, a sfamarci, a informarci, c'è sempre
stata questa massa di popolo.”29
A noi, oggi, il
compito così difficile ma anche così bello di saper essere degni
eredi di una lotta tanto gloriosa, soprattutto oggi...
quando perfino chi dovrebbe situarsi nel campo
progressista ed antifascista, non fa davvero molto per difendere le
conquiste (penso per es. alla Costituzione) e la memoria di
quella lotta.
Note
1G.
Pesce, Senza
tregua (1967),
Feltrinelli,
Milano, 2009, pp.202-204.
Cfr. anche
http://www.anpi.it/piazzale-loreto-15-martiri-per-comunicare-ferocia/
2
G. Pesce, Senza
tregua, op.
cit.,
p.204.
3
Enzo Collotti, Hitler
e il nazismo, Giunti, Firenze, 1996, p.110.
In tedesco nel testo.
4
E. Collotti, Hitler
e il nazismo, op.
cit.,
p110.
In tedesco nel testo.
5
E. Collotti, op.
cit.,
pp.112-113
e
125-128.
6
Robert Katz, Morte
a Roma. Il massacro delle Fosse Ardeatine (1967),
Editori
Riuniti, Roma, 1996.
Nuova edizione aggiornata. La Luftwaffe era l'aviazione militare
tedesca.
7
E. Collotti, La
soluzione finale. Lo sterminio degli ebrei, Tascabili Economici
Newton, Roma, 1995, pp.15-18
e
65,
71.
8
Marco Palla, Mussolini
e il fascismo, Giunti, Firenze, 1996, p.67.
I corsivi sono miei.
9
M. Palla, Mussolini
e il fascismo, op. cit., p.67.
Il corsivo è mio.
10
Cfr. E. Collotti, Hitler
e il nazismo, op. cit.,
rispettivamente alle pp.
107 e
106-107.
11
G. Pesce, Senza
tregua,, op. cit., p.27.
12
G. Pesce, op.
cit.,. p.2813
Ibid., p.299.
14
Ibid., pp.299
e
293.
15
Ibid., p.297.
I corsivi sono miei.
16
Ibid., pp.301-302.
17
Ibid., p.69.
18
Ibid., p.77.
19
Per l'intreccio tra scioperi del marzo '44 e lotta partigiana cfr.
Ibid., pp.68-77.
20
Ibid., p.151.
21
Ulpiano, Digesto,
I,
1, 10.
I corsivi sono miei.
22
Aristotele, Etica
nicomachea, Laterza, Roma-Bari, 2001, V, 3, p.175.
23
Aristotele, Etica
nicomachea, op. cit., V, 3, p.175.
Il corsivo è mio.
24
Maria Teresa Fumagalli Beonio Brocchieri, Le
bugie di Isotta. Immagini della mente medievale (1987),
Laterza, Roma-Bari, 2002, pp.60
e
67-68.
25
Maria Teresa F. B. Brocchieri, Le
bugie di Isotta, op. cit. pp.50-60.
26
Cfr. voci monarcomaco
e
tirannide
in
Nicola Abbagnano, Dizionario
di filosofia, Tea, Milano, (1971),
1999,
pp.
594
e
877.
27
Cfr. N. Abbagnano,
Dizionario di filosofia, op. cit., p.877; Luigi Bonanate, Diritto
naturale
e relazioni tra gli Stati (1976),
Loescher,
Torino, 1978, pp.63-64
e
176-177;
Rosario Villari, Storia
moderna, Laterza, Roma-Bari, 1973,
pp.247-249.
28
Blaise Pascal, Pensieri,
Edipem, Novara, 1974, Articolo IV, 277.
29
G. Pesce, Senza
tregua, op. cit., p.306.
lunedì 7 aprile 2014
Cenni riassuntivi su Roosevelt*
Roosevelt
apparteneva ad un'antica famiglia statunitense d'origine olandese:
il suo primo antenato (Claese Van Rosenvelt) si stabilì in quelli
che diventarono i Nuovi Paesi Bassi ed
a Nuova Amsterdam (rispettivamente
gli attuali Stati Uniti e l'attuale New York) nella prima metà del
Seicento.
Gli
antenati di Roosevelt ricoprirono fin da allora nel “Nuovo Mondo”
prestigiosi incarichi direttivi in campo politico ed
economico-amministrativo, così quando egli decise d'occuparsi di
politica, fece questa scelta come membro di un'èlite
storicamente molto importante ed
influente.
Del
resto, Roosevelt avrebbe potuto optare per una carriere prestigiosa e
vantaggiosa almeno quanto quella politica come per esempio quella
forense, dato che nel
1908 (ad appena 26 anni) entrò nel “prestigioso studio legale
Carter, Ladyard & Milburn.”1
Egli
scelse invece la carriera politica e nel 1910, a soli 28 anni fu
eletto senatore per lo
Stato di New York.
Ma il suo
compito di presidente degli USA fu davvero complesso: il Paese era
infatti devastato da una crisi economico-sociale senza precedenti: “I
mesi intercorsi tra le elezioni (novembre 1932) e l'insediamento del
neo-eletto (marzo 1933) furono durissimi per il popolo americano:
quindici milioni di lavoratori erano disoccupati, sei milioni di
agricoltori erano schiacciati da 10 miliardi di debiti ipotecari,
cinquemila banche erano chiuse, gli investimenti industriali erano
crollati a 74 milioni di dollari dal miliardo del 1929.”2
Ma
la crisi non aveva travolto solo l'economia,
aveva compromesso anche la credibilità delle maggiori istituzioni
politiche.
“Racconta
uno storico americano che Hoover, recatosi a Detroit, il maggior
centro della produzione automobilistica americana, per un comizio”,
dovette assistere a questo penoso spettacolo: “Nella città
dell'automobile per chilometri la macchina presidenziale sfilò tra
due ali di gente cupa e silenziosa; quando Hoover si alzò a parlare,
la sua faccia era terrea, le mani gli tremavano. Verso la fine della
campagna era ormai una figura patetica, un uomo stanco, avvilito,
fischiato dalla folla come nessun presidente era mai stato.”3
Così l'azione
di Roosevelt fu economica ma nello stesso tempo di tipo
politico-morale: egli non si limitò a constatare la crisi ma
varò una serie di attività che produssero un “ampio piano di
lavori pubblici finanziati dallo Stato”, portò ad un “aumento
dei salari”, fissazione di “prezzi minimi dei prodotti”,
“riconoscimento di sindacati nelle aziende” ecc.4
Il tutto
abbatté il tasso di disoccupazione, modernizzò il Paese e favorì
la ripresa economica: infatti tra i lavoratori il prestigio di
Roosevelt raggiunse livelli che fino a quel momento non si erano
ancora visti... e che non lo sarebbero stati neanche in seguito, se
egli fu l'unico presidente americano rieletto per più di due mandati
consecutivi.
Inoltre,
egli non arrivò “solo” a sconfiggere speculazione e
disoccupazione: questo perché Roosevelt scorse lucidamente la radice
di quei mali.
Come dichiarò
fin dal suo discorso di insediamento: “A colpirci non è
un'avversità naturale, come il flagello delle cavallette.” Nel
denunciare la crisi egli disse: “Principalmente questo succede
perché chi aveva il controllo degli scambi commerciali dell'umanità
ha fallito per la propria pervicacia e la propria incompetenza.”5
La
crisi dipende quindi dall'azione dell'uomo;
soprattutto da quella di uomini che hanno pensato solo alle “regole
di una generazione di egoisti. Non hanno lungimiranza, e quando non
c'è lungimiranza il popolo va in rovina.” Roosevelt puntò quindi
sull'applicazione di “valori sociali più nobili del mero profitto
monetario.”6
Quei valori
non si basavano né su discorsi astrattamente morali né su ricette
aridamente tecniche ma su qualcosa di molto valido e pratico: per
esempio sul rifiuto dell'idea che la “ricchezza materiale” debba
essere “parametro di successo.”
I valori in questione si basavano poi sull'abbandono della “falsa credenza che le cariche pubbliche e gli incarichi politici siano da valutare solamente con il metro dell'orgoglio per un posto prestigioso e del profitto personale.”7
I valori in questione si basavano poi sull'abbandono della “falsa credenza che le cariche pubbliche e gli incarichi politici siano da valutare solamente con il metro dell'orgoglio per un posto prestigioso e del profitto personale.”7
Superando
poi la tradizionale politica economica americana, egli varò una
“stretta supervisione su tutte le attività bancarie, del credito e
degli investimenti”; dichiarò inoltre che si doveva “porre
termine alla speculazione fatta con il denaro altrui.”8
Come
visto, il programma del Nostro era piuttosto concreto ed anche se fu
duramente osteggiato da quel mondo finanziario che peraltro aveva
determinato la crisi,
appunto il programma rooselveltiano trasse gli USA fuori da essa.
In
questo quadro risultarono preziosi anche gli studi e le riflessioni
in campo economico di Keynes e
comunque: “L'età della libera attività economica, intesa almeno
nel senso ottocentesco, e della fiducia nei meccanismi spontanei del
mercato poteva allora
dirsi definitivamente conclusa anche sul piano teorico.”9
Del
resto, Roosevelt aveva ben capito in seguito al crack di Wall Street
come una fiducia acritica (e per alcuni spesso interessata)
in un mercato lasciato privo di qualsiasi controllo, causasse
inevitabilmente crisi economica, disoccupazione, inflazione, forti
tensioni sociali ecc.
Non poteva
quindi darsi altra soluzione che non fosse ispirata a valori di
solidarietà, di controllo e di equità sociale. Per questo,
probabilmente, molte delle soluzioni rooselveltiane mantengono una
loro validità anche al giorno d'oggi.
L'alternativa
a tutto questo, cioè l'affidarsi senza riserve ad un'economia da
intendersi come al di sopra di qualsiasi regola o legge, ricorda
invece l'immagine di quella “società borghese che ha evocato come
per incanto così colossali mezzi di produzione e di scambio”, ma
che poi “rassomiglia allo stregone che si trovi impotente a
dominare le potenze sotterranee che lui stesso abbia invocate.”10
Note
* Questo brano fa parte di un mio saggio
ancora inedito dal titolo Dinamiche e prospettive dello Stato sociale.
1
Franklin Delano Roosevelt, Superare la crisi economica: il
New Deal, Gruppo editoriale L'Espresso, Roma, 2011, p. 11.
2 Rosario
Villari, Storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari, 1978, p.492.
3 R. Villari,
Storia contemporanea, op. cit., pp.492-493.
4 R. Villari,
op. cit., p.493.
5 F. D.
Roosevelt, Superare la crisi economica, op. cit., 19.
6 F. D.
Roosevelt, op. cit., p.21.
7 F. D.
Roosevelt, op. cit., pp. 21 e 23.
8 F. D.
Roosevelt, op. cit., p. 25.
9 R. Villari,
Storia contemporanea, op. cit., p.495.
10 Karl Marx Friedrich Engels, Manifesto del partito comunista (1848),
Tascabili economici Newton, Roma, 1994, p.23. Traduzione
di Antonio Labriola. Nel citare questo celeberrimo brano, non si
intende evidentemente assimilare la figura e l'opera di Roosevelt a
quella del movimento operaio, dal quale il presidente statunitense si
mantenne in effetti sempre lontano. mercoledì 12 marzo 2014
“La visita della vecchia signora”, di Friedrich Dürrenmatt
Quando avevo 11 o 12 anni vidi
alla tv questa pièce dello
scrittore e drammaturgo svizzero F. Dürrenmatt. La visita
mi turbò molto e quel
turbamento mi accompagnò per non poco tempo.
Negli
anni ho approfondito (leggendo alcuni romanzi di F. D.) la conoscenza
del suo mondo, che trovo notevolissimo. I suoi “gialli” o
“polizieschi”, per es., superano il solito discorso
assassino-vittima-detective, magari condito da
abbondanti dosi di whisky, sesso e cocaina.
Esattamente
al contrario, i gialli del Nostro sembrano dei pretesti per parlare
di questioni etiche, morali e sociali. In Dürrenmatt il giallo è la
cornice, ma il il
quadro è la condizione
dell'uomo nel mondo, le ingiustizie e l'assurdo che deve subire ed
anche imporre agli altri. Insomma, a D. più che raccontare la morte
della vittima, preme raccontare quella della società.
Veniamo
ora a La visita.
Dopo
tantissimi anni nella cittadina di Güllen torna la signora
Zachanassian.
In
realtà si tratta di quella che da ragazza si chiamava Kläri Wäscher.
Ora, di solito un romanziere (e penso anche un drammaturgo) non
sceglie i nomi a caso: seguitemi perchè farò un discorso
apparentemente contorto.
In
tedesco, “lavare” si dice “waschen” e “lavandaia”,
wäscherin. L'assonanza
quindi tra il termine tedesco per “lavandaia” (wäscherin)
ed il nome da ragazza della vecchia signora (Wäscher)
è evidente. Sempre in lingua tedesca, “lavanderia” si dice
Wascherei.
Bene,
secondo me D. con questo ci vuol dire che quando era giovane, quella
che ora è una vecchia e ricca signora,
era una donna povera, umile e che lavorava duro; ma che per vivere
doveva lavare lo sporco degli
altri.
Tutto
questo a livello simbolico,
perché ne La visita non
lo si dice esplicitamente,
ma ripeto: chi scrive non usa a caso neanche i nomi delle persone,
che spesso sono come delle spie che
l'Autore utilizza per segnalare qualcosa al lettore o allo
spettatore.
Bene,
la Zachanassian, ormai miliardaria in seguito al matrimonio col sig.
Zachanassian (e dopo quelli con altri 8-9 uomini) torna in una
Güllen ormai a pezzi e viene accolta come una star.
Sì, quella che una volta era una ragazzina come tante o meno
di tante, ora si degna di
visitare per qualche giorno i luoghi della sua gioventù.
Decide così
di far risplendere la sua fama & ricchezza su una città ormai
devastata da miseria, disoccupazione ed assoluta mancanza di fiducia
nel futuro.
La
signora è infatti disposta a donare alla città un
miliardo (non si sa se di
dollari, franchi svizzeri o marchi tedeschi)... ma ad una condizione:
che i suoi vecchi concittadini uccidano l'uomo
che in passato le fece un grave torto.
Lei chiede: “Giustizia
per un miliardo.”
Così
siamo portati domandarci: fino a che punto possiamo
spingerci pur di uscire dalla miseria? Di fronte ad essa quanto
valgono i nostri concetti
morali, giuridici, religiosi ecc.?
E
soprattutto, dove si situa il confine tra
giustizia e vendetta?
Come vedete,
in questo dramma (ed in effetti anche nei polizieschi) al grande Dürrenmatt non
interessa raccontare semplicemente una “storia.”
Comunque
ne La visita troviamo
anche molti momenti divertenti: spassosissimo il discorso del
sindaco. Quest'uomo, non si sa se più per servilismo, per amnesia o per entrambe le cose, esalta la famiglia della Zachanassian.
“La madre, magnifica, il
ritratto della salute.”
Ma qualcuno
gli fa notare, discretamente, che la donna morì di “tubercolosi
polmonare.”
“Il padre”,
che “costruì accanto alla stazione un edificio assai
frequentato.”
Si trattava di
un vespasiano.
Il
sindaco esalta poi il profitto scolastico della ragazza, il suo
“amore di giustizia e il suo spirito di beneficenza.”
La
signora replica che a scuola era tutt'altro che studiosa, tanto che
veniva “picchiata.” Ed una volta non comprò delle patate ad una
vedova per salvarla “dall'inedia”, ma solo per “stare
una volta tanto in letto insieme ad Ill, più comodi che nel bosco.”
E potrei
continuare a lungo...
Certo,
il riso de La visita è
un riso amaro: ma molte volte quello è un riso salutare.
Ci sveglia da torpore, indifferenza ed ipocrisia; mentre ridiamo ci
fa guardare allo specchio.
sabato 8 marzo 2014
La discussione filosofica (15/a parte)*
Bene, chi fa della teratologia
dunque vede nell'avversario
filosofico solo un mostro,
può anche credere d'averlo liquidato. Lasciamo che questo
non-filosofo si culli
pure nelle sue illusioni. Ma secondo me per non ripetere o riprodurre
questo deleterio meccanismo dobbiamo cercare di capire la sua
dinamica.
Anche
qui torna molto utile il ragionamento di Gramsci che col criticare il
Manuale di Bucharin
osservava che la demonizzazione del pensiero altrui è un grave
errore sia perché contiene la “pretesa anacronistica
che nel passato si dovesse pensare come oggi”, sia perché si
presenta come un “residuo di metafisica perché suppone un pensiero
dogmatico valido in tutti i tempi e in tutti i paesi, alla cui
stregua si giudica tutto il passato.”1
Chiariamo
ulteriormente il discorso svolto da Gramsci.
Nel
passo citato, egli ci mette in guardia dal pericolo di credere che
nelle varie epoche storiche le opinioni filosofiche, sociali,
culturali ecc. siano state errate perché non si uniformavano a
quello che noi pensiamo oggi.
Il che era ovviamente impossibile: uomini e donne dell'epoca
classica, del Medioevo, del '500, del '600 ecc. pensavano secondo
quello che Hegel ha chiamato Zeitgeist,
spirito del (loro) tempo.2
Tutto
ciò che noi pensiamo, infatti, dipende sì da condizioni
filosofico-culturali “pure”: conoscenza per es. della storia del
pensiero, dell'arte, del diritto, delle varie religioni ecc.; ma
nello stesso tempo tutto ciò dipende dalle condizioni materiali e
soprattutto sociali in
cui viviamo.3
Per
es. nel Medioevo,
escludendo dal quadro che sto dipingendo re, nobili, alto clero, capi
dell'esercito, teologi e filosofi (meno quindi dell'1% di quella
società), agli uomini ed alle donne del tempo risultava impossibile
una costante riflessione
autonoma e critica. Analfabetismo, epidemie, carestie, sfruttamento
economico e lavorativo pressoché schiavistico (servitù
della gleba), violenze fisiche
e/o sessuali, superstizione, repressione militare e religiosa
soffocavano anche la semplice ipotesi di
una riflessione.
Come
del resto affermato da Marx ed Engels, di solito le idee prevalenti
di un determinato tempo e di una determinata società sono le idee
che le classi dominanti hanno imposto alla società da esse dominata.
Così, uomini e donne finiscono per assorbire, pur soffrendo,
la mentalità che consente ai loro dominatori di continuare... a
dominarli!4
A
proposito infatti della coscienza,
Marx ed Engels affermano: “Anche questa non esiste fin dall'inizio,
come 'pura coscienza.'” Lo stesso linguaggio, del resto: “E'
antico quanto la coscienza, il linguaggio è la
coscienza reale, pratica, che esiste anche per gli altri uomini e che
dunque è la sola esistente anche per me stesso, e il linguaggio,
come la coscienza, sorge soltanto dal bisogno, dalla necessità di
rapporti con altri uomini.” Così: “La coscienza è dunque fin
dall'inizio un prodotto sociale e tale resta fin tanto che in genere
esistono uomini.”5
Un
prodotto sociale:
qualcosa che quindi nasce in società, ma in una società che è
fortemente controllata da chi controlla integralmente. Se
così non fosse, il dominato si
ribellerebbe; invece soffre ma pensa: è stato così da sempre, ma
perfino una vita come la mia è in fondo naturale anzi giusta.
Poi come non pensarla così quando fin da bambini si deve assorbire
la mentalità che il dominatore spaccia
per vera? Diritto,
religione, filosofia, informazione ecc. ribadiscono continuamente
questo concetto; certo non giustificano la ribellione.
Fino
allo scoppio della Rivoluzione francese, la struttura della società
e la sua ideologia di fondo sancivano (non solo in Francia) la
“legittimità” di una separazione netta tra alcuni e
pochi che avevano ogni
diritto, agio, lusso ecc. e
moltitudini che non ne
avevano nessuno. Sul
versante quindi dei rapporti di forza dice
bene il Le Goff quando sostiene (in modo solo apparentemente
paradossale) che il Medioevo non finì nel 1492 ma proseguì fino
all''800.6
Nel
Medioevo, tutto ciò riposava sul: “Revival
dell'antichissima dottrina dei
tre ordini: la società umana divisa in tre schiere, coloro che
pregano, coloro che combattono e quelli, la maggior parte, che
faticano lavorando la terra. Ripartizione che affonda le radici in
tempi lontanissimi, all'origine della civiltà indo-europea e ripete
la scansione famosa di Platone nella sua Repubblica;
nell'XI secolo il vescovo Adalberone di Laon la riconferma a sostegno
e struttura portante della monarchia.”7
Dalla
rivoluzione industriale ad oggi, a “coloro che pregano” ed alla
teologia subentrano i magnati di industria, economia e finanza, ma la
struttura di fondo rimane in effetti immutata. L'agricoltura è in
buona parte sostituita da attività lavorative più complesse
(industria pesante, peraltro presto ultra-tecnologizzata,
informatica, servizi ecc.) ma la subordinazione del lavoratore
salariato rimane dura, benché un po' tutelata dall'ambito giuridico.
Si dirà: ma
dato questo dominio, allora come mai sono scoppiate e scoppiano
rivolte e rivoluzioni? Esso avrebbe dovuto rendere la ribellione
impossibile.
La risposta
è che l'uomo non è una macchina o un bruto. Come diceva Gramsci:
“L'uomo è soprattutto spirito, cioè creazione storica,
e non natura.”8 L'uomo, insomma, non subisce passivamente la
sua condizione ma nel tempo sa prendere coscienza della
sua situazione e può lavorare per modificarla.
Certo, questo processo non è facile né automatico: perché il punto è acquisire “coscienza del proprio valore.”9 E l'acquisto di tale coscienza è sempre stato ostacolato da chi ha tutto l'interesse a mantenere le masse in condizioni di non-coscienza.
Certo, questo processo non è facile né automatico: perché il punto è acquisire “coscienza del proprio valore.”9 E l'acquisto di tale coscienza è sempre stato ostacolato da chi ha tutto l'interesse a mantenere le masse in condizioni di non-coscienza.
Il giro è
stato molto lungo ma penso che si sia capito perché Gramsci
denunciasse la sommarietà del pensiero di Bucharin: non vedere
quanto nel pensiero altrui possa esservi o esservi stato di positivo,
conduce ad una del tutto infondata autocelebrazione e ad abbandonare
un pensiero realmente dialettico.
Comunque:
“Che i sistemi filosofici passati siano stati superati non
esclude che essi siano stati validi storicamente e abbiano
svolto una funzione necessaria: la loro caducità è da considerare
da un punto di vista dell'intero svolgimento storico e della
dialettica reale; che essi fossero degni di cadere non è un
giudizio morale o di igiene del pensiero emesso da un punto di vista
'obiettivo', ma un giudizio dialettico-storico.”10
Vediamo
quindi come nella discussione filosofica abbiano pieno diritto di
cittadinanza anche filosofie da noi lontane; il che, beninteso, non
significa approvarle o accoglierle a priori. La filosofia non
esclude dunque lo scontro ma non si limita a tale ambito.
Inoltre,
dall'ambito in questione dobbiamo escludere attacchi ad personam.
Qui penso allo sconcertante attacco portato da Roscellino al suo
vecchio allievo Abelardo che (in quanto segnato dalla tragica
esperienza dell'evirazione) dovette leggere quanto segue: “Tolta
quella parte che ti rendeva uomo tu non devi più esser chiamato
Pietro ma 'quasi Pietro'.”11
Ma vedo che
circa il problema del primo pericolo cioè l'eccesso di
critica non potrò concludere neanche stavolta. Alla prossima.
Note
*
Ho pubblicato su questo blog le precedenti parti di questo post
rispettivamente: la 1/a il 25 /03/2008; la 2/a il 4/4/2008; la 3/a il
17/6/2010; la 4/a l’11/10/2011, la 5/a il 27/11/2011;
La
6/a il 15/11/2012; la 7/a l'8/12/2012.
Il
riepilogo di questo post (sino alla 7/a parte) è stato pubblicato il
21/02/2013.
Ho pubblicato l'8/a parte il 20/03/2013 e la 9/a il 14/09/2013; la 10/a il 5/10/2013, l'11/a il 30/10/2013, la 12/a il 16/11/213.
Ho pubblicato l'8/a parte il 20/03/2013 e la 9/a il 14/09/2013; la 10/a il 5/10/2013, l'11/a il 30/10/2013, la 12/a il 16/11/213.
Il
riepilogo di questo post (dall'8/a all'11/a parte) è stato
pubblicato il 13/12/2013.
La
13/a parte è stata pubblicata il 19/01/2014 e la 14/a l'8/02/2014.
1
Antonio Gramsci, Quaderni del carcere,
Edizione critica dell'Istituto Gramsci,, a cura di Valentino
Gerratana, Einaudi, Torino, 2007, p.1417.
2
“La storia mondiale, lo sappiamo, è dunque in generale
l'esposizione dello spirito.” G.W. F. Hegel, Lezioni
sulla filosofia della storia,
Laterza, Roma-Bari, 2003,
p.64.
3 Karl Marx,
Prefazione a Per la critica dell'economia politica, Edizioni Lotta
comunista, Milano, pp.16-17.
4 K. Marx
Friedrich Engels, L'ideologia tedesca, Editori Riuniti, Roma,
1958, pp.43-44 sgg.
5 K. Marx F.
Engels, L'ideologia tedesca, op. cit., pp.26-27. Il corsivo è
degli AA.
6 Jacques Le
Goff, Intervista sulla storia, a cura di Francesco Maiello,
Mondadori “Oscar”, Laterza, Roma-Bari, pp.81-85.
7
Maria Teresa F. B. Brocchieri, Eloisa e Abelardo, Mondadori
“Oscar”, Milano, 1987, p.149. In
inglese
nel
testo.
8
A. Gramsci, Socialismo
e cultura, in
Id., Le
opere. Antologia,
a cura di Antonio A. Santucci, Editori
Riuniti/l'Unità, Roma, 2007, p.14.
I corsivi sono miei.
9
A. Gramsci, Socialismo
e cultura, op. cit., p.14. Il
corsivo è mio.
10
Id., Quaderni
del carcere, op. cit., p.1417.
Corsivo dell'A. Sui gravi limiti di Bucharin (il che non significa
certo giustificare il suo carnefice Stalin) già Lenin trovava che
“le sue concezioni teoriche solo con grandissima perplessità
possono essere considerate pienamente marxiste, perché in lui vi è
qualcosa di scolastico (egli non ha mai appreso e, penso, mai
compreso pienamente la dialettica).” Vladimir Ilic Lenin, “Le
tesi di aprile e il testamento, Edizioni Alegre, Roma, 2006,
pp.34-35.
11
Maria Teresa F. B. Brocchieri, Storia
della filosofia medievale, Laterza, Roma-Bari, 1989, p.173.
venerdì 14 febbraio 2014
Cinema: ieri ed oggi
Per me un bel film ti accompagna
anche dopo averlo visto.
Sì, forse
possiamo dir questo anche dopo aver ascoltato un certo disco, gruppo
o dopo aver letto un buon libro.
Probabilmente
possiamo fare un discorso simile anche per la filosofia.
Ma
sempre secondo me, il cinema ed un bel film ci
accompagnano con più forza e persuasione.
Forse perché quel
determinato film ci trasmette
l'illusione della
vita, i personaggi che si muovono sullo schermo sembra che si trovino
nella vita reale, i loro sentimenti e le loro passioni acquistano un
rilievo che supera la
finzione. In apparenza,
certo: perché un film non è la vita reale.
D'altronde
non lo è neanche un romanzo come Delitto e castigo di
Dostoevskij... eppure sembra che da quelle pagine Raskolnikov possa
saltar fuori da un momento all'altro: magari con la scure da cui
gocciola il sangue dell'usuraia e quello di sua sorella!
Che per il
suo Shining Kubrick si
sia ispirato proprio all'eroe dostoevskiano?
Comunque
il cinema (e l'arte in generale) ci sembra reale quando
è verosimile:
insomma, tutto deve esser rappresentato in modo naturale...
Ricordate
gli sketches che ironizzavano sulla frase: “Mangia
qualcosa, Pedro; Pedro, perché non mangi qualcosa?”
Ora, talvolta
diciamo anche noi al Pedro (o al Mario, alla Lucia ecc.) frasi
simili; la situazione è abbastanza frequente. Situazione che forse
qualcuno vorrebbe risolvere ficcando in bocca a Pedro un imbuto per
nutrirlo a forza, ma questo è un altro discorso.
Il
nostro discorso è
convincere quell'ingrato di Pedro, Tom o Karl a mangiare... facendo
sembrare quell'invito del tutto naturale. Antonio, Mary, Jean-Claude
e Suzie Wong sono davvero preoccupati per
il deperimento organico di questo maledettissimo Pedro, accidenti a
lui!
Ma perchè non mangia, ma che
ha?! Frank ha cucinato per lui
tutto il santo giorno, non è neanche andato a Wall Street per
giocare in Borsa... ed aveva anche lo zainetto nuovo! Ma
che mangi almeno le crocchette di patate cucinategli dalla nonna di
Luca Brasi, dopo tutta la fatica che ha fatto per ottenere un'ora di
permesso dal Padrino...
Insomma, avete
capito. Ora andiamo avanti.
Ah, ma prima
ringrazio: Antonio Banderas, Jean-Claude Van Damme, Tom Cruise, Suzie
Wong, Luca Brasi, sua nonna, il Padrino, Kubrick e Jack Nicholson: un
po' d'educazione, altrimenti dove andiamo a finire?
Bene, secondo
me al cinema è molto importante la sala. Sì, ormai esistono
le multisale. Eppure datemi pure del vecchiaccio romantico, ma a
me le sale d'una volta piacevano! Certo, spesso i sedili erano in
legno e dovevano risalire agli anni '40 o '50; le poltrone delle
multisale sono molto più comode.
Quei sedili
non erano (come le poltrone multisaliche) sistemate in ordine
decrescente: bastava che davanti a te sedesse una persona leggermente
più alta di una spiga nana, perché il film te lo dovessi
letteralmente sognare.
Spesso la
gente fumava oppure entrava in sala a film già iniziato, talvolta i
bagni erano come le latrine della fanteria di Attila.
Ma
quelle sale
presentavano anche dei vantaggi: si faceva la sosta tra il 1° ed il
2° tempo, durante la quale potevi andare in bagno e/o portarci i
bambini, bere o mangiare qualcosa, sgranchirti le gambe e scambiare
con la bella o con gli amici un parere sul film.
Finita
la proiezione, potevi restare in sala a rivedere il
film tutte le volte che volevi. Tanti artisti hanno trovato la loro
strada proprio in certe vecchie, scalcinatissime sale.
So che ora mi
domanderete: “Ma tu rivorresti quelle sale?”
Be', di questo
riparleremo... sapete, ho Pedro che sta litigando con Ratatouille per
una questione di melanzane: non vorrei che ci scappasse il morto! Ed
un topo morto, benché cuoco, non sarebbe esattamente il massimo.
Alla prossima!
sabato 8 febbraio 2014
La discussione filosofica (14/a parte)
Ecco quali sono per me i due
“grandissimi pericoli” cui accennavo nella 13/a parte; si tratta
di pericoli tra loro molto diversi ma che in fondo sortiscono lo
stesso effetto.
Il primo:
l'eccesso di critica.
Il secondo:
non l'assoluta mancanza di
critica quanto una radicale sfiducia verso
la filosofia. Così non è che alcuni decidano di non
esercitare più il proprio senso
critico; lo esercitano... ma contro la filosofia.
Tuttavia,
come abbiamo visto nella 12/a parte, questo non è possibile né
desiderabile: equivale a filosofare sul rifiuto della
filosofia e del ragionamento in generale... che significa comunque
filosofare.
Spesso
si ritiene che in filosofia si proceda polemizzando con tutti,
talvolta anche denigrandoli; oppure esaltando sé stessi.
Come abbiamo visto nella 1/a parte, spesso questo errore è stato
commesso anche da grandi filosofi.
Per
me, qui scattano motivazioni legate più che al ragionamento,
a questioni di tipo personale, di carriera o anche volgarmente
economiche. Il caso delle invettive lanciate da Schopenhauer
(alle cui lezioni per molto
tempo non assisteva quasi nessuno) verso Hegel ed il suo sistema è
tipico... né purtroppo, isolato.1
Il
pericolo consistente in tale eccesso di
critica (spesso non sostenuto da validi contro-ragionamenti) trova
uno dei suoi esempi più eclatanti per es. nel XII secolo, nel modo
in cui S. Bernardo attaccò
Abelardo. Bernardo, infatti,
scrisse: “Noi siamo come guerrieri che
vivono accampati sotto una tenda o cercando di conquistare il cielo
con la violenza.”2
Ora,
per un uomo che aveva questa visione
della vita religiosa e dell'attività filosofica, con l'avversario
non si discuteva: lo si schiacciava. Circa poi chi leggesse opere di
Abelardo come la Teologia ed
il Conosci te stesso,
Bernardo sentenzia: “Sia chiusa per sempre la bocca di
chi parla male.”3
In
una visione sul piano letterario peraltro piuttosto suggestiva,
Bernardo definisce un allievo di Abelardo come Arnaldo da Brescia,
suo “armigero” ed inoltre “serpente”
che appunto ad Abelardo “si unisce squama a squama”4
C'è in effetti qualcosa di inquietante ma che colpisce, stimola la
fantasia nell'immagine di questo bi-uomo
che per la ”pretesa” di spiegare in termini umani quelle che
Bernardo chiama “le cose divine”, finisce per essere abbassato
dal suo avversario alla condizione del rettile...
animale spregevole che spregevolmente striscia per terra, si confonde
nello sporco o comunque si nasconde per poi attaccare.
Del
resto, fin dal libro della Genesi il
Serpente rappresenta
il Diavolo: quello che
stando alla tradizione cristiana ed all'etimo greco sarebbe il
Diàbolos cioè il
calunniatore. Il
Malvagio, colui che accusa su
basi del tutto false sia Dio che l'uomo.
Ed
a chi parla così si può forse rispondere? Mai! Infatti Bernardo
tuona: “Non sarebbe più giusto colpire e frustare una
bocca che parla così, piuttosto
che ribattere con argomenti?5
Inoltre,
la tradizione ebraica vede in Satana colui
che: “Compie tre funzioni: seduce gli uomini, li accusa dinanzi a
Dio, e infligge la pena di morte”; altra sua funzione consiste nel
“seminare discordia sulla terra.”6
Ora,
per Bernardo, un uomo che come Abelardo era dotato di “diabolica”
abilità nell'arte della discussione, incarnava in pieno
il perverso ideale satanico. Dal punto di vista di Bernardo si poteva
anche affermare che la filosofia di Abelardo seminasse intollerabile spirito di
divisione, di discordia ecc..; ragionare equivaleva per l'avversario del Bretone a
sragionare... o a
bestemmiare.
Infatti
nella sua Etica Abelardo
contestava alla Chiesa il diritto di “sciogliere e legare” (cioè
assolvere e condannare) dai peccati; in fondo, egli contestava anche
il diritto di ricorrere essa alla scomunica.
Per Abelardo la Chiesa aveva
quei diritti solo a patto che i prelati fossero dotati di specchiate
qualità morali e religiose.7
Certo
qui il Nostro si manteneva su un terreno prevalentemente
filosofico-teologico. Ma il suo allievo Arnaldo da Brescia trasse
dagli insegnamenti del maestro conseguenze anche politiche
se dichiarò con nettezza: ”I chierici che
hanno proprietà, i vescovi che hanno diritti sulle cose (regalia),
i monaci che posseggono la terra non possono salvarsi.”8
Fautore
di una Chiesa povera per i poveri, Arnaldo “abate a Brescia aveva
sollevato il popolo contro il vescovo corrotto.”9 Ed a Roma, dove
sostenne con forza un movimento popolare-comunale che si opponeva al
papa, fu condannato a morte (1155). La motivazione ufficiale della
condanna fu l'esser stato egli ereticus10
ma a mio avviso i reali motivi
furono più che di tipo teologico o religioso, di tipo invece
politico-sociale.
Insomma,
da quanto detto sinora emerge come talvolta, nella discussione
filosofica alcuni puntino a
demonizzare l'avversario. E' quel che Gramsci scorgeva e denunciava
nel Manuale di sociologia popolare di
Bucharin: “Nel Saggio si
giudica il passato come 'irrazionale' e 'mostruoso' e la storia della
filosofia diventa un trattato di teratologia.”11
Teratologia significa
“discorso sui mostri”: l'avversario filosofico diventa così un
essere a cui per definizione non
si può né si deve dar credito; coi mostri non si discute, semmai li
si scaccia. Tutto ciò che non rientra nella nostra
filosofia è così
tranquillamente scartato perché considerato al di fuori di qualsiasi
dimensione sociale e razionale.
Ovviamente
questa soluzione è molto comoda perché ci esenta dalla fatica del
ragionamento! Ma tale “soluzione” fa sprofondare anche noi nel
pericolo della teratologia;
non ragionando, infatti, diventiamo noi stessi gli
ipotetici mostri che
condannavamo.
C'è
ancora molto altro da dire sia per quanto riguarda il 1°
pericolo (eccesso di
critica) sia per quanto riguarda il 2° (assoluta
mancanza); ma non vorrei mettere
troppa carne al fuoco. Alla prossima, quindi. Volta, non carne.
Note
1
Sul “caso” Hegel-Schopenhauer cfr. la 1/a parte della presente
Discussione dove
ricordo che il 2° definì il pensiero hegeliano “una buffonata
filosofica”; soprattutto cfr. Nicola Abbagnano, Storia
della filosofia, Utet, Torino, 1979, vol. III, p.141.
2
Maria Teresa Fumagalli Beonio Brocchieri, Eloisa e
Abelardo, Mondadori
“Oscar”, Milano, 1987, p.167.
I corsivi sono miei.
3
Maria Teresa F. B. Brocchieri, Eloisa e Abelardo, op.
cit., p.168.
Il corsivo è mio.
4
Id., Storia della filosofia medievale. Da Boezio a Wyclif,
Laterza, Roma-Bari, 1989, p.190.
I corsivi sono miei.
5
Id., Eloisa e Abelardo, op.
cit., p.177.
Il corsivo è mio.
6
Dr. A. Cohen, Il Talmud (1935),
Laterza, Bari, 1989, p.86.
7
Pietro Abelardo, Etica o conosci te stesso, La Nuova
Italia, Firenze, 1976, pp.107-121
e spec. pp.112-113.
8
Maria Teresa Fumagalli Beonio Brocchieri, Storia della
filosofia medievale, op.
cit., p.191.
In latino nel testo.
9
Ibid., p.190.
10
Ibid, p.191.
11
Antonio Gramsci, Quaderni del carcere (1975),
Edizione critica dell'Istituto
Gramsci, a cura di Valentino Gerratana, Einaudi, Torino,
2007, p.1417.
sabato 25 gennaio 2014
“America 1929: sterminateli senza pietà”, di Martin Scorsese
Uno dei primi films di Scorsese.
Protagonisti: Barbara Hershey, David Corradine e suo padre John. Il
film è liberamente tratto dall'autobiografia di Bertha Thompson,
Sister of the road (sorella
della strada), però Scorsese ha saputo trarre dal libro un gran
bel film. Egli ha infatti colto
benissimo lo spirito irrequieto di Bertha, che non era una semplice
vagabonda bensì una donna curiosa, intelligente ed appassionata.
Figura
centrale è naturalmente Bertha (la Herhey): la sua sensualità,
unita alla sua iniziale ingenuità, l'esser lei anche guardinga ma
più spesso pronta a lasciarsi andare alla corrente della vita,
magari con una franca risata, la sua innocenza anche nel crimine,
l'amore incondizionato per Bill (D. Corradine) oltre che per i
lavoratori... be', tutto questo fa di lei una figura unica.
In
questo film (sebbene ambientato durante la Grande Depressione del
'29) la Hershey mi ha ricordato molte delle ragazze degli anni '70:
scanzonate & anche
naif ma pronte a prendere fuoco
di fronte all'ingiustizia. Del resto, sebbene il libro della Thompson
sia del '37, ha forse anticipato alcuni temi degli anni '60-'70.
Accanto a
Bertha-Barbara abbiamo anche un'altra grande figura, quella di Big
Bill Shelly (D. Corradine): sindacalista rivoluzionario che viene suo
malgrado coinvolto in una serie di rapine. Bill non è fatto per
quella vita: ma risulta difficile uscirne, quando alle calcagna hai
la polizia e le guardie del padrone della ferrovia (il miliardario
Sartoris, J. Corradine).
Inoltre,
Bill viene cacciato proprio dal suo sindacato. Così, dopo essersi
bruciato tutti i ponti alle spalle e consapevole che le sole
alternative a quella vita sono
costituite dalla sedia elettrica, dall'essere ucciso dai poliziotti o
dagli sgherri di Sartoris, Bill non può che continuare...
Però lui
(versione americana di Robin Hood) e la sua banda rubano solo ai
ricchi e destinano agli operai parte del bottino.
Rubano poi a
Sartoris, uomo che usa il pugno di ferro coi lavoratori... fino a
farli prendere a fucilate e ad incendiare le loro povere tende o
baracche.
Risulta
così a suo modo divertente
la scena della rapina in casa Sartoris, con una Bertha mozzafiato che
pistola in pugno, fasciata in un elegante vestito rosso e con uno
smagliante sorriso si rivolge così a Sartoris e ad i suoi amici
miliardari: “Volevo... volevo dirvi che questa è una
rapina, ma se vi metterete contro il muro ci eviterete la fatica di
spararvi.”
Scorsese
non si limita a rappresentare rapine, assalti armati ai treni,
sparatorie ecc. No, quelli sono gli elementi necessari del film,
quelle sono le cose che una banda fa.
Ma insieme a
quegli elementi troviamo anche quello sociale o sociologico: il
razzismo, le lotte e gli scioperi dei ferrovieri, la crisi economica,
lo sfruttamento della prostituzione, la diffusione a tutti i livelli
del gioco d'azzardo, l'alcolismo...
Poi, la storia
d'amore di Bertha e Bill, benché si svolga tra una rapina e l'altra
ed abbia come “luoghi” treni merci e case diroccate, è
rappresentata mantenendo un certo equilibrio tra loro tenerezza e la
loro (spesso incosciente) passione. Anche in questo la Hershey e
Corradine riescono benissimo.
Comunque il
film scorre alla grande, con in sottofondo una colonna sonora blues;
blues eseguito però senza strumenti elettrici: solo voce, chitarra
acustica ed armonica. Troviamo soltanto un rock, del resto necessario
in un momento piuttosto drammatico del film.
Mi
fermo qui perché come faccio spesso quando parlo di cinema, vorrei
darvi un'idea, spero
stuzzicante dei films che commento; ma vi assicuro che quello che non
vi ho detto è molto più
stimolante...
Iscriviti a:
Post (Atom)