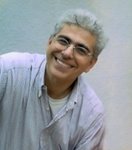Il 14 luglio 1789 il popolo di Parigi in rivolta attaccò e prese la Bastiglia, fortezza e carcere che considerava luogo-simbolo della tirannide e dell’oppressione.
Quello che vedete è il quadro del pittore Eugéne Delacroix
La libertà che guida il popolo. La libertà, noterete, è una donna dal portamento fiero e che come la stessa
giustizia non teme di scoprirsi.
Anzi, penso che attraverso questo scoprire sé stessa, la libertà (quella vera cioè quella che vuol essere
per tutti) aiuti a scoprire l’io, la dignità e la coscienza di chi crede d’essere destinato ad una vita di sottomissione.
La libertà, come la verità non teme di mostrarsi com’è: chi deve temere e vergognarsi è solo chi intende soffocarle.
Per Gramsci: “La verità deve essere rispettata sempre, qualsiasi conseguenza possa apportare, e le proprie convinzioni, se sono fede viva, devono trovare in se stesse, nella propria logica, la giustificazione degli atti che si ritiene necessario siano compiti.”
Ed aggiungeva: “Sulla bugia, sulla falsificazione facilona non si costruiscono che castelli di vento, che altre bugie e altre falsificazioni possono far svanire” (A. Gramsci,
La conferenza e la verità,
L’Avanti!, 19/02/16).
La verità si mostra insomma
nuda: così come la
giustizia, che se non è per tutti è solo per pochi privilegiati; ma allora si chiama
ingiustizia.
Tutti gli aristocratici del ‘700 consideravano segno di depravazione morale o di confusione mentale i discorsi che tendevano alla diffusione di leggi universali; ironizzavano sui “presunti diritti dell’uomo”...
Perché per loro pensare che
tutti avessero
uguali diritti significava procedere “dispoticamente” contro “tutti i privilegi e le libertà particolari” (Domenico Losurdo,
Il revisionismo storico. Problemi e miti, Laterza, Bari, 1996, pp.41-42).
Era quindi quello il problema: i
privilegi. Nessuna complessa questione filosofica, morale, teologica o giuridica ma solo i privilegi che fruttavano ai nobili ricchezze ed impunità di fronte alla legge.
Cioran in
Squartamento cita la lettera di un nobile che si era impadronito del cadavere di un artigiano e che sulla base di tale
possesso ne reclamava l’eredità…
contro gli eredi. Questo abuso/orrore doveva rientrare in una dimensione sancita dal
diritto, o il reclamo non sarebbe neanche stato concepito.
Vediamo quanto scrisse, con tono diabolicamente divertito certa Madame de Sevigné. In seguito ad una rivolta popolare scoppiata in Bretagna e repressa per Tocqueville “con un’atrocità senza esempio”, furono infatti prese misure che dalla sfera militare sconfinarono in quella sadica.
Madame, certo graziosamente elegante, profumatissima e dai modi impeccabili, scrive: “Si è cacciato e bandito tutto un quartiere, e proibito di riceverne gli abitanti sotto pena della vita; così si vedevano
tutti questi miserabili, donne incinte, vecchi, bambini, errare piangendo all’uscita della città, senza sapere dove andare,
senza avere cibo né riparo.”
Madame accenna
en passant ad un “imbecille” che considera responsabile di un “tumulto” e che “venne
squartato, e i suoi quarti esposti ai quattro angoli della città. Una sessantina sono stati arrestati
e domani cominceranno a impiccarli” (D. Losurdo,
op.cit., p.63).
I resti del corpo di un uomo fatto a pezzi sono definiti
quarti; come i quarti di
bue. L’essere umano se appartenente al popolo, abbassato alla dimensione
animale… Passibile, per la nobiltà francese, solo di divertito disprezzo. Lo
spettacolo dello squartamento, una sadica gioia di cui godere come antidoto, forse, alla monotonia della vita di corte.
M.me osserva con
nonchalance che “ora non siamo
tanto arrotati,
appena uno in otto giorni, per far funzionare la giustizia. E’ vero che
l’impiccagione è in ripresa…” (D. Losurdo,
op. cit.,
pp.63-64).
Si noti quel “non
siamo tanto arrotati”, questo apparente porsi tra le vittime della spietata repressione; forse per sbeffeggiare meglio l’insieme delle crudeltà loro riservato. E si noti la pena dell’impiccagione definita
in ripresa, come se si trattasse delle azioni di una società commerciale…